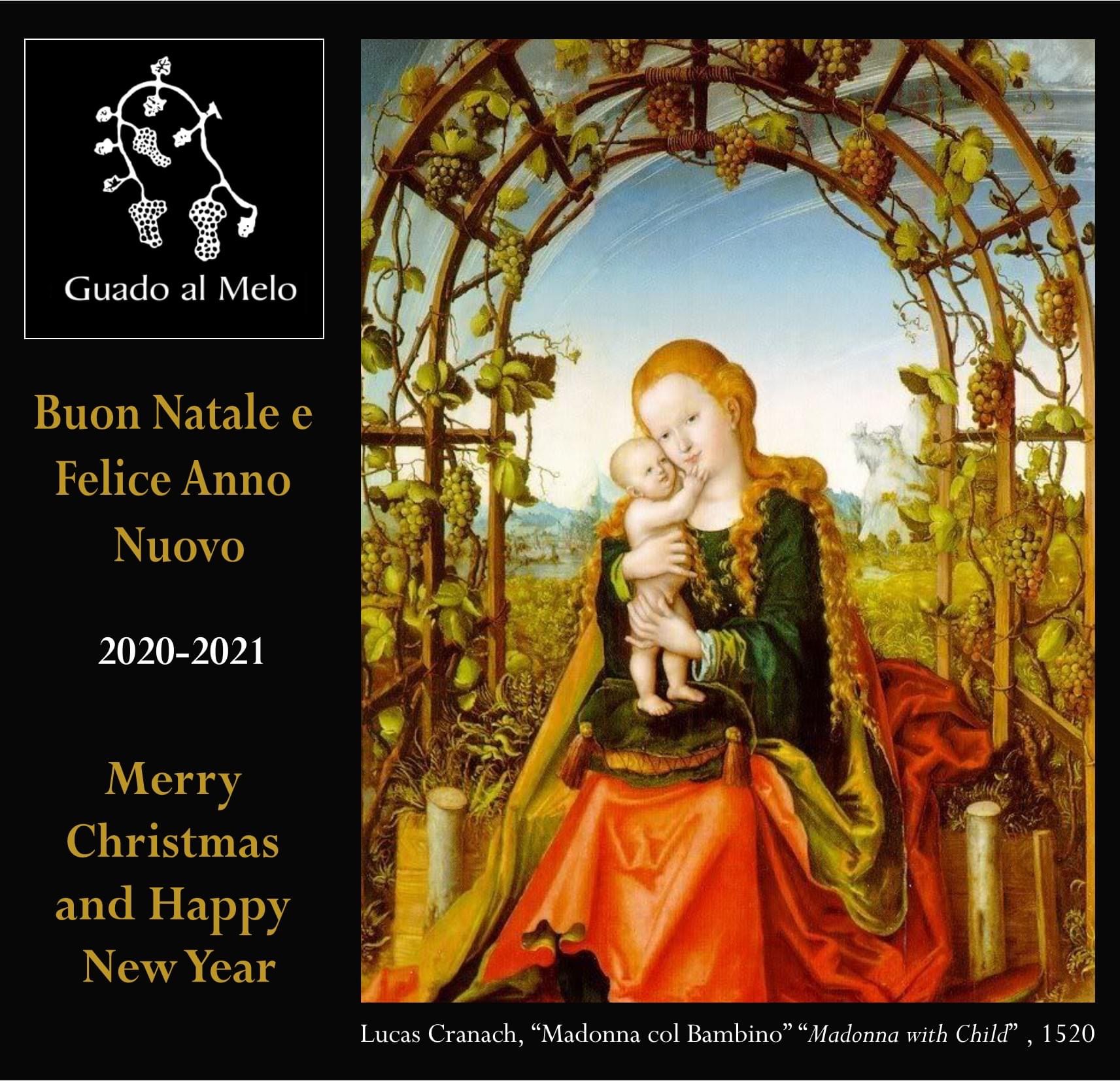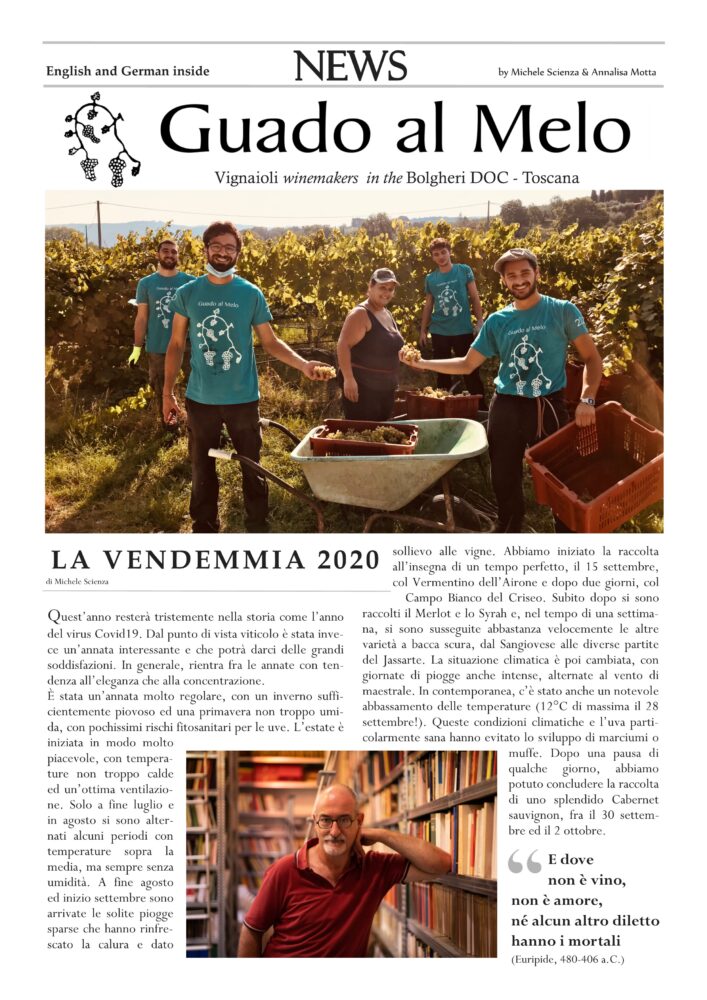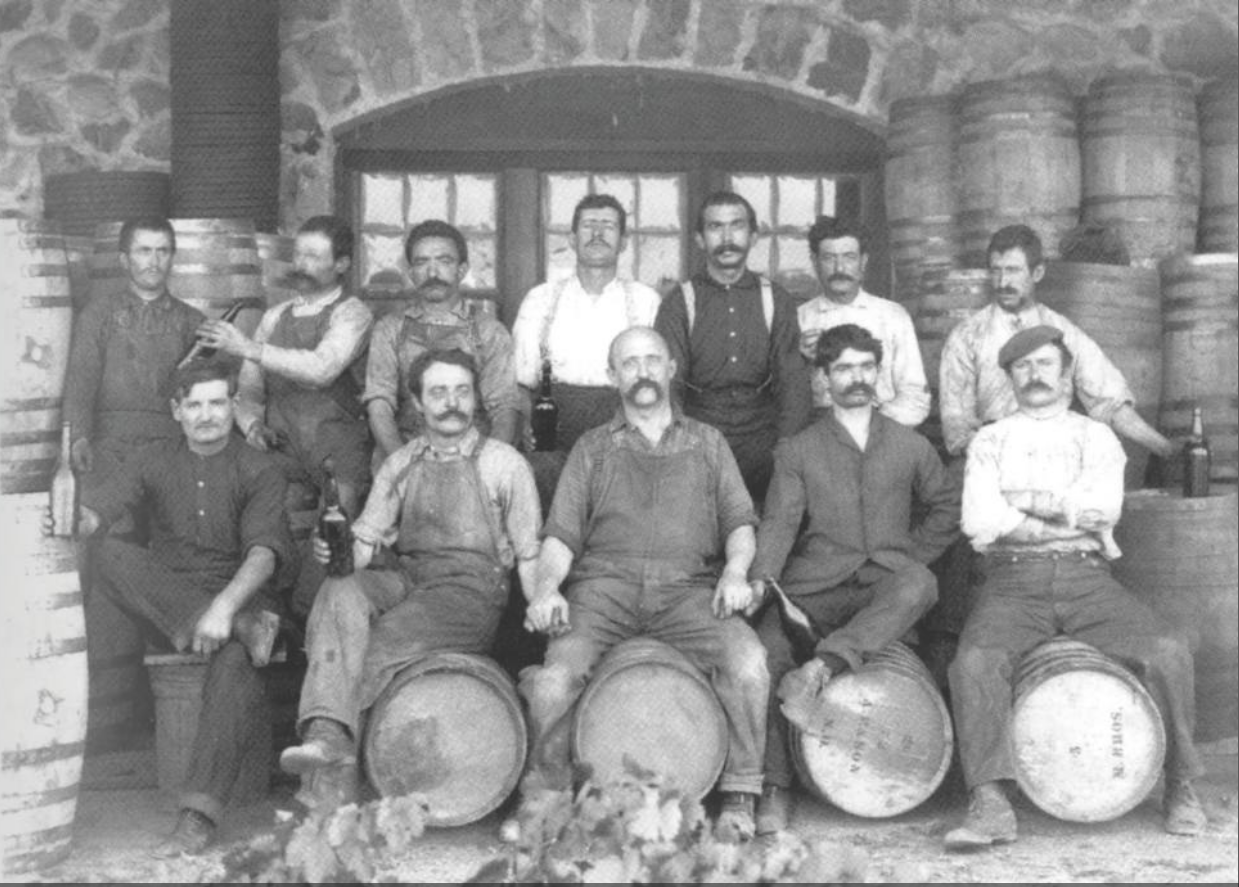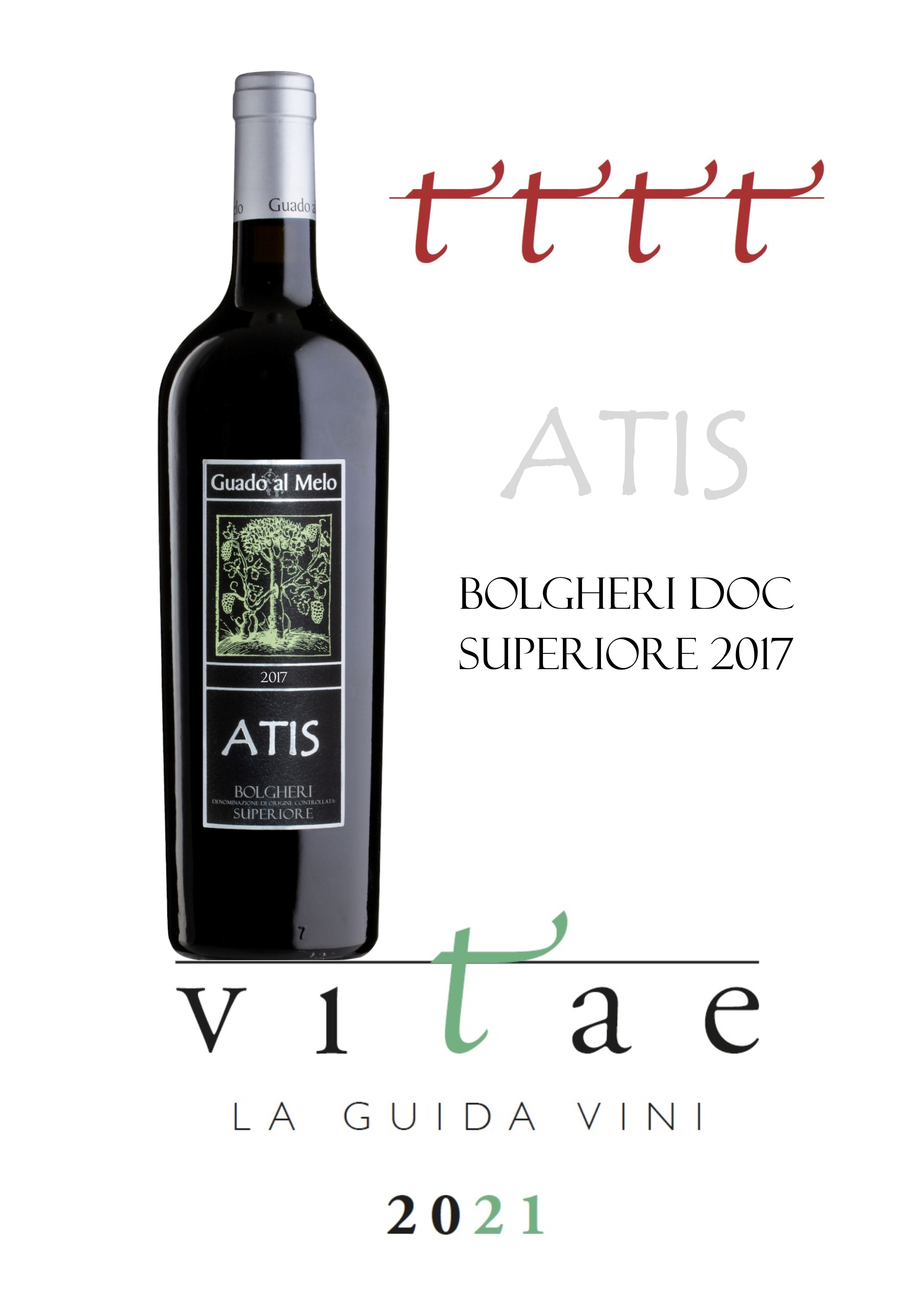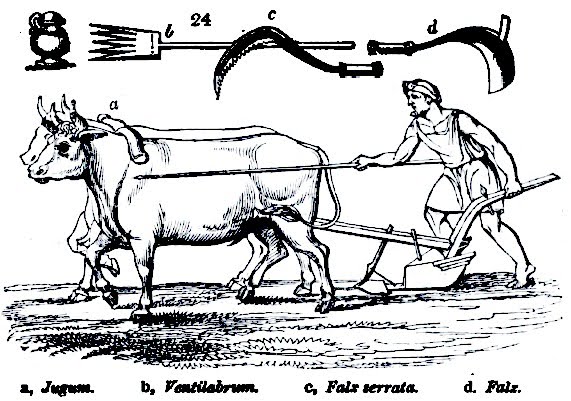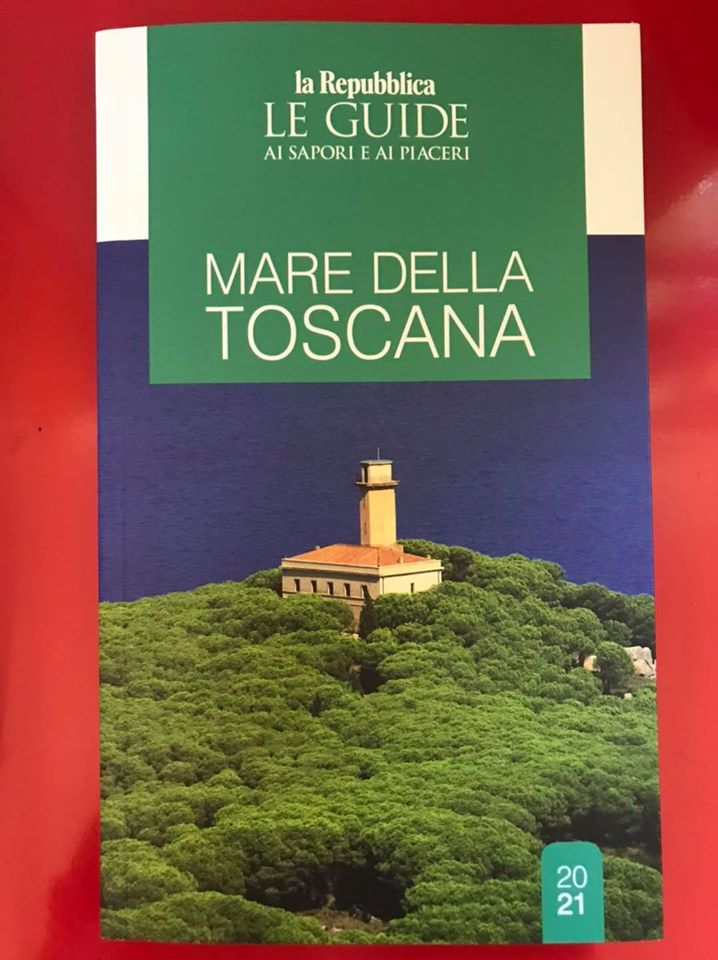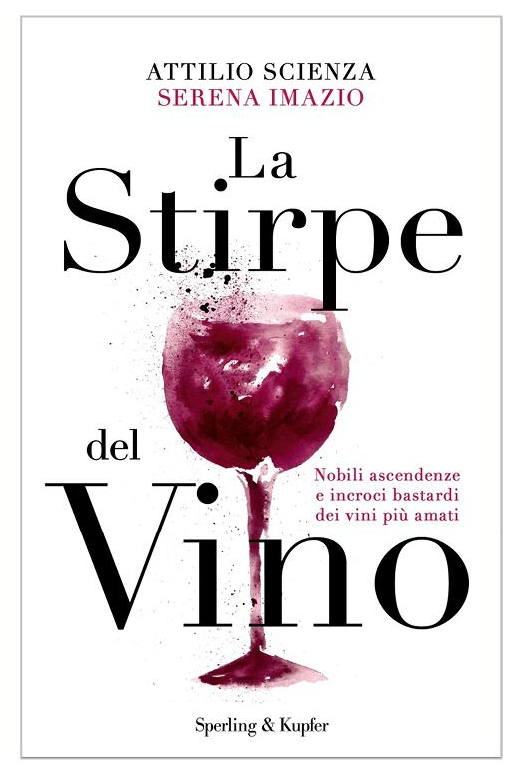Agroecologia in vigna e consociazioni vegetali, il nostro presente e futuro
Chi visita le nostre vigne (ed il nostro territorio in generale) rimane particolarmente colpito dal trovare un ambiente per molti versi ancora incontaminato. Rimangono impressionati dalle nostre vigne inerbite, con particelle non troppo estese, alternate a filari di ulivi, alberi da frutto e siepi, confinanti col bosco. Questa situazione è particolarmente diffusa in tutta la nostra DOC Bolgheri.
Questo modo di gestire la vigna, integrata perfettamente nell'ambiente ed in consociazione con altre specie vegetali, è frutto di una tradizione antica e di precise scelte agronomiche ed ambientali, che nascono da studi di agroecologia.
[one_second][info_box title="Cos'è l'agroecologia" image="" animate=""]L’agroecologia nasce dalla fusione di due ambiti che possono sembrare, in un primo tempo, molto distanti: agricoltura ed ecologia. L’ecologia si occupa di capire l'intricato insieme di rapporti che un essere vivente instaura con l’ambiente in cui vive e con gli altri esseri viventi che lo popolano. L’agroecologia applica questo approccio ad un particolarissimo ecosistema, quello domesticato e gestito dall’uomo, l’agro-ecosistema.
L'agroecologia è nata come una scienza che studia questi aspetti, in modo interdisciplinare, negli anni '60 circa. In America Latina ha assunto anche i connotati di un movimento politico, integrando al suo interno tutta la gestione del sistema alimentare umano.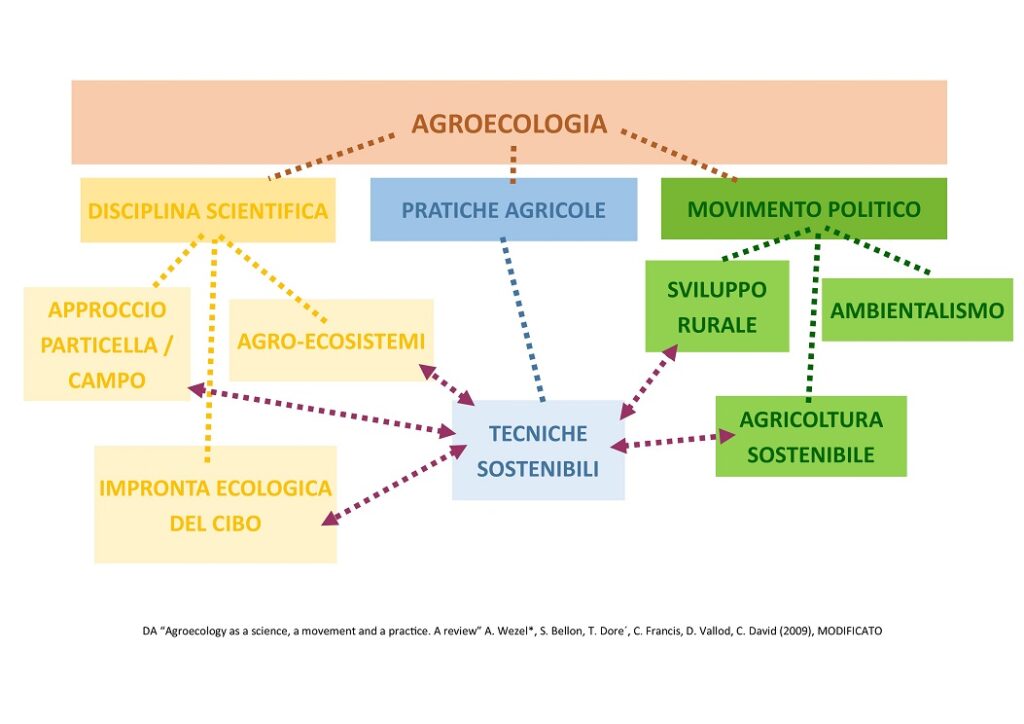
Per quanto riguarda la viticultura, l’agroecologia è uno dei concetti chiave in una gestione sostenibile. In particolare, riguarda l'integrazione della vigna nell'ambiente di contorno e la preservazione della biodiversità in essa. Detto in altre parole, con una visione agro-ecologica, la vigna viene considerata come un ecosistema integrato, dove compaiono diversi soggetti che interagiscono fra di loro (viti, flora e fauna di contorno). Se gestititi in modo appropriato, questi possono trovare un equilibrio ottimale, sia per una migliore coltivazione che per preservare l’ambiente ed il paesaggio.

In questo articolo mi soffermo sulla consociazione della vite con altre specie vegetali, ma lo stesso succede col mondo animale. Ad esempio, è ormai stranota l'applicazione della lotta biologica, basata su alcuni insetti o acari che svolgono il loro ciclo vitale a spese di specie dannose per la vite. In questi ultimi decenni si stanno capendo sempre più anche le interazioni con organismi ancora più piccoli, come batteri e funghi. Molti sono dannosi, ma alcuni hanno invece funzioni di interscambio con la pianta, che portano a preziose associazioni simbiontiche (dove entrambi i partner ricavano qualcosa di utile). L'esempio più noto è quello delle micorrizie, funghi che colonizzano le radici della vite, sia all'esterno che all'interno, migliorando in modo significativo l'approvvigionamento di acqua e di nutrienti minerali, oltre che migliorando in generale la capacità fotosintetica. Gli studi più recenti si stanno concentrando sempre più anche sul microbiota che popola le foglie, cioè l'insieme delle popolazioni dei microorganismi che vivono questi spazi. Diversi di essi sembrano giocare un ruolo importante nel matenimento della sanità della pianta. Alcuni batteri hanno dimostrato di inibire o ritardare la crescita di funghi dannosi alla vite, per cui si sta anche cercando di mettere a punto delle applicazioni pratiche. [/info_box][/one_second]
Il paesaggio viticolo di tante zone mondiali è spesso ben diverso. Deriva da un'impostazione che è nata con l'era moderna della viticoltura, che tende ad isolare la vite il più possibile da ogni forma vivente: suolo nudo, grosse estensioni di vigneti, un uso eccessivo di fitofarmaci che quasi “sterilizzano” la vigna. Questo modello, che ha dominato per decenni, ha ormai mostrato tutti i suoi limiti.
Dall'essere considerata una scelta di nicchia, retaggio del passato o visione bucolica di campagnoli alternativi (come ci siamo sentiti anche dire!), la gestione agroecologica della vigna sta interessando sempre più il mondo vitivinicolo. Sempre più articoli e pubblicazioni suggellano questo sistema come un modello agronomico valido, che può rappresentare la migliore prospettiva per un futuro sempre più sostenibile della viticoltura.
La consociazione vegetale in vigna è parte integrante della nostra tradizione, anche se in molti territori questa impostazione è andata perduta. Nella millenaria storia delle vigne d’Italia, la viticoltura più comune era promiscua, con filari di viti alternate ad altre coltivazioni. Addirittura gli alberi erano il sostegno stesso delle viti. Vi ricordate la vite "maritata" all'albero di origine etrusco-romana, che è rimasta nelle campagne del centro-nord Italia fino a metà Novecento? (Ne ho parlato diverse volte, soprattutto qui e qui).
Il mio non vuole essere un discorso finto-ingenuo o passatista, del tipo che prima era meglio o altre cose simili. Sicuramente, l'epoca moderna della viticoltura ci ha fatto imparare tantissimo, ma ha avuto anche degli eccessi indiscutibili. Ormai abbiamo capito che la viticoltura deve essere sostenibile sotto tutti i punti di vista: non solo per una produzione ottimale ma anche per la tutela dell'ambiente e della nostra salute. Per arrivare a questo risultato, dobbiamo fare la migliore sintesi possibile fra le diverse vie, prendendo il meglio di ciascuna.
La ricerca sta dimostrando sempre più che la consociazione delle viti con altre specie vegetali contribuisce a migliorare diversi aspetti della viticoltura, nell'insieme di una gestione generale agronomica volta alla sostenibilità. Vediamo, in breve, i vantaggi principali.
L'aspetto positivo più immediato è quello paesaggistico. Al di là del fascino che possono avere le linee geometriche di estensioni enormi di monoculture, è sicuramente più bello ed appagante un paesaggio dove si alternano diversi elementi. La bellezza non è un fattore trascurabile, ci riempe occhi e cuore. Tuttavia, la consociazione non si ferma ad una bella cartolina ma dà vantaggi ancora più profondi, sia di naturale ambientale che agronomica, come ora vedremo.
Un ambiente ricco di specie vegetali diverse permette una maggiore preservazione della biodiversità e dell'ambiente. Oggi si parla tanto di biodiversità della vigna e dell'utilità della lotta biologica. Credo che sia facilmente intuibile che sia difficile però la permanenza di insetti o altri organismi utili in una monocultura, dove magari anche si eccede con l'uso di fitofarmaci. Un ambiente con numerose specie vegetali è molto più attrattivo. Presenta fioriture a scalare per tanti mesi, oltre che offre diversi habitat. La vigna in questo modo diventa anche un “corridoio verde”, che può essere percorso da piccoli animali, nei loro spostamenti fra boschi, macchie e cespugli.
La ricerca ha dimostrato come la presenza di alberi, arbusti ed erba influisce sul micro-clima della vigna. I cambi climatici stanno portando ad innalzamenti delle temperature medie, che stanno causando sempre più fenomeni di accellerazione delle maturazioni delle uve. Diventano sempre più frequenti anche eventi meteoreologici estremi, come precipitazioni torrenziali, siccità accentuata, ecc. La presenta di vegetazione non è certo risolutiva, ma migliora diverse situazioni. Ad esempio, siepi ed alberi possono essere d’ostacolo al vento. La presenza di una ricca vegetazione migliora l’idrometria locale, grazie alla traspirazione-evaporazione delle foglie. Diminuiscono anche gli effetti delle gelate. Negli ambienti più caldi, invece, una parziale ombreggiatura contrasta gli stress dovuti ad eccessi termici e di irraggiamento solare, ...
Migliora la qualità del suolo: alberi, arbusti e copertura erbosa influiscono in modo importante con la loro massa radicale. Determinano un aumento della materia organica e dell’attività biologica della rizosfera. Uno dei problemi più importanti del nostro clima mediterraneo è la scarsa presenza media di sostanza organica nei suoli, per via di cicli di mineralizzazione troppo accellarati dalle alte temperature. Le numerose radici che esplorano il suolo a diverse profondità facilitano gli scambi di materia, oltre che contribuiscono a mantenere una certa porosità che tampona gli eccessi di acqua da un lato e, dall’altro, riduce gli essicamenti e l’erosione.
In generale, cambia il flusso di tutti gli ambiti energetici (irradiazione luminosa, turbolenza dei venti, ciclo dell’acqua e dei nutrienti). Ad esempio, degli studi hanno evidenziato le differenze del ciclo della fissazione del carbonio in situazioni di vigneto “nudo” rispetto a vigne in consociazione, a netto vantaggio delle seconde.
In particolare, la presenza di una ricca vegetazione determina un effetto positivo sul microbiota della rizosfera. Il suolo è più vivo, ricco di funghi, batteri, lombrichi, ecc. Aumenta la presenza delle micorrizie, perchè queste non colonizzano solo le viti ma anche altre specie arboree. Questi funghi, come dimostrato, hanno effetti positivi sulla capacità fotosintetica delle piante ma anche sulla loro capacità di esplorare il suolo per l’approvvigionamento di sali minerali ed acqua. Il micelio extra-radicale delle micorrizie può colonizzare nello stesso momento più piante, sia viti che altre, creando una sorta di cenosi inter-specifica. La presenza di più specie vegetali può portare ad una maggiore differenziazione delle micorrize presenti, rispetto alla monocoltura, aumentando la probabilità della loro diffusione e sopravvivenza. Si è anche visto che la presenza di comunità diversificate di micorrizie velocizza il tempo di colonizzazione delle radici di giovani piante.
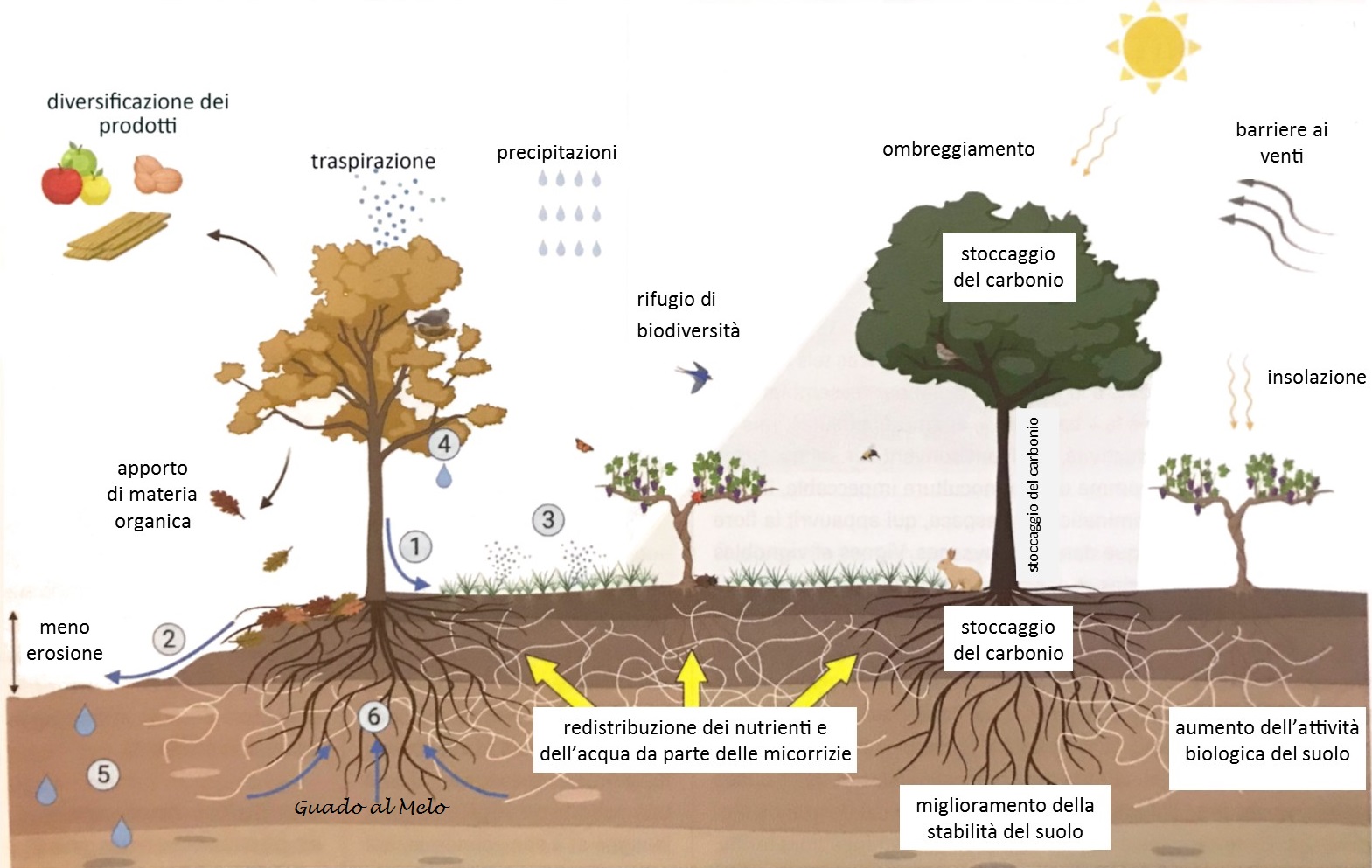
La consociazione tradizionale deriva da usi antichissimi, a volte fatti con sapienza, a volte casuali. Oggi l’agroecologia della vigna permette degli studi approfonditi sulla particella per capire la disposizione migliore dei diversi alberi, la scelta delle specie da inserire, sia come essenze che come taglia, ecc.
Credo che però la presenza di essenze locali, anche spontanee, crei una consociazione specifica molto più interessante rispetto a progetti troppo costruiti, rientrando anche nel concetto generale di specificità del genius loci (o terroir viticolo, chiamatelo come preferite) di quella vigna. Non dobbiamo dimenticare che uno dei principali fini della viticoltura sostenibile è quello minimizzare gli input umani. Credo sia un controsenso una costruzione artificiosa di una "falsa" naturalità, oltrettutto se ha necessità di continui interventi umani per essere mantenuta. Una gestione ottimale dovrebbe condurre ad un agro-ecosistema che si equilibri il più possibile da solo.
Ad esempio, nel caso del manto erboso, il prato spontaneo ha dei vantaggi indubbi rispetto il seminato. Numerosi studi hanno dimostrato che l'accumulo di azoto disponibile nel suolo grazie al sovescio di certe leguminose non sia così diverso da quanto si possa ottenere col prato spontaneo. Se non ci sono grossi impedimenti, perché non lasciar fare alla natura, evitando le continue semine? I vantaggi ecologici e di gestione sono evidenti: si limitano gli usi del trattore (si riducono i consumi di carburante e si evitano troppi ingressi che compattano il suolo), diminuiscono le spese in generale (è inutile comprare il seme quando il prato si rigenera da sé), ecc. Credo che sia un controsenso parlare di biodiversità in vigna e poi impostare la monocultura anche nel prato. Quello spontaneo sviluppa numere specie diverse che fioriscono a scalare, in modo da creare un ambiente più in sintonia con le stagioni, molto più attrattivo per la micro-fauna locale.
Concludo tornando a quella che è la massima forma di consociazione della vite con altre specie vegetali: la vite "maritata" l’albero che a Guado al Melo stiamo studiano da diversi anni in campo. Questa forma antica tradizionale è snobbata dal mondo produttivo. C'è molta chiusura nel mondo del vino italiano intorno a questo tema: è un sistema che viene visto come vecchio e superato.

Curisamente, sto trovando invece sempre maggiore interesse per le viti maritate nella letteratura francese di settore. Sempre più mi capita di leggere articoli e testi sull'argomento, come nello speciale della Revue des Oenologues che cito in fondo.
Come ho già raccontato nella parte finale di questo post, i Romani dall'Italia la portarono anche nel resto d’Europa, Francia compresa. I francesi, storicamente, hanno abbandonato la vite maritata molto prima di noi, ma stanno tornando a riscoprire questa forma d'allevamento come nuova strada per un possibile futuro della viticoltura. Ad esempio l'OIV ha premiato fra i migliori libri del 2020 per la viticoltura sostenibile (o "durable", come dicono in Francia), un libro che parla di consociazione fra viti ed alberi, fra cui anche la vite alberata. Sto parlando de “La vigne et ses plantes compagnes” di Léa Darricau e Yves Darricau, ed. La Rouergue (2019).
Il mio vuole essere anche un invito a svegliarsi per il mondo del vino italiano. Come è già successo troppe volte per tanti altri aspetti del vino, aspetteremo di capire l’importanza di questa nostra tradizione quando i francesi l'avranno rilanciata e rivendicata nel mondo come loro? A quel punto ci sembrerà interessante? Meditiamo!
"Pratique viticoles inspirantes - Agroécologie en action au service du vivant", Revue des Oenologues.., Dossier Spécial, Nov. 2020, n.177
“Agroecology as a science, a movement and a practice. A review” A. Wezel*, S. Bellon, T. Dore´, C. Francis, D. Vallod, C. David (2009), Agronomy for Sustainable Development29(4):503-515
"Vine Roots", by E. Archer and D. Saayman, 2018 The Institute for Grape and Wine Sciences, Stellenbosch University
"La nuova viticultura", a cura di A. Palliotti et al., 2015, Edagricole.
Buone Feste
Per questo Natale ho scelto l’immagine di una Madonna col Bambino sotto una pergola di uva, di scuola tedesca. Il loro volto è sereno, come la serenità che dovremo cercare di ritrovare col nuovo anno.
Un caro augurio a tutti voi
Michele Scienza, secondo Wine Advocate uno dei produttori più creativi di Bolgheri
La rivista americana Wine Advocate ha pubblicato il suo giudizio sulle ultime annate presentate della nostra DOC Bolgheri, col parere di Monica Lerner. Potete trovare l'articolo al link qui sotto ma, visto che è leggibile solo per gli abbonati, eccovi un breve resoconto.
Intanto, ringraziamo di cuore Monica Lerner ed il suo staff!
La cosa che più ci soddisfa è che siamo definiti come i produttori più creativi di Bolgheri. Gli aggettivi che più usa per noi (ed i nostri vini) sono: "folli", "insolito", "diverso dai suoi pari", ecc. Da parte nostra, ci sembra strano passare per bizzarri perchè siamo fra i pochi a produrre vini secondo antiche tradizioni vinicole italiane. Ognuno però ha il suo legittimo punto di vista! Ad ogni modo, siamo orgogliosi di fare vini che sono riconosciuti come non banali (o scontati).
 Così mette in nota su di noi: "Ricordo con affetto la mia visita a questa tenuta, anche se molti anni fa, e ho un vivo ricordo dei folli vigneti di Guado al Melo. Esplorarne le trame sperimentali è come essere un archeologo della vite, con tanti tesori nuovi e sconosciuti da scoprire. Michele Scienza e suo padre Attilio hanno una collezione di viti che non si trovano da nessun'altra parte, tutte raccolte in anni di esplorazioni e viaggi oltreoceano. Sono stati riportati dalla Georgia e da altri luoghi antichi per la Vitis vinifera".
Così mette in nota su di noi: "Ricordo con affetto la mia visita a questa tenuta, anche se molti anni fa, e ho un vivo ricordo dei folli vigneti di Guado al Melo. Esplorarne le trame sperimentali è come essere un archeologo della vite, con tanti tesori nuovi e sconosciuti da scoprire. Michele Scienza e suo padre Attilio hanno una collezione di viti che non si trovano da nessun'altra parte, tutte raccolte in anni di esplorazioni e viaggi oltreoceano. Sono stati riportati dalla Georgia e da altri luoghi antichi per la Vitis vinifera".
Ecco la sua impressione sui nostri vini.
Abbiamo dovuto scegliere fra i nostri bianchi da mandare in degustazione e abbiamo deciso per l'Airone Vermentino. Sicuramente lo ha apprezzato molto, visto che ha preso un punteggio strepitoso per la sua categoria e prezzo (89). Questa è la sua descrizione, che potete confrontare con la vostra impressione, visto che è un vino già in vendita: "Il Vermentino L'Airone Guado al Melo 2019 rivela miele, bergamotto, pesca e mela Golden, che conferiscono al vino una certa ricchezza e consistenza in più rispetto a molti dei suoi pari. Lo stile è più aperto, morbido e nel complesso ossidativo, con una sottile dolcezza sulla chiusura. Non è uno di quei Vermentini taglienti e croccanti, ma è invece un vino che privilegia setosità e morbidezza cremosa."
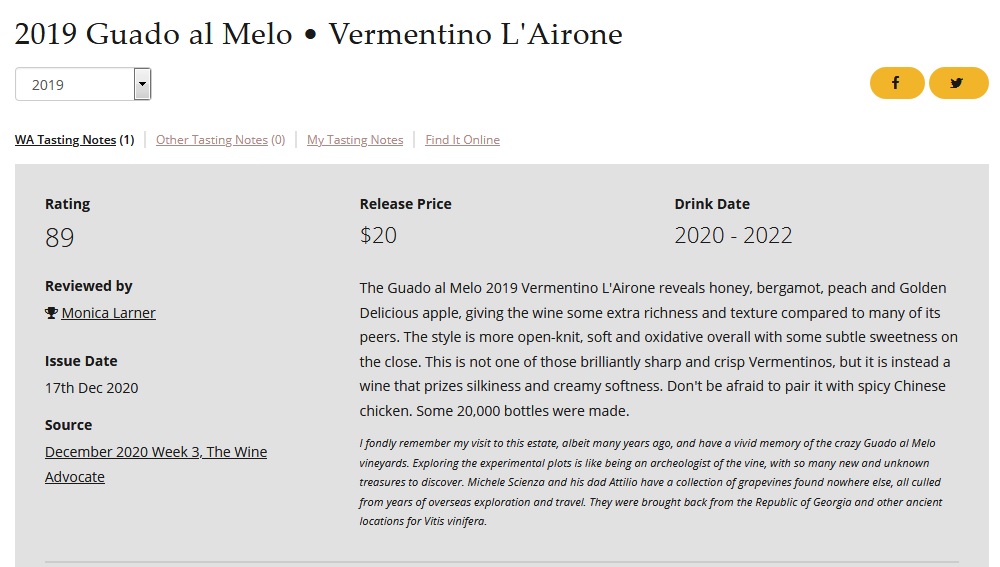
Grande apprezzamento anche per il Rute 2018 (89) che ricordo, è stato anche amato dal Gambero Rosso al punto da dargli i TreBicchieri: "Un rosso insolito ... Questo è un vino di medio corpo, ben concentrato, di uno dei produttori più creativi, Michele Scienza, nella denominazione Bolgheri ... Questo rosso da taglio presenta aromi di frutta nera e pane tostato con insoliti sentori di di crakers Graham* o caramello. Nel bouquet si sentono più leggere anche note terrose e di fungo porcino”.
Ho cercato cosa sono questi crakers Graham* ed ho trovato che sono biscotti molto friabili fatti con una miscela particolare di farina integrale. Quindi, potrebbe significare un aroma un po' dolce e caramellato, tipo biscotto Digestive? Qui ho trovato anche una ricetta, se volete provarla.
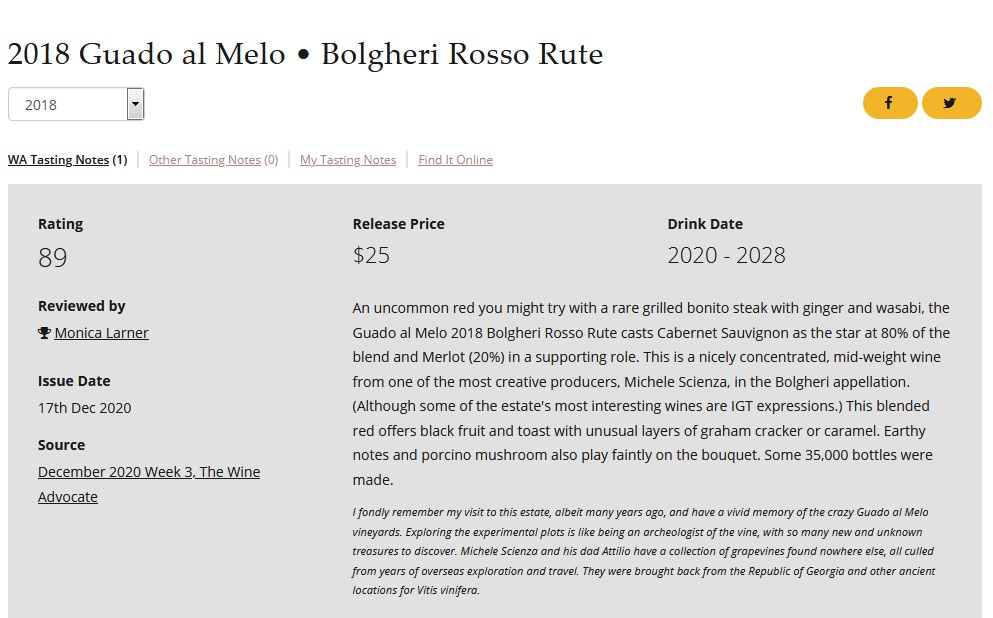
Con l'Atis 2017 alziamo il livello (ed il punteggio, 91): "Mostra la morbidezza materica e gli aromi di amarena per lo più associati al Merlot (mia nota: come sapete, in realtà il Merlot è una percentuale bassissima, la prevalenza è Cabernet sauvignon). È un vino corposo, con un bouquet ricco e generoso modellato dal caldo sole e dalle alte temperature dell'annata. Il bouquet rivela note di conserva di more, crema di cassis, spezie, cedro e mogano affumicato o mesquite che vorresti cucinare con una bistecca alla griglia. Al palato il vino esprime fermezza e un tocco di agrumi".
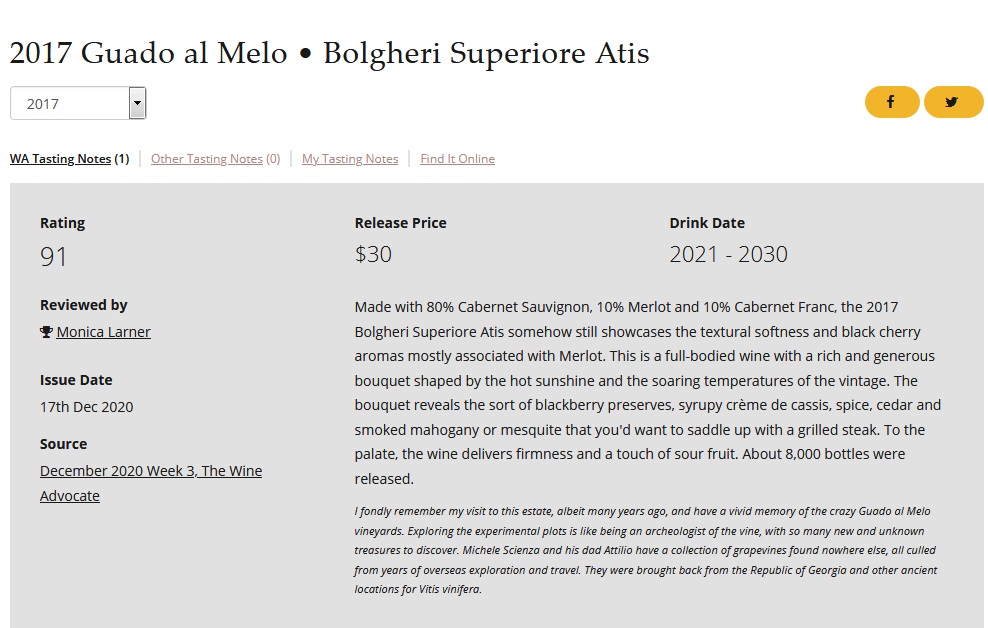
Il suo preferito è stato sicuramente il Jassarte (91+), col quale si sbizzarisce a sottolinearne la particolarità: "Una pazza miscela di 30 vitigni mediterranei e toscani, ..., Jassarte 2017 evoca un tema "giurassico" in viticoltura perché l'antico mondo del vino viene magicamente portato in vita in questo assemblaggio insolito, quasi paleontologico. Ho assaggiato molte annate di questo vino in quasi 20 anni. Penso che questa sia l'edizione migliore e più equilibrata che ho provato finora. Equilibrio è la parola chiave, perché immaginate quanto sia difficile produrre un vino con così tante variabili, da un vigneto sperimentale che imita un giardino pre-fillosserico. La frutta scura e la mora sono seguite da spezie tostate, cracker Graham e alcuni degli altri aromi che abbiamo visto nelle altre nuove annate di Guado al Melo. Non puoi battere questo livello di creatività".
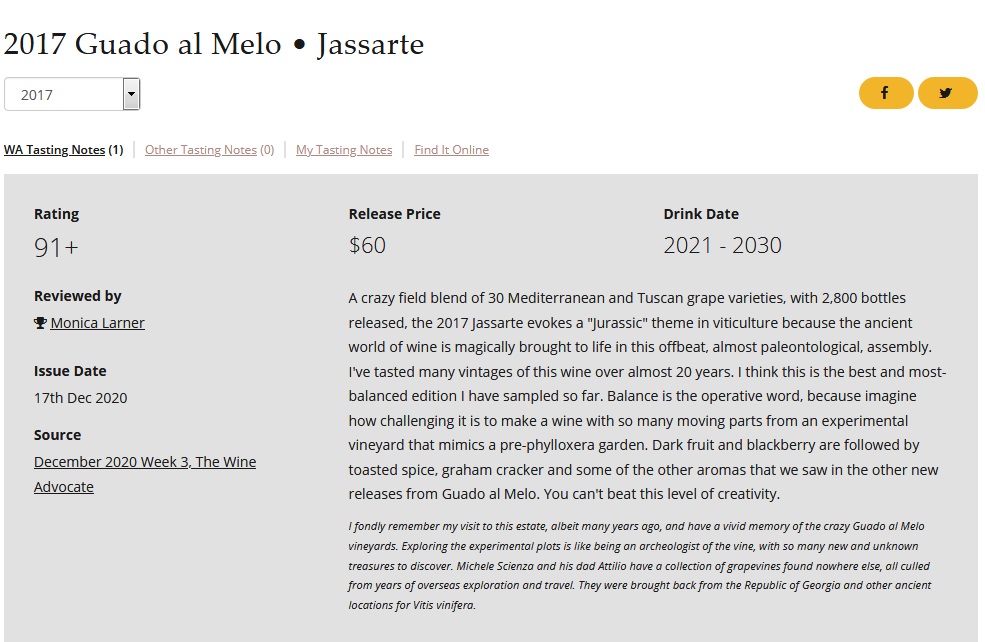
Nella parte generale dell'articolo sulla DOC Bolgheri, viene presentata in generale l'annata 2017. Sicuramente non è stata facile ma, al di là di aver comportato una riduzione importante della produzione, secondo noi non è neppure stata così negativa. Il paragone col Sahara è quanto meno azzardato. Viceversa, è un territorio che dimostra sempre un'ottima capacità di resilienza. Secondo noi Bolgheri ha sopportato molto bene l'aridità dell'annata, a conferma della sua straordinaria vocazione viticola.
La Maremma aspra e selvaggia di Bolgheri e Castagneto
Ai giorni d'oggi il nostro territorio è un giardino mediterraneo di grande bellezza, dove si producono vini di prestigio mondiale. Nell'epoca antica, come ho raccontato qui e qui, era una fiorente zona agricola, al centro di un ottimo sistema di comunicazione e di commerci. Nelle diverse aziende agricole romane del territorio, poste come oggi nell’area pedecollinare e di pianura intorno alla via Aurelia, si producevano e commerciavano vino, olio d’oliva e cereali.
Invece, nel lungo periodo intermedio fra questi due estremi, la costa toscana meridionale subì una trasformazione drammatica: divenne un territorio povero, dominato da paludi, con un’agricoltura poco più che di sussistenza ed anche isolato. E così rimarrà per secoli. Come è stato possibile?
Sicuramente la natura del luogo ha avuto un ruolo importante. Le paludi costiere naturali hanno dilagato senza più l’intervento umano di costante gestione e cura del territorio, iniziato con gli Etruschi e perfezionato in epoca romana.
La questione geografica è sicuramente determinante ma non è sufficiente a spiegare questa involuzione, che dipese comunque soprattutto da motivi politici e sociali, strettamente concatenati fra loro. La Maremma, forse troppo lontana dai centri di potere di allora, divenne solo una terra da depredare, senza che i dominatori si preoccupassero minimamente del suo sviluppo. Questa gestione e la povertà locale resero la situazione sociale molto stagnante, con un'impostazione feudale che impedì per secoli la nascita di una classe di proprietari terrieri più dinamici, in grado di guidare un importante sviluppo dell'agricoltura (viticoltura compresa) e di tutto il territorio, come successe invece in altre parti della Toscana.
Per lunghi secoli, quindi, la Maremma non è stata il luogo solare di vacanze che è oggi. Era una Maremma aspra e selvaggia, una terra di povertà e di abbandono, che è rimasta più o meno tale fino al XIX, per alcune zone anche per la prima metà del XX secolo.
È la Maremma che Dante cita nella Divina Commedia come paragone per la triste foresta dei suicidi, un bosco intricato e malevolo, pieno di sterpi e di bestie temibili. La definisce con quelli che reputa i suoi confini: Cecina a nord e Corneto a sud (il nome medievale di Tarquinia):
“[…] non han sì aspri sterpi né sì folti
quelle fiere selvagge che ‘n odio hanno
tra Cecina e Corneto i luoghi cólti.”.
È la Maremma che ancora nell'Ottocento rendeva precaria la vita dei suoi abitanti e dei lavoratori stagionali con la malaria, come ricordato in questo famoso canto popolare toscano:
"Tutti mi dicon Maremma, Maremma..
ma a a me mi pare una Maremma amara
l'uccello che ci va perde la penna
io c'ho perduto una persona cara.
Sia maledetta Maremma, Maremma,
sia maledetta Maremma e chi l'ama.
Sempre mi piange il cor quando ci vai
perché ho timore che non torni mai ...".
("Maremma amara", canzone popolare toscana)
Il nostro comune di Castagneto Carducci è nella parte più a nord della Maremma, detta Alta Maremma o (in passato) anche Maremma Pisana.
La produzione del vino di allora.
In tutta Italia, la produzione del vino nell'Alto Medioevo fu notevolmente ridimensionata rispetto alla fiorente epoca romana, ma non scomparve mai del tutto. Molto diversa fu la storia nell'Europa centro-settentrionale, dove la viticoltura era stata portata dai Romani. Dove la coltivazione era resa difficile e costosa da un clima non proprio favorevole, scomparve quasi del tutto. Sopravvisse solo grazie agli ordini monastici e alla Chiesa. Alla produzione religiosa se ne affiancò poi una signorile, di nobili e principi, per i quali il vino era un simbolo di prestigio e di potere.
Invece nel mondo mediterraneo come l'Italia, dove la vite cresce rigogliosa senza troppa fatica, la produzione rimase sempre molto diffusa anche nel mondo contadino. Già alla fine dell'Alto Medieovo era ritornata a buoni livelli quantitativi, con la ripresa di traffici e commerci. Quasi tutti gli Statuti Comunali italiani si preoccuparono di regolamentare la produzione del vino, i dazi e quant'altro.
In generale si persero però le raffinate tecniche romane e si tornò ad una produzione più primitiva. Ci vorrenno secoli per recuperare molte di queste conoscenze. Per avere una trasformazione veramente sostanziale, si dovranno poi aspettare le scoperte e le innovazioni della seconda metà dell'Ottocento.
La viticoltura medievale fu caratterizzata in generale da vigne chiuse e protette, realizzate a ridosso dei villaggi e anche dentro le mura di borghi e città. Gli spazi da sfruttare erano ristretti e quindi prevalse la coltivazione della vite bassa. Dal Rinascimento, col ritorno ai campi aperti, nell'Italia centrale tornerà invece a prevalere la vite maritata all'albero. Come già raccontato qui in epoca romana, l'una e l'altra forma (con tutte le varianti locali) non spariranno mai del tutto in Italia. Prevarrà l'una o l'altra a seconda delle epoche storiche e delle tradizioni locali.
Anche nel nostro territorio la vite ed il vino non sparirono neanche nelle epoche più buie. La presenza delle vigne intorno a Castagneto è citata fin dal primo documento scritto dell’Alto Medioevo (754 d.C.) ed in quelli successivi, con un certo incremento nelle proprietà signorili del Seicento e, soprattutto, del Settecento.
Ho raggruppato questo lungo periodo perchè purtroppo non abbiamo notizie su come fosse la viticoltura ed i vini locali di queste epoche. Sappiamo solo che fu una produzione essenzialmente legata ad un consumo locale, senza sviluppo ulteriore per via delle difficoltà generali del territorio di allora. Un salto produttivo ci sarà solo con l’Ottocento, ma di questo parlerò in un prossimo post.
Una particolarità è che i contadini maremmani, a fianco della produzione nelle vigne, continuarono ancora ad usare per secoli l’uva selvatica delle lambruscaie, gli aggregamenti di viti selvatiche nei boschi da cui migliaia di anni prima aveva avuto origine la viticoltura (vedete qui). Come descritto da Emilio Sereni, in Italia non c'è quasi mai stata una separazione netta fra l'ambiente agricolo-pastorale e quello naturale. Mi piace pensare che questa tradizione non sia morta e stia tornando nell'idea di agro-ecologia che stiamo cercando di applicare ai nostri giorni.
Vediamo ora come il paesaggio e l'agricoltura del nostro territorio si sono trasformati in questi lunghi secoli, quando la Maremma era ancora aspra e selvaggia.
La Maremma dei villaggi di altura.
Tra la parte finale dell'Impero Romano e l'inizio dell'Alto Medioevo, ci fu un vuoto politico, accompagnato da incursioni barbariche e guerre che trasformarono drammaticamente il nostro territorio, come tutta l'Italia. Fra il VI e VIII secolo l'area fu quasi spopolata e gli insediamenti si spostano sempre più sulle colline. Cercavano di sfuggire al progressivo avanzamento delle paludi costiere ma anche di allontanarsi dalla via Aurelia, fino ad allora asse centrale del territorio ma che ormai era diventata la porta di ingresso di barbari ed eserciti.
Si tornarono spesso ad occupare i luoghi di abitazione pre-romana, dove era più facile proteggersi e nascondersi, con vicini fonti e boschi per il sostentamento, visto che l'agricoltura non era più sufficiente.

Nel giro di poche generazioni si persero infatti molte delle conoscenze e delle tecniche in ogni campo. I villaggi tornarono ad essere fatti di capanne. In alcune zone della Toscana si ritornò addirittura ad abitare le grotte. L’uso della pietra sarà recuperato solo verso il IX-XI secolo, prima per le mura difensive, le dimore signorili e poi il resto.
In questo periodo è nata la struttura del paesaggio della Maremma la cui impronta è visibile ancora ai giorni nostri:
- La parte di pianura costiera era dominata da acquitrini, canneti e boscaglia.
- La zona pede-collinare e di prima collina era quella abitata e coltivata. Qui si formarono gli insediamenti che poi diventeranno i borghi medievali ed i castelli. Le coltivazioni erano poste intorno ai villaggi. Più a ridosso delle case (e poi anche dentro le mura) c’erano le vigne, gli orti, gli olivi ed altri alberi da frutto, ben protetti dagli animali selvatici e no, oltre che dagli umani. I cereali ed altre colture (come le fibre tessili) erano coltivati in spazi un po’ più ampi e un poco più discosti dai villaggi. I singoli appezzamenti erano detti mansi, realizzati sui diversi fianchi delle colline, per sfruttare le diverse esposizioni al sole.
- Le colline vicine erano invece dominate dai boschi, il vero asse centrale per la vita e l’economia dell’epoca.
[one_third][info_box title="" image="" animate=""]Dal VI secolo cominciò il dominio longobardo, col centro del ducato a Lucca. Nel 730 d.C. circa venne nominato un signore locale, il “comes” (conte) Ratcauso, inviato nel territorio soprattutto con l’incarico di difendere le risorse minerarie dagli attacchi dei pirati. Castagneto è nominato per la prima volta in un documento del 754 d.C., nell’elenco dei beni dati in dotazione alla nascente Abbazia di Monteverdi, fondata dal figlio di Ratcauso, Walfredo. Bolgheri viene citata per la prima volta in una bolla papale del 1075, col nome di Sala del Duca Allone, quando già i Franchi avevano preso il sopravvento sui Longobardi. La presenza del castello è segnalata nel 1158. Altri castelli sorsero sulle colline intermedie: il Castello di Castiglioncello di Bolgheri e quello di Segalari.
I pochi resti attuali della Torre di Donoratico (non l'attuale Donoratico, che è nato a fine Ottocento) segnano invece un sito di lunghissima stratificazione abitativa. Vi ricordate che ne ho già parlato in epoca etrusca e poi in quella romana (qui)? Gli archeologi vi hanno trovato anche resti di capanne della prima epoca longobarda (dette grubenhaus), della metà circa del VIII sec. Più tardi il villaggio di capanne divenne un piccolo borgo fortificato e poi un castello. Questo luogo fu definitivamente abbandonato nel XVI secolo, forse a seguito di un assedio o di una pestilenza (o entrambi). Questo abbandono definitivo, dopo millenni di continuità abitativa, rimane un mistero per gli studiosi. [/info_box][/one_third]
I nuovi insediamenti di collina non comprendevano quasi mai edifici religiosi. Le chiese rimasero per lo più dove erano nel Tardo Impero, in pianura, vicino alle principali vie di comunicazione romane. Questa è un’altra caratteristica tipica del paesaggio di campagna toscano: villaggi di altura e chiese pievane di pianura, dove si incontravano anche abitanti di diversi insediamenti. Solo più tardi, dopo il IX-X secolo, le chiese entreranno nei villaggi, costruite dai nuovi signori come segno di prestigio.
La Maremma dei boschi
In tutta Europa, in quest’epoca, il bosco si riprese buona parte del territorio, in quel fenomeno generalizzato detto “reazione boscosa”, durato almeno fino al X secolo. Allo stesso tempo il bosco divenne il centro dell’economia, per via di un’agricoltura ormai secondaria. Nel nostro territorio, dove l’agricoltura non si svilupperà mai più di tanto almeno fino al XIX secolo, il bosco rimase centrale molto a lungo. Ancora oggi domina buona parte delle nostre colline e della cultura del territorio.
Nel bosco si raccoglieva la legna per tutti gli usi, prima solo di sussistenza, poi divenne un’importante risorsa economica, il cui monopolio era nelle mani dei governi e dei loro feudatari. Il legname ed altri prodotti erano trasportati via mare da porti naturali lungo la costa, posti spesso agli sbocchi dei torrenti: il Renaione, il Seggio, la Bassa (a mezzo miglio a sud del Forte), il Paradù. Oggi sono bellissime località balneari.
Nei boschi si cacciava e si raccoglievano i frutti spontanei. Qui da noi erano molti estesi i castagneti (non a caso il capoluogo del comune si chiama Castagneto), ben più di oggi. Le querce davano le ghiande, usate per gli animali ma anche per l’uomo. Dal frassino si prendeva la manna, un dolcificante estratto per secoli in Maremma. La raccolta finirà all’inizio dell’Ottocento, quando divenne comune il consumo di zucchero di canna importato. Poi c’erano vari frutti: more di rovo, corbezzoli, funghi, ecc. Il bosco è stato per secoli il regno dei carbonai, sia per una produzione d'uso domestico che per l'alimentazione dei forni fusori del ferro, una delle principali risorse economiche da sempre delle nostre terre.
Gli animali erano per lo più allevati allo stato brado nei boschi e nei pascoli incolti. La predominanza era dei maiali, lasciati nei boschi quasi tutto l'anno e messi in stalla solo d’inverno. A lungo sono stati la principale fonte di grasso, in sostituzione all’olio d’oliva, la cui coltivazione era in decadenza dopo l'epoca romana.
Le boscaglie semi-paludose dell'area costiera erano invece adatte all'allevamento brado dei bufali, gestiti dai bufalai e dai butteri. La presenza del bufalo selvatico è molto antica, testimoniata almeno in epoca romana. Eppure il naturalista francese Buffon nel XVIII scrisse che il bufalo fu introdotto in Italia dai Longobardi e in diversi testi viene riportata questa teoria. I bufali girovagarono per la nostra pianura fino ai primi decenni dell’Ottocento, quando si passò ad un allevamento solo nelle stalle. Oggi è completamente scomparso.

La Maremma dei contadini e dei nobili
La prima aggregazione dei villaggi, nati nel periodo di vuoto di potere, diede il via a comunità contadine più o meno paritarie, dove spesso l’agricoltura era gestita in modo comunitario o per famiglie.
La trasformazione dei villaggi in nuclei fortificati avvenne più o meno fra il IX e XI secolo, col riaffermarsi anche di una gerarchia di potere locale. Secondo gli studiosi, alcune figure indussero le famiglie più deboli a cedere le proprietà in cambio di protezione, accumulando nel tempo ricchezze, prestigio e cariche decisionali. L’accentramento comprese anche le terre agricole, con la nascita della proprietà fondiaria, che divenne sempre più grande, organizzata intorno alle curtes (corti). L’azienda curtense era simile al colonato del tardo Impero Romano (che ho spiegato nella parte finale di questo articolo). Era suddivisa in piccoli mansi, affidati ai coloni. Una parte dei campi era invece gestita direttamente dal signore, con il lavoro di servi e delle corveé obbligatorie dei contadini.
La mezzadria, che avrà un ruolo centrale in buona parte della Toscana a partire dall’anno mille, qui si diffuse tardissimo, non prima del XVIII-XIX sec. I contadini della Maremma non hanno vissuto quasi mai nelle campagne, se non in epoche recenti, per via anche delle frequenti incursioni dei pirati, come testimoniato dalle tante torri di avvistamento disseminate lungo la costa. I coloni lavoravano di giorno nei campi e di notte rientravano al sicuro delle mura fortificate del borgo. Questo antico uso li priverà a lungo del diritto alla casa colonica e al bestiame.
La povertà dilagante e la lunghissima impostazione feudale hanno polarizzato per secoli le classi sociali locali, non permettendo per molto tempo la nascita di classi intermedie che, ovunque, sono state promotrici delle trasformazioni e degli sviluppi dei territori.
[one_third][info_box title="" image="" animate=""]Alla fina dell’età longobarda e carolingia si affermano nuovi protagonisti lungo la nostra costa: le famiglie dei conti (Aldobrandeschi, Ardengheschi, Gherardeschi, ecc…) e i vescovi delle diocesi maremmane, i cui poteri, su uomini e terre, disegnano un nuovo ordinamento.
I conti della Gherardesca iniziano la loro storia certa con la metà del XII secolo, quando il territorio passò sotto la Repubblica di Pisa, e mantennero il potere anche col passaggio successivo sotto la Repubblica Fiorentina (inizio XV secolo). I tre centri principali divennero in questo periodo comuni autonomi: Donoratico (non quello attuale, ma sulla collina) (1407), Bolgheri (1409) e Castagneto (1421), in continuo conflitto con i conti. La sua residenza era il castello di Castagneto e per questo divenne il capoluogo della Comunità.[/info_box][/one_third]
Visto che tutto o quasi apparteneva ai fedautari, l'accesso ai beni del territorio da parte delle comunità era regolamentato dagli “usi civici”, diritti di uso da parte degli abitanti per il pascolo, la raccolta nel bosco, la pesca, ecc. Alcuni erano diretti discendenti dei diritti sul demanio pubblico di epoca romana, altri erano novità. Ad esempio, dopo la raccolta del proprietario nel castagneto, era concessa la raccolta dei poveri, detta “ruspo”. C’era lo “ius pascendi”, che permetteva di far pascolare il bestiame nei terreni dove il proprietario aveva già fatto il raccolto. Lo “ius lignandi” permetteva di raccogliere nei boschi del signore o del comune un po’ di legna per gli usi famigliari. Non era mai possibile la caccia, soprattutto di animali di grossa taglia, che rimaneva esclusiva dei signori. La contesa dei diritti di uso fra le comunità locali e le famiglie nobiliari furono occasione di numerose dispute e scontri fino a metà Ottocento.
Dal XIII secolo circa in poi, nella Maremma fatta di povertà e di fortissime disuguaglianze sociali, nacque anche il brigantaggio, che il deputato fiorentino Oreste Massari, nell’Ottocento, definì come "la protesta selvaggia e brutale della miseria contro le antiche e secolari ingiustizie”. La massima concentrazione di briganti fu nella Maremma più a sud, vicino al confine con lo Stato Pontificio, luogo di maggiori traffici. La fine del brigantaggio maremmano viene fissata con l’uccisione dell’ultimo grande brigante, Domenico Tiburzi, nel 1896.
La Maremma della transumanza.

Comunque, il periodo di relativa pace del primo Medioevo portò in tutta Italia un innalzamento della popolazione. Si tornò ad avere una contrazione dei boschi a favore dell’agricoltura. In Maremma però durò poco e non ebbe molti effetti positivi. Ad esempio, non si fece nulla per bonificare le aree acquitrinose che, anzi, si allargarono ancora di più dopo la decadenza politica seguita alla sconfitta di Pisa del XIII sec.
L’inizio della Piccola Glaciazione, all’inizio del 1300, portò carestie ed epidemie, come quella della Peste Nera. La Toscana ne fu colpita duramente. In Maremma la popolazione diminuì dell’80%. Il caso più eclatante fu Grosseto, che passò da 1200 a 100 abitanti. A Castagneto la popolazione venne praticamente dimezzata. La povertà del territorio e le difficoltà resero la Maremma un territorio sempre scarsamente popolato. I governi cercarono a più riprese, anche nei secoli successivi, di stimolare l’immigrazione, senza molto successo.
I luoghi incolti ed i boschi erano utilizzati da sempre per la pastorizia e la transumanza ma dal Basso Medioevo, con l'abbassamento della popolazione, questo divenne un vero business per i governi ed i loro feudatari. L'affitto dei pascoli dilagò, influendo in modo determinante sul mancato sviluppo agricolo della Maremma.
Nell’Alta Maremma arrivavano greggi dal Casentino, dal Mugello, da Lucca, da Bologna e fin da Perugia, attratti dal clima mite locale, dal tardo autunno fino all’inizio della primavera. Veniva pagava una tassa per ogni capo, detta “fida”, per cui i pascoli affittati erano detti “fidati”, regolati in modo centralizzato dalla “Dogana di pascolo”. Le Bandite, termine che si trova in diversi toponimi locali, erano alcuni pascoli che rimanevano riservati all’uso dei residenti. Le "bandite per usi" erano gratuite, mentre le "bandite per fida" richiedevano comunque una tassa.
Questa economia fu incrementata ancor di più dal XVI secolo in poi. Il paesaggio venne sempre più pesantemente modificato dall’aumento delle greggi transumanti e dall’uso dell’incendio (qui detto “debbio”, anch'esso rimasto nei toponomi) per il loro allargamento. La grande diffusione della macchia mediterranea che c’è ancora oggi sulle colline, cioè la vegetazione colonizzatrice dopo che un bosco è stato distrutto dal fuoco, è segno di un ambiente molto poco naturale, frutto dell’azione costante dell’uomo.
[highlight background="#B2BA97" color="white"]La macchia mediterranea è una fase intermedia dell'evoluzione della vegetazione spontanea nel nostro ambiente. Le fasi sono le seguenti. Il ciclo si può concludere se non subentrano disturbi esterni. Dopo un incendio rinascono le piante erbacee e si forma la prateria. Dopo di che si sviluppano piccoli arbusti (come la fillirea, il timo, il cisto, ecc.). In terreni dove questi arbusti sono inframmezzati da numerose rocce (e non si andrà molto oltre), si parla di gariga. Quando gli arbusti diventano predominanti, abbiamo la macchia bassa. Poi possono subentrare arbusti più alti (corbezzolo, mirto, ginestra spinosa, lentisco, ecc.), che formano la macchia alta, quella che nel linguaggio comune si identifica di più col nome di macchia mediterranea. Fra questi arbusti alti, ad un certo punto diventeranno sempre più numerosi dei veri e propri alberi (la roverella, il leccio, il pino d'Aleppo, ecc.). Questa formazione mista si chiama forteto. Poi gli alberi diventano sempre più predominanti e si arriva all'evoluzione finale, il bosco vero e proprio.[/highlight]
Una Maremma che, con difficoltà, si avvia a diventare agricola.
[one_third][info_box title="" image="" animate=""] La Repubblica Fiorentina divenne poi Granducato mediceo (1569), ma la situazione non cambiò molto e furono mantenute le stesse impostazioni feudali. Nel 1737 subentrò alla guida del Granducato di Toscana la dinastia degli Asburgo-Lorena. Verso la fine del secolo s'aprì una prima epoca di riforme, alcune delle quali contribuirono un po' a muovere la stagnante situazione sociale e portarono finalmente alla nascita di una nuova (piccola) classe di proprietari agricoli. Dal 1799 al 1814 la Toscana fu occupata dai francesi. Questo comportò l’abolizione dei feudi ed i conti divennero proprietari a tutti gli effetti. Dopo di che tornarono i Lorena. Cercarono di stimolare la coltivazione degli incolti, incentivando di fatto però ancora la grande proprietà terriera. [/info_box][/one_third]

Nel Seicento e nel Settecento, i conti, per via delle basse rendite delle terre, furono spinti anche a farle fruttare di più con affitti o cessioni, che diedero il via ad un primo allargamento dell’agricoltura. Era un timido inizio: infatti ancora a metà settecento la pianura era occupata per buona parte da aree boscose e paludose, le colline dai boschi e dai pascoli.
Il ramo dei conti di Bolgheri aumentò gli affitti ai coloni. Questi iniziarono i primi disboscamenti vicini al villaggio, per scopi agricoli. I contadini rimanevano però ancora senza diritto alla casa colonica ed al bestiame. Erano detti mezzaioli e dovevano dividere i prodotti a metà col proprietario. Un altro tipo di contratto, il cui nome è rimasto nei toponimi locali, era il “terratico”, in cui l’accordo era che per ogni sacco di grano avuto per la semina, il proprietario aveva indietro due sacchi del prodotto. A fine ‘600 il conte si riprese alcune delle terre affittate, per iniziare ad occuparsi anche personalmente di agricoltura.
Nell’area intorno a Castagneto, sotto un ramo diverso della famiglia della Gherardesca, invece si ebbero più le “allivellazioni”. Il "livello" era un tipo di contratto agrario nato in epoca longobarda, simile all'enfiteusi romana. Era un affitto più vantaggioso per l'agricoltore, spesso di lunga durata, col quale il contraente godeva pienamente del bene in cambio di un canone in denaro (un po' più simile agli affitti moderni). C’era l’obbligo di migliorare il fondo ma anche la possibilità di riscattare la proprietà o di vendere il livello. Di fatto, spianava la strada all'acquisizione della proprietà.
Le prime rare allivellazioni risalgono al Seicento, dette “vecchie allivellazioni”. Nel 1784, il granduca Pietro Leopoldo allivellò diversi beni ecclesiastici e comunitari. Nel 1788 ci furono i “livelli antichi”, con cui i della Gherardesca diedero diverse terre ai castagnetani in cambio della cessione degli usi civici della comunità. L’ultimo risale al 1849, quando il conte cedette al comune diversi terreni che poi, a sua volta, allivellò ai cittadini. Ad ogni allivellazione, si aveva una trasformazione del paesaggio, con la crescita delle coltivazioni agricole.
In questo periodo l’agricoltura, fino ad allora praticamente di sussistenza, iniziò finalmente a crescere. Si coltivava principalmente la classica triade: grano, vite e ulivo. A fine Settecento si sviluppò anche la coltivazione del mais, portato dai lavoratori stagionali detti “lombardi” (anche se principalmente arrivavano dell’Appennino tosco-emiliano).
Questo timido incremento agricolo non fu però facile: ci si mise di mezzo anche la natura. Per quasi tutto il Settecento la regione fu periodicamente invasa dalle cavallette, catastrofe biblica sconcertante, mai successa prima e finora mai ripetuta (per fortuna). A Piombino, il 23 giugno 1711, verso le ore 18.00, comparve sul mare una massa scura e una nube di locuste ricoprì rapidamente tutta la campagna. Le invasioni di cavallette si ripeterono periodicamente fino al 1786, allargandosi fino a Castagneto e a Sassetta, a sud fino a Massa Marittima e Gavorrano, distruggendo numerose terre coltivate.
Nella seconda metà del Settecento il granduca spinse alla realizzazione delle prime case coloniche che, per questo motivo, furono chiamate “leopoldine”. Purtroppo, per limitare i costi, furono depredati resti di edifici abbandonati. Scomparvero così praticamente tutti i reperti ancora esistenti di epoca antica, come gli ultimi tratti originari della via Aurelia ed i resti di ville romane. Vi ricordate della lapide di cui vi ho parlato qui? Fu ritrovata nel muro di una stalla. A metà Ottocento scomparvero in questo modo anche i resti della villa romana detta Del Mosaico (vedi qui). Lo stesso successe per i resti di edifici medievali come l’abbazia di Santa Maria in Aschis, San Colombano, parti del Castello di Donoratico (all'epoca i resti erano molto più estesi di oggi), ecc.
Accusati dal Granduca di tenere male le loro terre, i conti iniziarono a fare anche le prime opere di bonifica delle aree paludose e di miglioramento della viabilità. A fine Settecento iniziò la costruzione di quello che diventerà il famoso viale dei cipressi di Bolgheri.
Qui ci fermiamo, alle soglie del periodo della più grande trasformazione del territorio. Vedremo poi come l’Ottocento fu il secolo della prima importante espansione della viticoltura nel nostro comune.
Qui finisce formalmente l'epoca, per il nostro territorio, della Maremma aspra e selvaggia.
L’ampliamento della bonifica e lo sviluppo di colture specializzate dell'Ottocento trasformarono definitivamente questo territorio in agricolo, facendolo uscire da quella che era la definizione dell’epoca di Maremma, la cui appartenenza era allora ritenuta disonorevole:
“da disdegnare a ragione l’antico e diffamato nome” (Beccarini, 1873).
"Il paesaggio come risorsa", di Mauro Agnoletti, Edizioni ETS, 2009.
"Vini Bolgheri e altri vini di Castagneto", di Luciano Bezzini, Enrico Guagnini. Casa Editrice Le Lettere, 1996.
"Dominare e gestire un territorio: ascesa e sviluppo delle signorie forti nella Maremma toscana centrosettentrionale tra X e XII secolo", Giovanna Bianchi, Archeologia Medievale, XXXVII, 2010, pag. 93-103.
"Castello di Donoratico, i risultati delle prime campagne di scavo (2000-2002), a cura di Giovanna Bianchi, Ed. All'Insegna del Giglio, 2004
"Il discorso del vino", di Pietro Stara, ed. ZeroinCondotta, 2013
"L'insediamento altomedievale nelle campagne toscane", di Marco Valenti, Ed. All'Insegna del Giglio, 2004
"Storia del paesaggio agrario", di Emilio Sereni, Ed. Laterza, 1961
Benvenuto Antillo 2019: varietà tradizionali e un'anfora meravigliosa.
 Antillo è il nostro Bolgheri Rosso con cui abbiamo voluto esplorare l’anima più tradizionale del territorio.
Antillo è il nostro Bolgheri Rosso con cui abbiamo voluto esplorare l’anima più tradizionale del territorio.
La storia locale del vino è antica, come in tutta Italia. Oggi Bolgheri è legata essenzialmente alle varietà internazionali, ma nel passato erano presenti anche altre più antiche. Fra quelle rosse c'erano soprattutto il Sangiovese, il Canaiolo nero, la Malvasia nera, l'Alicante (chiamato Cannonau in Sardegna ), ecc. Tutte queste varietà erano sempre vinificate come blend, di campo o di cantina (molte di queste stanno nella vigna Campo Giardino e danno vita al Jassarte).
Il Sangiovese era comunque quello maggioritario e, col Canaiolo, rimarrà la varietà rossa principale per quasi tutto il Novecento. Infatti, queste saranno le due varietà più importanti della prima DOC nata sul territorio, nel 1983, impiegate nella produzione del Bolgheri DOC Rosato.
Il declino del Sangiovese iniziò negli anni '80, il decennio che ha visto, con i primi anni '90, le trasformazioni più radicali della produzione locale. Nonostante ciò, quando fu fatta la sostanziale modifica del Disciplinare del 1994, venne comunque mantenuto, ammesso nella produzione dei vini rossi e rosati di Bolgheri per un massimo del 70%. Nel 2011, con una nuova modifica del Disciplinare, fu ridimensionato ancor di più, ammesso al massimo per il 50%.
La persistenza nel Disciplinare non ne ha comunque evitato la quasi scomparsa: oggi nei vigneti di Bolgheri rappresenta meno del 1% delle varietà a bacca rossa. Noi siamo fra i pochi ad averlo mantenuto nelle nostre vigne e fra i pochissimi ad impiegarlo in un vino Bolgheri DOC.
Abbiamo voluto mantenerlo per questioni storiche. Abbiamo la testimonianza della presenza del Sangiovese nelle nostre vigne dall'inizio circa dell'Ottocento, da quando il nostro podere (nel 1820-1821) entrò a far parte della grande tenuta Espinassi Moratti, che ha lasciato una documentazione molto dettagliata.
Riproporre questo storico legame vitigno-territorio non è però solo un'operazione nostalgica, ma ci permette di far nascere un vino dal carattere molto ben definito, che si differenzia notevolmente dagli altri nostri Bolgheri (Rute e Atis, il Bolgheri Superiore), i quali rappresentano invece la nostra espressione della produzione locale contemporanea.
Antillo è il nostro Bolgheri più giovane, caratterizzato da una grande freschezza e da profumi molto fruttati. Il blend col Cabernet sauvignon accentua la complessità ed arricchisce la struttura. Infine, una piccola parte di Petit Verdot contribuisce alla sua vivacità, oltre che donare note speziate.
L'annata 2019 ha presentato dei contrasti climatici intensi, ma in generale la giudichiamo molto buona. Dopo un inverno piovoso, la primavera è partita calda e secca, per poi precipitare in un maggio di pioggia e temperature basse, con ritardo in tutte le fasi successive delle viti. L’estate ha avuto picchi di grande caldo, ma senza umidità. Il periodo della vendemmia è stato più tardivo del solito, come atteso, ma sempre caratterizzato dal bel tempo. Abbiamo raccolto il Sangiovese ed il Petit Verdot il 24 settembre, il Cabernet sauvignon nei primi giorni di ottobre. L’annata ha originato un vino che, come al solito, è molto piacevole e di buona beva, piacevolmente acidulo, con intensi aromi fruttati, soprattutto di fragola e ciliegia, e profumi speziati, dove prevale il pepe nero. La grande freschezza controbilancia una struttura che non è trascurabile (è oltre 30 g/l di estratto secco) e lo rende di grande beva.
In questo vino tutto parla della vigna, dal nome (Antillo significa “luogo soleggiato”, descrizione perfetta per il nostro territorio) al disegno in etichetta, che rappresenta foglie e grappoli di vite prese da un’anfora etrusca.
Il gioco di foglie e grappoli dell'etichetta dell'Antillo viene dalla Hydria Ricci, una famosa anfora del 530 a.C. circa, rinvenuta a Cerveteri e conservata al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. Ricci è il nome dell'archeologo che l'ha rinvenuta. Cos'è una hydria? Con questo nome si indica la particolare forma d'anfora che era usata nei banchetti antichi per contenere l'acqua. Da qui era attinta e mescolata al vino, prima del consumo.
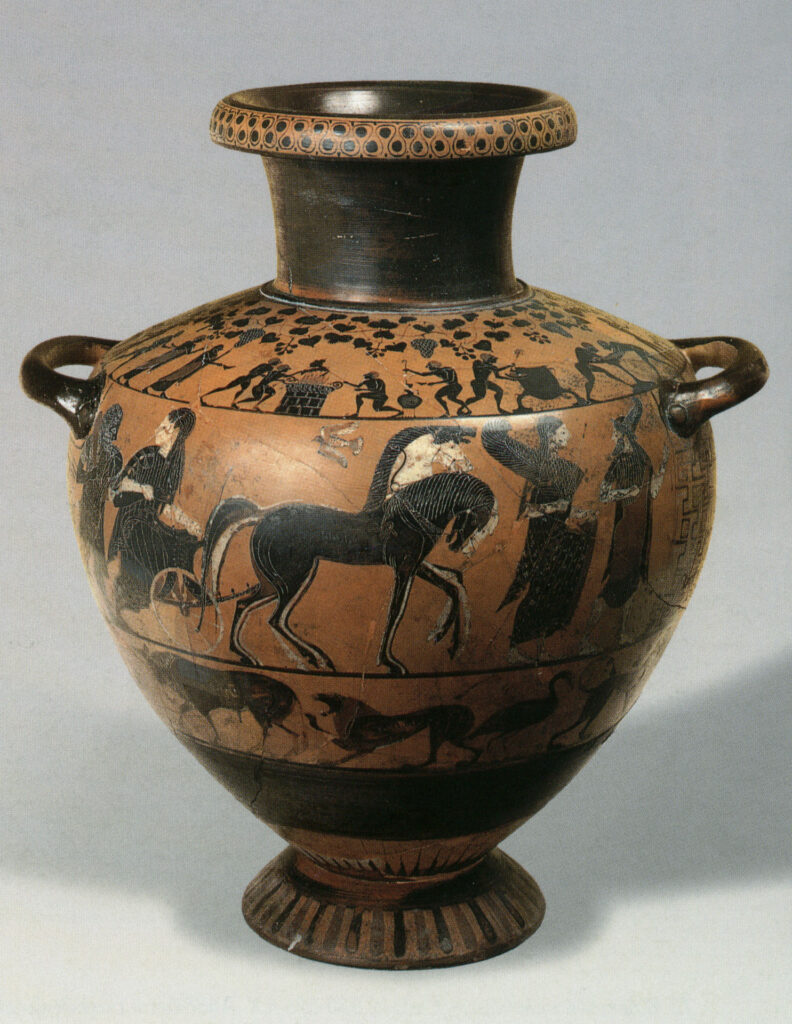
Sulla spalla, a girare tutt'intorno, c'è l'intreccio di tralci di vite e di edera, da cui ho elaborato l'etichetta dell'Antillo. La vite e l'edera sono i due simboli di Dioniso. Vedete le foglie che sono diverse? Quelle dell'edera sembrano il segno picche delle carte, quella della vite sono trilobate e con dei puntini sui margini, forse per simulare il seghettamento. Si riconoscono bene i grappoli di uva dai frutti a bacche dell'edera.
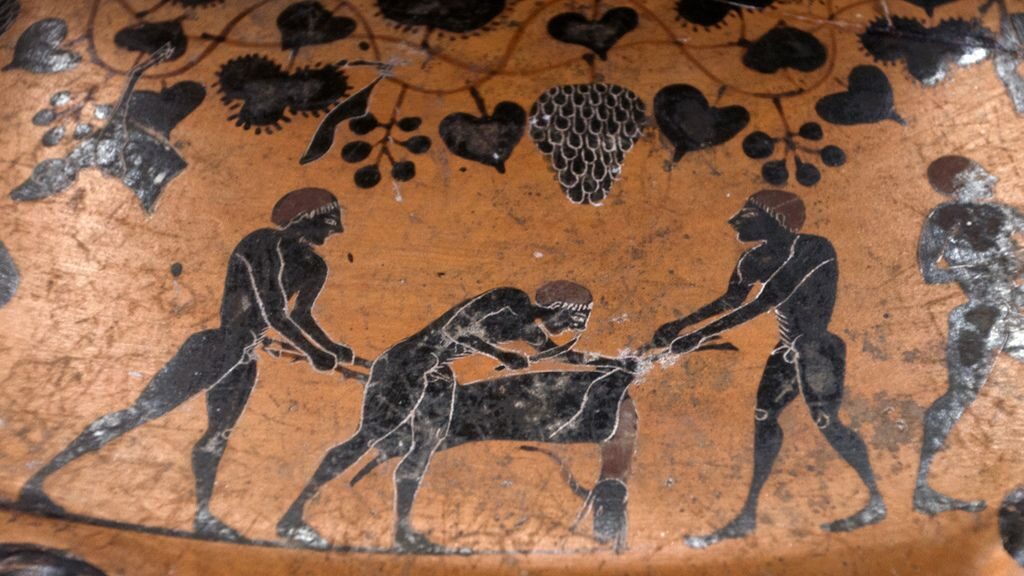
Sotto quest'intreccio si vede una sequenza di azioni molto animate di personaggi che preparano e svolgono sacrifici animali, che poi cuociono, ed attingono il vino da anfore. Un personaggio barbuto (a sinistra, nel particolare dell'anfora qui sotto) regge in mano il kantharos, coppa a due manici usata per il vino e simbolo di Dioniso. Con l'altra mano indica un grande grappolo che sta sopra di lui .
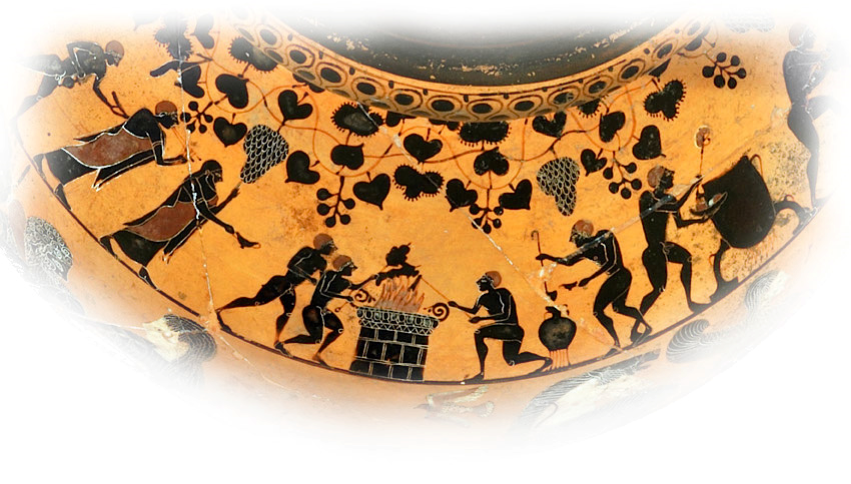
Sembra che questa scena complessa celebri l'introduzione all'umanità della coltivazione della vite, con i sacrifici necessari per garantirsi un buon raccolto. Il personaggio importante potrebbe essere lo stesso Dioniso oppure Icario, il primo uomo (secondo i miti greci) a ricevere dal dio l'insegnamento della viticultura, oppure Maleas, il timoniere di quel mito in cui si racconta di quando gli etruschi rapirono il dio del vino (che ho raccontato qui). Sul corpo dell'anfora ci sono scene mitologiche che si ricollegano alle storie di Eracle ed Achille.
Non mi dilungo: se volete conoscere nel dettaglio queste belle storie ed i loro simbolismi, vi rimando a questo breve filmato dove il direttore del museo di Villa Giulia racconta tutto questo in modo molto chiaro.
https://youtu.be/g9LFjG4En2M
Attilio Scienza racconta la storia della varietà
Terzo appuntamento del ciclo L&L: Liber&Lectio, una serie di incontri dove esperti e studiosi approfondiscono argomenti di grande attualità, ma che hanno radici antiche, prendendo spunto dalla presentazione dei loro recenti lavori.
Attilio Scienza (Università degli studi di Milano) e Serena Imazio (esperta in Biologia molecolare) affronteranno l'affascinante tema delle ORIGINI DEL VINO. Con la presentazione del libro “La stirpe del vino. Nobili ascendenze e incroci bastardi dei vini più amati” verrà ricostruita per la prima volta la famiglia del vino: muovendosi fra analisi del DNA, archeologia, antropologia, mito e letteratura, raccontando l'origine e la storia dei grandi vitigni. Che è anche la storia dei territori in cui sono nati o hanno trovato casa, e la storia degli uomini che alla vite hanno dedicato la loro vita.
IL LIBRO DI ATTILIO SCIENZA E SERENA IMAZIO: LA STIRPE DEL VINO. NOBILI ASCENDENZE E INCROCI BASTARDI DEI VINI PIU' AMATI.
In principio fu il Pinot: capriccioso, poco produttivo, instabile nel colore, eppure capace di regalare vini così eleganti e profumati che generazioni di uomini, innamorati del suo succo, lo hanno curato e diffuso. E il Pinot li ha ripagati: mutevole per natura, ha dato origine al Pinot bianco e al Pinot grigio; incrociandosi, ha generato lo Chardonnay e forse il Traminer, dal quale derivano il Cabernet Sauvignon e il Merlot. In Italia ha per nipoti Marzemino, Lagrein e Refosco. La sua storia è esemplare: oggi in Europa si contano circa diecimila vitigni, diversissimi fra loro, che discendono però da pochi avi fondatori. L'analisi genetica ha rivelato insospettabili storie di incroci, scambi e migrazioni - come la probabile origine meridionale del Sangiovese -, che vanno a intrecciarsi con racconti di conquiste, viaggi ed esplorazioni. Furono i mercanti a introdurre vitigni esotici, come moscati e malvasie, e gli uomini che si allontanavano dalla loro terra a portare con sé le proprie radici sotto forma di piante, andando a contaminare il patrimonio locale, fino a creare nuove varietà.
INTERVENTI
Remo Pedon, Presidente della Biblioteca Internazionale “La Vigna”
Danilo Gasparini, presidente del Consiglio Scientifico della Biblioteca Internazionale “La Vigna”
Attilio Scienza, Università degli studi di Milano
Serena Imazio, esperta in Biologia molecolare
5 grappoli di Bibenda all'Atis 2017
Grazie mille allo staff della guida Bibenda che assegna anch'essa il massimo riconoscimento al nostro Atis 2017, il Bolgheri Superiore DOC.
Grazie a chi ci ha visitato, nuovi orari
Con la fine di ottobre finisce anche la nostra apertura stagionale.
Michele, io, Katrin e Jadranka ringraziamo chi ci ha visitato in questi mesi.
Abbiamo degustato insieme i nostri vini, avete visto dove e come lavoriamo, esplorato la storia e cultura del vino nel nostro piccolo museo. Vi abbiamo raccontato di Bolgheri, di vignaioli Etruschi, di viti selvatiche rese domestiche, di tecniche artigianali e cura della vigna, di co-fermentazioni, di vigne moderne e pre-fillosseriche, di innovazione sostenibile e tanto altro. Per noi è stato un grande piacere.
Da ora in poi sono possibili ancora tour guidati con degustazione, esclusivamente su prenotazione, oltre che la possibilità di acquistare il vino in orario di ufficio (o con spedizione a casa).
Naturalmente, tutto questo sarà possibile salvo nuove limitazioni legate al Covid-19.
Minicorso on line sulla Toscana (e Guado al Melo) con ASPI e Paolo Porfidio
Viticoltura e migrazione: fra insetti pestiferi e voglia di riscatto.
Mi sono imbattuta per la prima volta nel legame fra viticoltura e migrazione quando ho studiato il tema della fillossera e ne ero stata affascinata. Mi ero ripromessa di fare degli approfondimenti ed eccovi un primo risultato.
La viticoltura o meglio le crisi viticole, come quella scatenata dalla fillossera, sono state una causa importante di migrazione. In effetti, questo insettino ha fatto danni incredibili, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento in poi. Devastò letteralmente le vigne d'Europa e la crisi economica che ne derivò fu una delle cause che spinsero milioni di europei a migrare altrove. In Italia colpì verso la fine dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento, con la devastazione di intere regioni viticole. Tutta la nostra viticoltura ne uscì profondamente trasformata, al punto che si parla di una viticoltura pre e post fillosserica. Alcuni territori ce la fecero a ripartire, alcuni più velocemente, altri più lentamente. Altri non ce la fecero proprio o, comunque, non sono più riusciti a tornare alle produzioni vinicole precedenti.
Ho scoperto, però, che la viticoltura non è stata solo una causa ma spesso anche motivo di riscatto per chi migrava. I tanti vignaioli che furono costretti a partire dall'Italia, a causa della fillossera o per tanti altri motivi, hanno portato con sé un enorme baglio di conoscenze e professionalità che spesso sono tornati loro utili nei luoghi di destinazione. In alcuni paesi di arrivo, i nostri migranti hanno contribuito a gettare le basi di un settore economico che, in alcuni casi, è diventato anche molto importante.
I vignaioli hanno portato con sé conoscenze, hanno modellato i paesaggi ed introdotto a volte anche le nostre pregiate varietà di uva. Questo è avvenuto, in alcuni casi, anche illegalmente. Infatti era spesso proibito importare piante nei paesi di destinazione e questo ostacolo fu superato in diversi modi. I semi furono cuciti negli orli degli abiti, i sarmenti nascosti sotto le ampie gonne di allora. Le talee erano celate sul fondo dei bagagli, avvolte in sacchi di iuta ed infilate dentro alle patate per non farle seccare. C'è chi ha pensato di costruire, coi sarmenti della vite, gabbie per i polli, contando sul fatto che i doganieri si sarebbero concentrati sul contenuto e non sul contenitore.
Le storie di emigrazione viticola sono tantissime. Molte di quelle che racconto le ho trovate negli articoli e nei libri di Flavia Cristaldi e degli altri autori, citati in fondo, che vi invito a leggere per intero. Alcune delle storie che riporto sono grandiose, altre piccole, alcune sono continuate nel tempo, altre sono finite purtroppo presto.
Iniziamo però a capire perché partirono.
L’insetto che sconvolse la vita di migliaia di vignaioli
 Le malattie e le avversità agricole hanno segnato spesso la storia dell’umanità. Nei secoli hanno causato carestie, morti, crolli di imperi, migrazioni di massa... Questo articolo di Silvia Kuna Ballero ne fa un elenco significativo: “Le malattie delle piante che hanno scritto la storia umana”.
Le malattie e le avversità agricole hanno segnato spesso la storia dell’umanità. Nei secoli hanno causato carestie, morti, crolli di imperi, migrazioni di massa... Questo articolo di Silvia Kuna Ballero ne fa un elenco significativo: “Le malattie delle piante che hanno scritto la storia umana”.
Nell’Ottocento, i traffici di merci e persone si erano intensificati come non mai. Tutti questi movimenti portarono ad una notevole circolazione di fitopatologie, con conseguenze a volte devastanti. L’esempio più eclatante è stata la grande carestia irlandese, causata dalla peronospora della patata, oltre che dalle scellerate politiche inglesi. Morirono oltre un milione di persone e almeno due milioni dovettero migrare altrove.
La vita dei contadini italiani dell’Ottocento e dell'inizio del Novecento già non era rose e fiori: spesso e volentieri era al limite della sopravvivenza. Bastava poco per sbilanciare questo fragile equilibrio, portando intere famiglie alla disperazione: l'arrivo di un'alluvione, di una siccità prolungata, malattie che colpivano piante o animali, ... L'arrivo di nuove e devastanti malattie della vite diede il colpo di grazia a molte di queste esistenze precarie.
Il primo problema della viticoltura ci fu intorno a metà Ottocento, causato dell’oidio, una malattia fungina arrivata dall’America. Causò danni economici ed alcune migrazioni, ma la soluzione fu trovata abbastanza rapidamente, grazie allo zolfo. La fillossera arrivò più tardi, nella seconda metà del secolo, e fu la causa principale della distruzione delle vigne e di migrazioni di massa. Potete trovare i miei approfondimenti sull'argomento qui, qui, qui, qui e qui, dove racconto come venne scoperta la malattia, le difficoltà, le polemiche e la difficile strada per trovare una soluzione.
In breve, questo parassita attacca principalmente le radici e porta alla morte la vite europea (Vitis vinifera L.). Devastò prima la Francia, poi tutto il continente europeo ed il resto del mondo, ovunque (o quasi) ci fosse una vigna. Ci vollero circa trent’anni per capire come risolvere il problema e molti altri per uscirne. La soluzione venne dall’idea geniale di innestare la pregiata vite europea su radici di vite americana, naturalmente resistente al parassita. 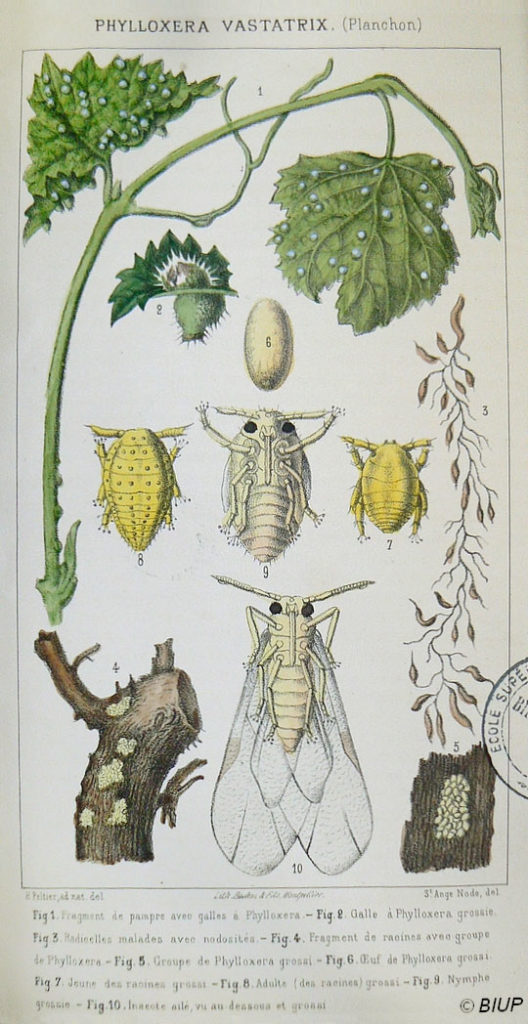
Questo però significò ripiantare da capo tutte le vigne, con interventi economoci importanti, con la perdita irrecuperabile di viti centenarie e di chissà quante varietà antiche minori. Molti vignaioli non ce la fecero a reggere la crisi. Molti non ebbero neppure la possibilità economica di ricostruire le proprie vigne. Ci fu chi si trasferì nelle città, andando ad infoltire il proletariato urbano. Altri dovettero migrare più lontano.
Ho cercato dei dati complessivi sulle implicazioni della fillossera sulla migrazione italiana ma, per ora, ho trovato solo storie di singoli territori.
La crisi della fillossera colpì duramente anche perchè nel XIX sec. la viticoltura in Europa si era espansa come non mai. Stava diventando, in modo sempre più diffuso, un settore economico importante. L'arrivo stesso della fillossera in Francia, la prima nazione a subire l'invasione del parassita, spinse altri territori ad incrementare le proprie vigne per sfruttare il momento di crisi del vino francese. Ad esempio, in Puglia ed in Sicilia ci fu una vera e propria corsa all'impianto, con l'eliminazione della maggior parte del grano. L’isola di Salina, nel 1880, basava quasi tutta la sua economia sul vino, con l’esportazione di 26.000 ettolitri all'anno. Tuttavia, la fillossera arrivò inesorabilmente anche in queste terre, che ormai dipendevano quasi esclusivamente dal vino per vivere. Migliaia di persone furono gettate sul lastrico e molte furono costrette a migrare. Nel 1895 la fillossera aveva distrutto in Sicilia quasi centomila ettari di vigneto. Nel 1904 risulteranno distrutti altri 230 mila ettari, che verranno riconvertiti per buona parte a colture granifere. Le isole Eolie furono praticamente spopolate: dal 1891 al 1914 si conta che partirono quasi diecimila persone.
I fenomeni di spopolamento sono sicuramente più eclatanti in territorio isolati, come isole o vallate. Un esempio più vicino a noi è rappresentato dall’isola d’Elba. Nell’Ottocento il vino era uno dei settori trainanti dell’economia locale. L’oidio causò una prima crisi ed un'ondata migratoria fra il 1850 e il 1860. Negli anni '70 la produzione vinicola non si era solo ripresa, ma aveva anche superato quella precedente. Negli anni ’90 però la fillossera fece stragi, costringendo ad una partenza di massa della popolazione, soprattutto verso l’Australia ed il Sud America. La viticoltura, più tardi, ripartì di nuovo, ma non è più riuscita a tornare ai tempi d’oro d’allora.
Per quanto riguarda il nostro territorio, l'attuale Bolgheri DOC, Mauro Agnoletti (Università di Firenze) cita la fillossera fra le principali cause che portarono all'arresto e alla progressiva diminuzione della viticoltura a Castagneto e Bolgheri nel corso del primo Novecento, dopo il boom ottocentesco. In questo periodo la campagna verrà dedicata sempre più all'orto-frutta, ai cereali e soprattutto all'olivo, che si diffuse allora in monocultura in tutta la provincia di Livorno, con un incremento del 300%. Le vigne torneranno a crescere solo dagli anni '60, ancor di più negli anni '80 -'90 e negli ultimi decenni.
Abbiamo capito perché molti vignaioli partirono. Vediamo ora alcune storie di dove sono andati.
Trentini in Bosnia, fra vino e religione.
La migrazione in Bosnia è poco conosciuta anche perchè di piccola entità. Il Trentino, all'epoca ancora sotto l'Impero Austro-ungarico, fu devastato dalla fillossera e dalle malattie del baco da seta. A peggiorare la situazione ci furono due alluvioni, nel 1882 e nel 1883. Moltissimi contadini partirono per le Americhe, ma una parte di questa migrazione fu indirizzata dalle autorità austriache verso l'attuale Bosnia Erzegovina, appena entrata a far parte dell'Impero (nel 1878), dopo che era stata dominio turco. Era una strategia etnica: volevano creare insediamenti cattolici in aree fino ad allora musulmane. Così, fra il 1874 e il 1914, alcune famiglie trentine della Valsugana e della Valle dell’Adige furono spinte verso i Balcani.
I Trentini ebbero la possibilità di scegliersi le zone più adatte alle loro necessità, con l'invio di esploratori (Augusto Parotto di Villa Agnedo, Giuseppe Martinelli di Aldeno e Domenico Clazzer di Roncegno). Trovarono terreni adatti alla viticoltura e al granoturco vicino a Mahovljani. Qui avviarono una fiorente attività viticola, che divenne famosa nella regione.
Purtroppo la piccola avventura finì male. Nel 1934 giunse anche lì la fillossera e distrusse tutto quello che era stato realizzato. I vignaioli non ce la fecero a ricominciare e furono costretti a cercarsi altri lavori. Molti se ne andarono, per tornare in quella che era diventata nel frattempo la loro nuova patria, l'Italia. Il governo fascista indirizzò molti di essi verso le nuove terre della bonifica in Lazio, dove ricominciarono col lavoro inscritto nel loro DNA: piantare viti.
Napoletani, siciliani (e polli) in Nord d’Africa
 In Nord Africa anticamente c’era stata la viticoltura, sviluppata dai Romani. Era poi praticamente sparita per via dei divieti islamici al consumo di vino. Vi fu riportata dai francesi, che la espansero soprattutto dopo la crisi della fillossera in patria. In Algeria, diverse di queste vigne furono affidate agli esperti migranti napoletani.
In Nord Africa anticamente c’era stata la viticoltura, sviluppata dai Romani. Era poi praticamente sparita per via dei divieti islamici al consumo di vino. Vi fu riportata dai francesi, che la espansero soprattutto dopo la crisi della fillossera in patria. In Algeria, diverse di queste vigne furono affidate agli esperti migranti napoletani.
In Tunisia arrivarono invece i siciliani, molti da Pantelleria (nella foto), distante solo 70 Km. I Francesi avevano imposto il divieto d’importare vitigni stranieri, ma i siciliani non ne vollero sapere di coltivare altro che le varietà della loro tradizione. Le importarono illegalmente, ingannando i gendarmi usando i tralci di vite per realizzare gabbie per i polli. Portarono soprattutto lo Zibibbo e crearono un’ampia zona viticola nel nord della Tunisia, dove il paesaggio fu modellato come un piccolo pezzo di Sicilia. Uno dei centri più prosperi fu quello di Bou-Ficha, dove le brezze marine stemperavano il terribile caldo africano. Le vigne erano fatte di viti ad alberello, spesso dentro le buche per proteggerle dal vento e dal caldo. Sui terreni scoscesi realizzarono terrazzamenti con muretti a secco, diffondendo nella regione questa nostra cultura millenaria. Nel 1964, pochi anni dopo l’indipendenza della Tunisia (avvenuta nel 1956), il governo decise di nazionalizzare le terre degli stranieri, costringendo gli immigrati ad andarsene. Molti italiani partirono per la Francia, diversi tornarono in patria dove ricominciarono a fare viticoltura, soprattutto nell’Agro Pontino.
La colonizzazione italiana della Libia non è qualcosa di onorevole da ricordare. Comunque, convinse alcuni disperati a partire per cercare fortuna altrove. Nel 1932, ogni podere da affidare ad un colono, nella Cirenaica e in Tripolitania, comprendeva anche 2 ettari di vigneto. Furono portati diversi vitigni del sud e delle isole, come il Catarratto, l’Inzolia, il Nerello ed il Bombino. Tutto finì con l’abbandono delle colonie.
Piemontesi in Sudafrica.
Questa storia è forse la meno conosciuta e la più antica fra quelle che racconto. Riguarda la viticoltura in Sud Africa, che era iniziata a metà del Seicento con la colonizzazione olandese, con risultati non proprio esaltanti. Ad un certo punto, però, lo sviluppo vinicolo della colonia trasse vantaggio da un importante evento politico che sconquassò l'Europa. Il 18 ottobre 1685 il re francese Luigi XIV revocò l’Editto di Nantes, proibendo il culto evangelico in Francia e scatenando persecuzioni ed esodi di massa. Luigi spinse in questa direzione anche il vicino Duca Vittorio Amedeo di Savoia, andando a colpire soprattutto la comunità valdese del Piemonte.
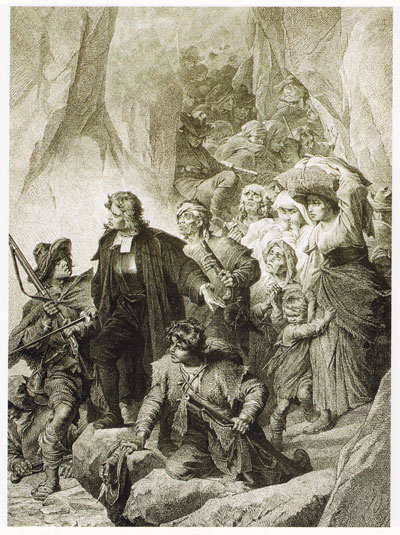
Le valli piemontesi divennero luoghi di massacri e persecuzioni. I fuggitivi, con gli ugonotti francesi, cercarono rifugio in zone di Europa più tolleranti, fra cui i Paesi Bassi. Il governo olandese cercò però di ridurre il numero dei profughi sul proprio territorio dirottandoli verso la colonia sudafricana. Avevano anche capito il valore del patrimonio di conoscenze che quei contadini portavano con sé. Simon van Der Stel, Governatore dell'epoca della colonia, scriveva al Consiglio Olandese:«Riteniamo di incontrare tra i rifugiati francesi e piemontesi che verranno, uomini esperti nella coltivazione della vite e dell’ulivo, che istruiranno i vecchi coloni che ignorano del tutto questa coltura».
Molti si rifiutarono di partire. Aspettarono in Germania il cambiamento politico e fecero ritorno nelle loro valli. Altri invece partirono per il Sudafrica, mescolati agli Ugonotti. L’arrivo dei francesi e dei piemontesi fece cambiare il passo allo sviluppo viticolo della colonia. Furono concentrati nella valle del Drakenstein e nei pressi di Stellenbosch. Gli furono date in concessione fattorie e terreni, in un programma organizzato di espansione agricola. Poi, se ne perdono le tracce, perché furono costretti ad assimilarsi alla cultura locale, obbligati anche a cambiare cognome: Botta divenne Botha, Lombardo divenne Lombard o Luumbard, Jourdan divenne Jordaan o Jordan, ecc.
Secoli più tardi, altri italiani arriveranno con le migrazioni dell’Otto-Novecento. Non saranno molti, ma alcuni saranno decisivi per le trasformazioni del vino sudafricano. Il piemontese Michele Angiolo Zoccola arrivò a Johannesburg dall’Inghilterra nel 1888, come immigrato di successo. Acquistò il Gran National Hotel e una fattoria di 1600 ettari, che chiamò Lombardy Estate (oggi Wynberg). Fu il primo a impiantare viti nel Transvaal, che fino ad allora era ritenuto inadatto, con grandi risultati.
Il toscano Francesco Eschini, originario di Pontremoli, arrivò a Città del Capo dall’Argentina, fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Iniziò con la gestione di una pensione e capì che nella produzione sudafricana di allora mancava un vino semplice, da pasto. Iniziò la produzione in collaborazione con un possidente locale, poi creò la sua azienda, Bellville Winery, influenzando con le sue scelte la produzione nazionale, che in quel momento si stava trasformando dopo le distruzioni della fillossera.
Più recentemente, l’enologo friulano Giorgio della Cia si trasferì negli anni '70 del Novecento ed introdusse i tagli bordolesi ed i lunghi invecchiamenti, contribuendo ancora una volta alla trasformazione della produzione vinicola del Sudafrica.
Vignaioli e platani italiani in Brasile

A fine Ottocento il governo brasiliano, con la fine della schiavitù, cercò di attirare emigranti europei per far avanzare la colonizzazione del paese. La ricerca si basò su principi di scelta razzista: non riuscendo ad attirare più di tanto gli immigrati nord europei, ripiegarono sul nord Italia. Furono mandati emissari nelle valli lombarde, trentine e venete con la promessa di un viaggio pagato e terre che si sarebbero potute riscattare dopo pochi anni.
Molti dei nostri immigrati contadini si stanziarono nel sud del Brasile, dove, con poco o nulla, iniziariano ad impiantare le vigne ed altre coltivazioni. All’inizio producevano in situazioni veramente estreme: c’era chi vinificava nelle vasche da bagno. Nello Stato del Rio Grande do Sul nacquero villaggi con toponimi italiani, come Nova Bassano, Nova Brescia, Nova Milano, Nova Roma do Sul, São João do Põlesine, Vale Vêneto, ecc. Poi furono costretti a cambiarli con nomi più brasiliani.
L’inizio fu difficile e, oltre tutto, anche qui la fillossera arrivò e distrusse le nuove vigne appena fatte ma questo non bloccò i vignaioli. Con l’introduzione della vite innestata, si riuscì a superare questo problema e le vigne poterono prosperare. La viticoltura fu anche estesa anche ad altre zone, come allo Stato di Santa Catarina e nella valle del São Françisco. Col tempo questa produzione, inizialmente molto povera, si affinò, furono importati strumenti e macchinari dall’Italia, le vigne si ingrandirono. Sono poi arrivati enologi e tecnici italiani, … Viceversa i giovani del luogo sono venuti a studiare in Italia, come il caso dei discendenti di immigrati trentini, che hanno mandato i figli a studiare alla scuola enologica di San Michele all’Adige.
Molti di questi immigrati arrivavano dal Nord Italia, per cui realizzarono le vigne col sistema delle loro cultura viticola, soprattutto basata sui tutori vivi, cioè la vite alberata (la vite "maritata" all'albero di antica tradizione etrusca e romana, vedete qui), sistemi a pergola e a tendone. Non usarono però alberi autoctoni e, come sostegni per la vite, fecero venire dall’Italia i platani (Platanus acerifoglia L.), essenza che non era presente in Brasile. Ancora oggi, in certe zone vinicole brasiliane, si possono vedere filari di vecchi platani che affiancano le vigne moderne (nella foto, la Vale dos Vinhedos). Sono i resti viventi di questa vecchia migrazione di uomini e piante.
I Rey del Vino veneti in Argentina.
La dinamica iniziale fu simile al Brasile, ma il governo argentino cercò subito gli immigrati italiani e spagnoli, perché voleva mantenere affinità culturale per i nuovi arrivati. I viticoltori italiani, soprattutto di origine veneta, si stabilirono inizialmente nella provincia centro-occidentale di Mendoza. Grazie a loro la produzione di vino diventerà uno dei pilastri economici della regione. Due veneti, in particolare, Antonio Tomba e Giovanni Giol, partirono dal niente e crearono aziende vinicole così grandi ed importanti da venire proclamati dai presidenti argentini "Rey del Vino", Re del Vino.
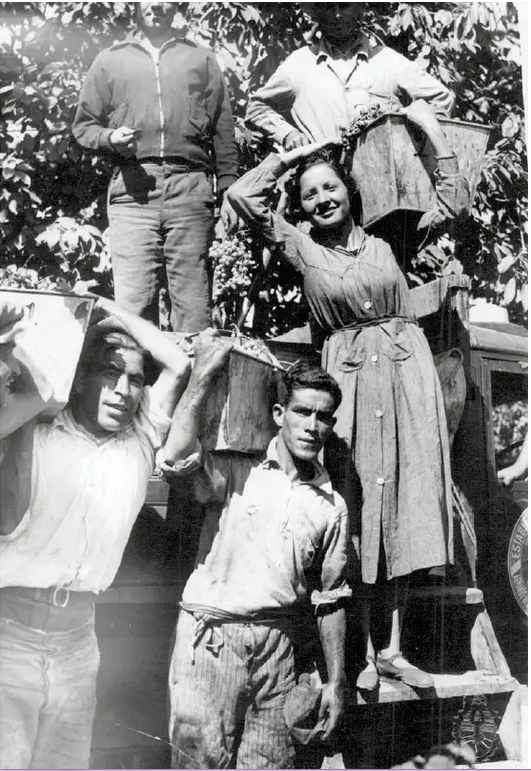 Antonio Tomba era di Valdagno (Vicenza). A 17 anni era scappato di casa e si era unito ai garibaldini. Arrivò in Argentina nel 1873 e, dopo essersi arrangiato con diversi lavori a Buenos Aires, si spostò nella provincia di Mendoza e qui aprì un emporio. L’attività commerciale ebbe successo, sposò una ragazza che era figlia di proprietari terrieri ed iniziò a piantare vigne. Creò così la sua Bodega (azienda viti-vinicola) che a fine secolo era la più grande d’America. Fece scalpore il suo “vinodotto”, un sistema di tubi e pompe che dalla cantina portava il vino direttamente alla stazione ferroviaria, per riempire le cisterne sui vagoni. Nel 1899, a cinquant'anni ed ormai malato, volle tornare a casa, ma morì sul transatlantico, in mezzo all'oceano.
Antonio Tomba era di Valdagno (Vicenza). A 17 anni era scappato di casa e si era unito ai garibaldini. Arrivò in Argentina nel 1873 e, dopo essersi arrangiato con diversi lavori a Buenos Aires, si spostò nella provincia di Mendoza e qui aprì un emporio. L’attività commerciale ebbe successo, sposò una ragazza che era figlia di proprietari terrieri ed iniziò a piantare vigne. Creò così la sua Bodega (azienda viti-vinicola) che a fine secolo era la più grande d’America. Fece scalpore il suo “vinodotto”, un sistema di tubi e pompe che dalla cantina portava il vino direttamente alla stazione ferroviaria, per riempire le cisterne sui vagoni. Nel 1899, a cinquant'anni ed ormai malato, volle tornare a casa, ma morì sul transatlantico, in mezzo all'oceano.
Giovanni Giol era partito per l’Argentina senza niente a vent’anni, nel 1886. Anche lui arrivò a Buenos Aires e cercò di arrangiarsi. Poi iniziò a seguire la costruzione delle linee ferroviarie verso l’interno del paese, vendendo vino ai lavoratori italiani, con la damigiana caricata su una carriola. Gli affari andarono bene e nel 1887 poté affittare una vigna a Mendoza e iniziò a produrre il vino da sé. L’attività crebbe, nacque la sua prima Bodega, che poi crebbe ancora. Ad inizio ‘900 Giovanni Giol aveva un impero di 750 ha di vigne, oltre il vino che comperava. Nel 1912, giunto alla mezza età, volle tornare a casa e lo fece da immigrato di successo. Poté comperare vaste proprietà nella sua terra natia e continuò la sua attività di produttore di vino.
Questi sono solo i due esempi più folgoranti dei molti migranti italiani che contribuirono a fare della provincia di Mendoza una piccola eden dorata del vino. A metà ottocento la provincia contava circa 500 ettari di vigne, all'inizio del Novecento erano diventati oltre dodicimila, negli anni ’30 oltre trentamila. Il successo diede un po' alla testa: ad inizio Novecento, il municipio acquistò i cancelli per il parco cittadino a Parigi, uguali a quelli di Versailles. Il noto agronomo italiano Dalmasso, in visita in Argentina in quegli anni, scrisse: “Parlare di bodegas grandiose non è davvero esagerato. Là veramente, più che grandioso, si può dire che tutto è colossale”.
Il sogno americano in una botte di vino.
Fra gli italiani che giunsero negli USA, quelli che arrivano in California furono fra i più fortunati, pur con mille difficoltà. L’ondata più consistente ci fu dal 1850 al 1924, composta soprattutto da liguri, toscani, siciliani, calabresi e piemontesi. Trovarono una terra dal clima molto simile alla loro patria e molti di essi poterono continuare il loro lavoro di contadini e di viticoltori. Non fu semplice: dovettero scontrarsi con forti pregiudizi razziali ed il Proibizionismo, ma diversi riuscirono ad imporsi, contribuendo a creare in California un settore viti-vinicolo fiorente.
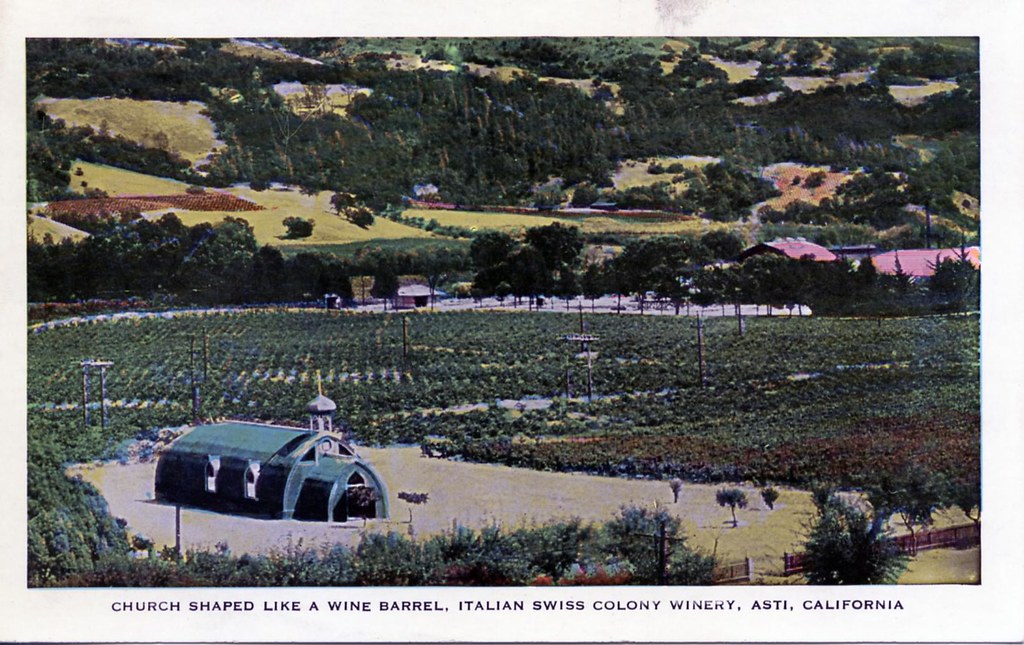 Nella “Raccolta dei Rapporti sull’emigrazione e colonie” del governo italiano del 1909, si legge che in California c’erano dai 6 mila ai 7 mila piccoli agricoltori italiani, sparsi nelle diverse contee, soprattutto intorno a San Francisco. Coltivavano con successo soprattutto frutta, cereali ed ortaggi, a Sonoma la vite. Negli anni ’60 le famiglie di origine italiana detenevano il 50% delle aziende vitivinicole californiane (oggi il 15%). Non a caso nacquero cittadine e località dai nomi evocativi, come Asti o Chianti.
Nella “Raccolta dei Rapporti sull’emigrazione e colonie” del governo italiano del 1909, si legge che in California c’erano dai 6 mila ai 7 mila piccoli agricoltori italiani, sparsi nelle diverse contee, soprattutto intorno a San Francisco. Coltivavano con successo soprattutto frutta, cereali ed ortaggi, a Sonoma la vite. Negli anni ’60 le famiglie di origine italiana detenevano il 50% delle aziende vitivinicole californiane (oggi il 15%). Non a caso nacquero cittadine e località dai nomi evocativi, come Asti o Chianti.
Nel 1907 l’azienda Italian-Swiss Colony, proprietà di immigrati piemontesi, donò un terreno al vescovo di San Francisco. Lì, gli stessi viticoltori costruirono la chiesa della Madonna del Carmelo (Our Lady of Mount Carmel), usando il legno delle loro botti. La chiesa stessa fu realizzata a forma di una (mezza) grande botte di vino.
Bibliografia:
“L’emigrazione italiana in un bicchier di vino. Tra viti, vini e culture”. Autori: Flavia Cristaldi, Sandra Leonardi, Delfina Licata Edizioni Nuova Cultura, 2015
“E andaron per mar a piantar vigneti. Gli Italiani nel Rio Grande do Sul”. Flavia Cristaldi, Tau Editrice, 2015.
“Storia del contributo italiano alla viticoltura sudafricana dalle origini alla contemporaneità”, Claudio Sessa, Diacronie Studi di Storia Contemporanea, n.30, 2, 2017
“I viticoltori italiani: una emigrazione ad alta qualificazione?” Flavia Cristaldi, Rapporto italiani nel Mondo, 2015
https://www.isoladelba.online/storia/elba_da_toscana_a_italiana.asp
https://www.lipari.biz/notizia.asp?idnews=23303
“Storia dell’emigrazione Italiana – Partenze”. A cura di Piero Bevilacqua, A. de Clementi, E. Franzina, Donzelli Editore, 2001.
“L’invasione silenziosa: storia della fillossera nella Sicilia dell’Ottocento”. Salvatore Costanza, Torri del Vento Edizioni, 2015
“L’Italia al di fuori dell'Italia: un altro sguardo sulla viticoltura italiana e le sue ripercussioni in Brasile”. Shana Sabbado Flores, Vagner Da Silva Machado, Vander Valduga and Rosa Maria Vieira Medeiros. Territoires du Vin, 6-2014
“Il contributo dei Veneti allo sviluppo della vitivinicoltura in Argentina e in Brasile”. Rivista La Vigna, n.24, 2014.
"Il paesaggio come risorsa - Castagneto negli ultimi due secoli", Mauro Agnoletti, Edizioni ETS, 2009.
"Il ruolo del vigneto nel paesaggio di Castagneto Carducci fra Ottocento e l'attualità", M. Agnoletti e S. Paletti, in "Paesaggio rurale e sostenibilità. Studi e Progetti" allegato n.15 di Architettura del Paesaggio, ed. Paysage.
Atis, TreStelle Oro della guida Veronelli
Il nostro Atis Bolgheri DOC Superiore 2017 ha ricevuto un importante riconoscimento dalla prestigiosa guida Veronelli 2021, le Tre Stelle Oro. Ne siamo molto orgogliosi. Grazie di cuore a tutto lo staff. Lo hanno assaggiato in anteprima, ricordo che questa annata sarà disponibile a marzo/aprile 2021.
Il nostro Rute ed i TreBicchieri del Gambero Rosso
Michele ed io siamo rimasti stupiti quando abbiamo saputo che il Rute aveva vinto i TreBicchieri. Era andato in finale, come già aveva fatto altre volte, ma non ce lo aspettavamo. Siamo stati sorpresi che il Gambero Rosso abbia deciso di premiare a Bolgheri non solo i vini di lunghissimo invecchiamento e concentrazione, come i Superiori, ma anche i Rossi. Ne siamo contenti, anche perché non si vive di soli vini importanti, che si bevono solo in occasioni particolari.
Così, dopo l’Atis (il Bolgheri Superiore), Jassarte e Criseo, anche il Rute entra nel gruppo dei nostri vini che ricevono riconoscimenti dalla critica. E lo fa alla grande. Conferma, ancora una volta, come tutta la nostra gamma sia di grande valore.
Se devo descrivere Rute (rosso in Etrusco) in una parola, direi eleganza. Purtroppo è molto abusata, anche per vini che sono tutt’altro che eleganti. L’eleganza è fatta da aromi fini e complessi, da una giusta concentrazione alleggerita (ma non banalizzata) da una grande freschezza, che si traduce in verticalità gustativa. Rute è un rosso che ha capacità molto buone di invecchiamento, che possono anche arrivare a 10 anni.
Queste caratteristiche nascono dal Genius Loci delle nostre vigne, fra le colline di Bolgheri: un territorio marino e ventoso, mediterraneo, fatto anche di colline con forti escursioni termiche estive fra il giorno e la notte, suoli alluvionali leggeri, profondi e ben drenati.
Ad ogni modo, vi dico un trucco da addetto ai lavori: la capacità di un’azienda di lavorare bene non si capisce dai vini più importanti. Quelli sono una piccola nicchia, da curare e coccolare. Vorrei vedere che non siano di qualità, vorrebbe dire che si sono fatti errori veramente grossolani.
La qualità di un’azienda si misura veramente sui vini di base. Se si fanno molto bene anche quelli vuol dire che si è capaci di lavorare bene sempre, dove non è facile e scontato. E con un pizzico d’orgoglio, posso dire che il nostro lavoro artigianale è sempre lo stesso: sappiamo curare con estremo amore tutte le nostre vigne e ogni partita di uva che entra in cantina (Michele dice che qui divento un po’ leziosa, sarà!).
Passare dai vini di grande invecchiamento a quelli più giovani, non dovrebbe significare scadere nella qualità dell’uva o lavorare meno bene. Significa lavorare in modo diverso. In vigna, una volta scelte le particelle più adatte per l’uno o l’altro tipo, significa lavorare al meglio per aiutare le viti a trovare equilibri produttivi diversi, più ristretti per l’uno e un po’ più ampi per l’altro, in modo da avere uve con equilibri e concentrazioni differenti, che sprigioneranno al meglio le loro caratteristiche nel tipo di vino che andranno ad originare. Così sarà in cantina: percorsi diversi, più brevi o più lunghi, ma ugualmente curati.
La vinificazione dell'epoca Romana, dove tutto ha avuto inizio II: le pratiche enologiche
Continua da qui
Entriamo ora nel dettaglio dell'enologia dell'epoca Romana.
Le pratiche enologiche
Fra le pratiche enologiche al primo posto non possiamo che mettere il taglio, nel quale sta buona parte dell’arte del bravo cantiniere di ogni tempo. Ad esempio, Plinio cita i Liguri e gli abitanti della zona del Po’ come usi a tagliare i vini troppo aspri con altri più leggeri. I vini di Marsiglia sono citati come ottimi vini da taglio, perché troppo intensi da essere consumati da soli.
Per migliorare vini un po' poveri, la pratica meno invasiva era quella di farli permanere sulla feccia di vino buono. Ad esempio, si racconta che il vino di Sorrento era messo in dolii con le fecce del pregiato Falerno, per dargli più gusto. All’epoca conservavano la feccia di qualità facendola seccare in forno, in pani. L'aggiunta di feccia era anche una classica tecnica del passato per superare i blocchi fermentativi, anche se naturalmente non sapevano di inoculare così dei lieviti.
Avevano poi messo insieme una serie di sostanze da aggiungere al vino con intento migliorativo, soprattutto per la produzione della grande massa dei vini di media-bassa qualità. Come ho raccontato qui, allora si tendeva principalmente a produrre tanta uva, con la conseguenza di avere mosti/vini poveri di diversi elementi o con difetti più o meno accentuati. Diverse di queste correzioni rimarranno alla base dell'enologia moderna, con la differenza (non secondaria) che oggi si usano sostanze purificate. Sono state anche eliminate tutte quelle tossiche. Resta il fatto che i vini migliori (allora come oggi) non ne avevano bisogno, come ci racconta Columella.
 Un'aggiunta comune era quella del mosto cotto, che era lo "zucchero" dell'epoca (insieme al miele). Si otteneva da mosto di uva surmatura che veniva concentrato con una bollitura lenta. Formava così un liquido alquanto zuccherino, scuro, con gusto più o meno caramellato e ricco di profumi. Durante la cottura si potevano anche aggiungere diversi frutti o erbe aromatizzanti. Nella produzione di vino, poteva essere aggiunto al mosto in fermentazione per aumentare la componente zuccherina di uve di bassa qualità. Oggi ricordo che è consentito aggiungere mosto concentrato e rettificato o lo zucchero (quest’ultimo non è ammesso in Italia). Il mosto cotto poteva anche essere aggiunto al vino già finito ed in questo caso si parlava di “vino cotto”. L'uso del mosto cotto rimarrà per tutti i secoli successivi in Italia, soprattutto nel centro e nel sud. La produzione del mosto cotto in epoca romana era però dannosa per la salute, perché era bollito principalmente in pentoloni di piombo. Nella bollitura si forma il diacetato di piombo (sale di piombo dell’acido acetico) che ha un gusto dolce, detto anche zucchero di Saturno, saccharum Saturni (Saturno era il simbolo alchimistico del piombo). La sua ingestione, come altre forme di assimilazione del metallo, può causare gravi problemi di tossicità cronica, con lo sviluppo di una malattia detta saturnismo. Il quadro è molto complesso e comprende danni mentali, l'alterazione di diversi organi e del sangue. C'è chi ha ipotizzato che certe forme di pazzia attribuite ad alcuni imperatori romani potessero essere sintomi di saturnismo.
Un'aggiunta comune era quella del mosto cotto, che era lo "zucchero" dell'epoca (insieme al miele). Si otteneva da mosto di uva surmatura che veniva concentrato con una bollitura lenta. Formava così un liquido alquanto zuccherino, scuro, con gusto più o meno caramellato e ricco di profumi. Durante la cottura si potevano anche aggiungere diversi frutti o erbe aromatizzanti. Nella produzione di vino, poteva essere aggiunto al mosto in fermentazione per aumentare la componente zuccherina di uve di bassa qualità. Oggi ricordo che è consentito aggiungere mosto concentrato e rettificato o lo zucchero (quest’ultimo non è ammesso in Italia). Il mosto cotto poteva anche essere aggiunto al vino già finito ed in questo caso si parlava di “vino cotto”. L'uso del mosto cotto rimarrà per tutti i secoli successivi in Italia, soprattutto nel centro e nel sud. La produzione del mosto cotto in epoca romana era però dannosa per la salute, perché era bollito principalmente in pentoloni di piombo. Nella bollitura si forma il diacetato di piombo (sale di piombo dell’acido acetico) che ha un gusto dolce, detto anche zucchero di Saturno, saccharum Saturni (Saturno era il simbolo alchimistico del piombo). La sua ingestione, come altre forme di assimilazione del metallo, può causare gravi problemi di tossicità cronica, con lo sviluppo di una malattia detta saturnismo. Il quadro è molto complesso e comprende danni mentali, l'alterazione di diversi organi e del sangue. C'è chi ha ipotizzato che certe forme di pazzia attribuite ad alcuni imperatori romani potessero essere sintomi di saturnismo.
 Spesso aggiungevano galle di quercia seccate, escrescenze che si formano sulla pianta in seguito all’attacco di parassiti (i cinipidi, insetti imenotteri). Le galle sono state usate per millenni nella produzione del vino (e non solo) perché contengo un’alta percentuale di tannini. Questi sono presenti naturalmente nell'uva e sono componenti importanti del vino, ma possono essere carenti in prodotti di bassa qualità. Oggi non si aggiungono più le galle ma solo i tannini purificati, così come quelli ottenuti dal legno di quercia o di castagno, da essenze esotiche, dai vinaccioli e dalle bucce dell’uva. I tannini danno un gusto un po’ amaro, per cui vanno dosati accuratamente, ma hanno diversi effetti positivi sul vino: migliorano la struttura e il corpo, hanno una certa azione protettiva (ad esempio proteggono dalla laccasi, un enzima deleterio per il vino, che si può trovare in uve aggredite dalla muffa grigia), aiutano a stabilizzare il colore, ...
Spesso aggiungevano galle di quercia seccate, escrescenze che si formano sulla pianta in seguito all’attacco di parassiti (i cinipidi, insetti imenotteri). Le galle sono state usate per millenni nella produzione del vino (e non solo) perché contengo un’alta percentuale di tannini. Questi sono presenti naturalmente nell'uva e sono componenti importanti del vino, ma possono essere carenti in prodotti di bassa qualità. Oggi non si aggiungono più le galle ma solo i tannini purificati, così come quelli ottenuti dal legno di quercia o di castagno, da essenze esotiche, dai vinaccioli e dalle bucce dell’uva. I tannini danno un gusto un po’ amaro, per cui vanno dosati accuratamente, ma hanno diversi effetti positivi sul vino: migliorano la struttura e il corpo, hanno una certa azione protettiva (ad esempio proteggono dalla laccasi, un enzima deleterio per il vino, che si può trovare in uve aggredite dalla muffa grigia), aiutano a stabilizzare il colore, ...
 Anche l'aggiunta di altri elementi vegetali aveva un effetto positivo dovuto all'apporto dei tannini, come ad esempio i i noccioli d’oliva oppure l’elleboro nero e bianco (che contiene acido gallico). All'epoca si pensava che questa ranuncolacea avesse effetti conservanti sul vino e che giovasse alla salute. In realtà l’elleboro bianco contiene anche un allucinogeno altamente tossico. Eppure il suo uso è citato spesso nell’antichità, per rischiarare la mente secondo Petronio Arbitro (nel Satyricon) o come rimedio alla pazzia per Orazio (Terza Satira, Libro II) o contro l’epilessia. L’elleboro nero invece è meno dannoso.
Anche l'aggiunta di altri elementi vegetali aveva un effetto positivo dovuto all'apporto dei tannini, come ad esempio i i noccioli d’oliva oppure l’elleboro nero e bianco (che contiene acido gallico). All'epoca si pensava che questa ranuncolacea avesse effetti conservanti sul vino e che giovasse alla salute. In realtà l’elleboro bianco contiene anche un allucinogeno altamente tossico. Eppure il suo uso è citato spesso nell’antichità, per rischiarare la mente secondo Petronio Arbitro (nel Satyricon) o come rimedio alla pazzia per Orazio (Terza Satira, Libro II) o contro l’epilessia. L’elleboro nero invece è meno dannoso.
Plinio racconta che in Africa si usava aggiungere al vino il gesso, che veniva poi eliminato per sedimentazione. L’aggiunta di gesso è una pratica che è stata usata comunemente fino a non molto tempo fa, denominata "gessatura". Era tipica delle zone molto calde, come il sud Italia e la Spagna. Si spargeva il gesso anche direttamente sopra le uve, durante il trasporto o in fase di pigiatura. Questa aggiunta (ricordo che il gesso è solfato di calcio) ha un’azione acidificante, con l'effetto secondario di ravvivare il colore e di chiarificare il vino. La carenza di acidità è infatti un problema che si può avere spesso in uve prodotte in climi caldi. Il gesso sviluppa anche lentamente acido solforico nel vino, per cui ha anche una certa azione conservante. Porta però ad un accumulo di solfati, che sono tossici al di sopra di certe quantità. Oggi non è più usata. Un altro prodotto usato come acidificante in epoca Romana e moderna era l'allume (solfato doppio di alluminio e potassio con 12 molecole di acqua di cristallizzazione), anch'esso non più utilizzato.
Al contrario, per togliere acidità (un problema soprattutto delle uve dei climi più freschi o non ben mature) aggiungevano polvere di marmo o la calce. Entrambi apportano al vino carbonato di calcio, una sostanza utilizzata per millenni come disacidificante del vino. Ancora oggi è usata, è la più economica, ma comporta diversi problemi come la liberazione di una quantità eccessiva di anidride carbonica. Oggi si preferisce in genere il tartrato di potassio o altro.
Aggiungevano molti tipi di ceneri (incenso arso, cenere di radici di viti, gusci d’ostriche arse, cedro arso, ...). Tutte queste sostanze portano all'incremento di diversi sali. L'effetto è quello di aumentare l'estratto secco e, quindi, di dare più corpo al vino. Anche queste aggiunte sono state usate a lungo nel passato ma oggi sono pratiche illegali.
Per gli autori romani tutte queste sostanze davano un generico miglioramento del vino: argilla, latte, albumi, farina di pisello selvatico (rubiglio), ... Le ho raggruppate perché oggi sappiamo che hanno tutte la stessa funzione. Sono le "antenate" di diverse pratiche enologiche in uso ancora oggi, con funzione chiarificante, affinante e stabilizzante. In generale, smussano l’eccesso di tannini (il vino è meno duro) e migliorano gli aromi. Oggi si usa ancora l'argilla ma purificata, come la bentonite o altri prodotti simili. Anche le proteine di origine animale sono un grande classico di tutti i tempi, come l'albume di uovo sbattuto (albumina), anche se oggi c'è l'obbligo di indicarli in etichetta come allergeni. Dopo millenni di utilizzo, il latte non è più usato tal quale, ma oggi c'è ancora chi impiega un suo estratto, il caseinato di potassio. Le farine di leguminose, soprattutto di piselli, erano usate tal quali fino a non molto tempo fa; oggi si usano estratti proteici vegetali, che derivano ancora soprattutto da queste piante.
Altre aggiunte invece riguardavano la produzione di vini considerati particolari, che non erano mai tagliati con quelli normali. L'aggiunta di diverse erbe serviva a produrre vini aromatizzati, come quelli fatti con incenso, rose, assenzio e tanto altro.
Diversi vini importati dalla Grecia, come quelli di Chio, di Coo o il Corineo (da Rodi) erano mescolati ad acqua di mare, purificata per decantazione. I Romani presero dai Greci questo uso, ma in quantità più contenute. Ritenevano che la salatura dovesse essere molto precisa, perché l'eccesso rendeva il vino poco piacevole e anche dannoso per la salute. Aggiunte simili sono state fatte anche fino a non tanto tempo fa, con acido cloridrico o sale da cucina. Oggi sono pratiche vietate. Servivano ad aumentare i cloruri del vino, che possono essere un po’ già presenti (in modo diverso a seconda delle varietà e del territorio), con un effetto di aumento della sapidità e dell’estratto secco (per un vino più corposo).
 Un altro ingrediente di alcuni vini romani era la pece (resina) vegetale. Oltre che essere usata per rivestire tutti i contenitori vinari, a volte era aggiunta proprio nel vino, per un prodotto particolare chiamato resimato o impeciato. Questa pratica derivava anch'essa dalla Grecia, dove ancora oggi è prodotto un vino resinato chiamato retsina. Oggi si usa solo la resina del pino d’Aleppo, ma nell'epoca antica si usavano tante essenze diverse, come la trementina o terebinto (essudato del Pinus palustris e altre Pinacee), il mastice dei lentischi, la resina derivata dai semi dell'ambretta o abelmosco (una malvacea orientale), ecc. I diversi tipi di resina erano dissolti nell’olio d’oliva e con esso si conciava il mosto o il vino. L’aggiunta di resina sembra nascere dal fatto che abbia una certa azione antisettica, che determina un’azione protettiva durante la fermentazione, oltre che un’azione conservante. Causa però una forte aromatizzazione del vino, non a tutti gradita.
Un altro ingrediente di alcuni vini romani era la pece (resina) vegetale. Oltre che essere usata per rivestire tutti i contenitori vinari, a volte era aggiunta proprio nel vino, per un prodotto particolare chiamato resimato o impeciato. Questa pratica derivava anch'essa dalla Grecia, dove ancora oggi è prodotto un vino resinato chiamato retsina. Oggi si usa solo la resina del pino d’Aleppo, ma nell'epoca antica si usavano tante essenze diverse, come la trementina o terebinto (essudato del Pinus palustris e altre Pinacee), il mastice dei lentischi, la resina derivata dai semi dell'ambretta o abelmosco (una malvacea orientale), ecc. I diversi tipi di resina erano dissolti nell’olio d’oliva e con esso si conciava il mosto o il vino. L’aggiunta di resina sembra nascere dal fatto che abbia una certa azione antisettica, che determina un’azione protettiva durante la fermentazione, oltre che un’azione conservante. Causa però una forte aromatizzazione del vino, non a tutti gradita.
Curiosamente, mi sono imbattuta nella resina anche in testi enologici più recenti: l'odore resinoso è riportato fra i difetti olfattivi del vino a fine XIX-inizio XX secolo. Il prof. Antonio Sannino racconta che si riscontra di frequente nei vini Trentini, per via dell'uso di tini fatti con legno di larice o abete.
Le pratiche enologiche erano nate per migliorare la produzione ma, nel tempo, con la crescita del settore e degli interessi economici in gioco, degenerarono anche verso adulterazioni e contraffazioni sempre più spinte. Affaristi senza scrupoli usavano uve di qualità sempre più scarsa, che erano poi pesantemente "aggiustate" nelle cantine. In particolare, cercavano di coprire i difetti con trattamenti aromatizzanti molto intensi.
Questi eccessi erano riconosciuti e criticati dai Romani stessi. Diversi autori scrivono di non apprezzare certe sofisticazioni eccessive, che stravolgevano il gusto del vino o che ritenevano pericolose per la salute. Questi vini trovavano comunque un mercato fra le classi meno abbienti. Ad esempio, Plinio scrive che i vini provenzali erano completamente alterati dall'intensa affumicatura e dall'aggiunta di troppe erbe, fra le quali temeva che ce ne fossero anche di nocive. Racconta dell'uso di aggiungere aloe al vino per alterare colore e sapore. Alcuni autori scrivono, con sarcasmo, che bevono più volentieri il vino Sabino rispetto a tanti altri, anche se non era fra i più pregiati, perché perlomeno era genuino e non troppo contraffatto. Seppure c'era questa percezione, non fu mai creata una legislazione che regolasse il settore e mettesse un limite alle aggiunte fatte ai vini.
L'invecchiamento

L'invecchiamento dei vini all'epoca Romana (invecchiare = vetustescere) era fatto col calore. Veniva fatto solo per i vini selezionati come i migliori, che erano travasati in anfore chiuse col tappo in sughero ed accuratamente sigillate. Dopo di che, erano lasciate sotto il sole o in ambienti caldi. A Pompei sono state trovate anfore un po' ovunque, dagli atri delle case, sotto ai portici, nei sottotetti, nelle cucine, in locali appositamente scaldati con fornaci (hypocaustum), ... Dopo un certo periodo di questo trattamento, erano messe al fresco delle cellae vinariae. Questi vini così invecchiati, secondo le testimonianze antiche, potevano durare a lungo ed erano considerati fra i vini più rinomati.
Come poteva essere il gusto di questi vini? Possiamo trovare una risposta a questa domanda andando a cercare l'uso del calore per l'invecchiamento in epoche più vicine a noi.
C'è un vino che è prodotto ancora oggi con un sistema che assomiglia molto a quello romano. Si tratta del Madeira, prodotto in un arcipelago del Portogallo che si trova al largo della costa nord-occidentale dell'Africa. Il vino viene potenziato nel grado alcolico con l'aggiunta di alcol di canna da zucchero e poi trattato col calore (intorno ai 50°C) per diversi mesi, in contenitori tenuti in locali riscaldati tramite stufe o lasciati sotto il sole. Questa tradizione non sembra derivare dal ricordo dell'antico uso romano. La storia ufficiale del Madeira racconta che è stata una riscoperta recente, che risale al XVI - XVII sec. In questo periodo il vino dell'isola iniziò ad essere trasportato frequentemente via mare e si accorsero che maturava in modo notevole quando passava per due volte l'Equatore. Ad ogni modo, questo vino ha forti note ossidative ed è molto stabile, capace di lunghissimi invecchiamenti.
Date le fortissime somiglianze produttive, possiamo ipotizzare che i vini invecchiati dei Romani fossero simili al Madeira? Possibile, ma non ne avremo mai la certezza.
L'uso del calore non fu però completamente dimenticato dopo l'epoca antica. Continuò ad essere citato nei testi agrari dei secoli successivi, dal Basso Medioevo in poi, ma non sappiamo se fosse ancora utilizzato o meno. Andrea Bacci ("Storia Naturale dei Vini", 1596) scrive che ai suoi tempi il vino era prodotto in modo molto più semplice rispetto ai sistemi accurati dell'epoca antica, dei quali rimaneva solo una vaga idea. Non possiamo però escludere a priori che questa tecnica non fosse ancora utilizzata da qualcuno.
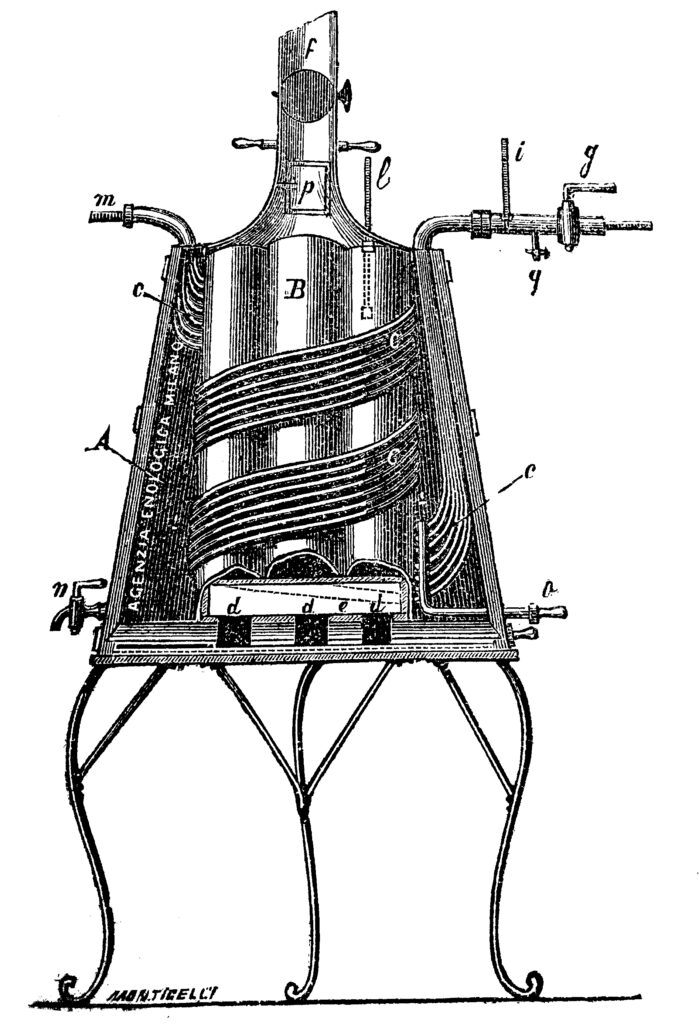
Si tornò però a parlare in modo importante dell'uso del calore per l'invecchiamento dei vini nella seconda metà dell'Ottocento e per buona parte del Novecento. Questo ritorno fu stimolato dagli intensi studi dell'epoca sulla natura della fermentazione (vedete qui), che portarono alle importanti scoperte di Pasteur sul ruolo dei microrganismi nel vino, oltre che dell'ossigeno nell'invecchiamento. Grazie a Pasteur nacque la pastorizzazione, un trattamento termico moderato e di breve durata, usato per la conservazione del vino. Ritornò anche l'idea di usare il calore per l'invecchiamento, anche perchè ci fu un altissimo interesse a trovare vie molto più veloci ed economiche rispetto ai lunghi tempi ed ai costi elevati del passaggio in botti di legno (che in quel periodo infatti andarono un po' in disuso).
Il calore ha un effetto conservante perché elimina i microrganismi e le proteine (gli enzimi) che possono causare le alterazioni del vino. Se al calore si aggiunge l'esposizione più o meno controllata all'ossigeno, si ha anche un effetto di invecchiamento, che viene favorito e velocizzato dall'alta temperatura. Ricordo che alla base dell'invecchiamento del vino c'è sempre un processo di ossidazione. Quando è molto spinto, si hanno vini dal gusto palesemente ossidato. Se minimale, porta a trasformazioni più fini ed eleganti.
Numerosi studi cercarono di definire dei protocolli per un invecchiamento rapido ottimale, definendo i cicli di calore ed i tempi di trattamento. Le temperature erano comprese fra i 40° e gli 80°C, cercando di tenerle il più basse possibile per evitare che il vino prendesse un gusto di "cotto". Si dimostrò, come già sapevano gli antichi, che questa proceduta era attuabile solo con vini di alta gradazione alcolica, di una certa potenza e buona acidità, mentre quelli meno intensi ne erano completamente rovinati. I Romani erano citati solo fugacemente, ma vennero usati diversi sistemi che riconducono ai loro, come stufe per il riscaldamento dell'ambiente o per il bagnomaria delle bottiglie, oltre che l'esposizione al sole. Si assiste anche all'ideazione di macchinari industriali per il riscaldamento in continuo del vino, detti enotermi, per trattare produzioni anche molto consistenti. Vennero studiati anche sistemi che prevedevano il passaggio di correnti elettriche nel vino, pratica detta "elettrificazione", ma furono abbandonati abbastanza presto. Al termine di tutti questi trattamenti, il vino era lasciato per qualche altro mese in cantina a riposare, prima della messa in commercio.

Il sistema dell'esposizione al sole era detto all'epoca "soleggiamento". Era alla portata di tutti, il più economico e il meno tecnologico. Era fatto in contenitori di vetro trasparente, bottiglie o (più spesso) damigiane, non riempite completamente e ben tappate, lasciate sotto il sole per diversi periodi. All'epoca si attribuiva grande importanza all'uso di contenitori trasparenti perché si sottolineava l'azione antimicrobica dei raggi solari sul vino. Noi sappiamo che effettivamente i raggi UV possono avere un'azione sterilizzante, ma anche che passano solo in minima parte attraverso il vetro. L'effetto della luce è soprattutto sul colore.
Ad ogni modo, seppure questi sistemi alternativi furono usati per diverso tempo, i risultati furono sempre abbastanza controversi. Non è facile però capire dai testi degli autori dell'epoca cosa intendessero per un "buon invecchiamento". Ad esempio, il prof. Arturo Marescalchi fece delle prove con vino di Freisa e Barbera nel 1894, lasciando un po' di bottiglie al sole di luglio per 12 giorni, alcune esposte alla luce ed altre coperte da un panno nero, oltre che alcune di controllo in cantina. Per lui il migliore era il vino esposto al calore e alla luce, con un colore mattone-aranciato, molto scarico, che oggi sarebbe considerato come poco qualitativo. Alcuni autori dell'epoca parlano proprio di una madeirizzazione (= ossidazione) più o meno intensa, come positiva. Molti altri però reputavano questo invecchiamento come il sintomo di un processo ossidativo troppo intenso, che uniformizza i vini e fa perdere i tratti unici del territorio e delle varietà.
Il prof. Garoglio, negli anni '60 del Novecento, scriveva che la buona riuscita dell'invecchiamento col calore era discutibile e molto casuale. In certi casi si avevano risultati abbastanza apprezzabili, in altri totalmente disastrosi. Al suo tempo era ancora in uso, ma stava andando a sparire. Dagli anni '60-'70 ritornò invece a crescere l'uso dell'invecchiamento in botti di legno, grazie anche alle rinnovate capacità economiche delle aziende vitivinicole. Anche la pastorizzazione ai soli fini conservativi venne sempre più abbandonata per il vino, mentre è rimasta per altri alimenti (come il latte, la birra ed i succhi di frutta). È ancora permessa, forse c'è chi la usa, ma senza troppa pubblicità perché non è considerata una pratica molto qualitativa.
I vini di recupero
 Nei tempi antichi non si sprecava proprio nulla e si producevano vini di qualità ancora più infima, per i più poveri e gli schiavi. Queste pratiche della vita frugale contadina rimarranno comunque in uso per secoli.
Nei tempi antichi non si sprecava proprio nulla e si producevano vini di qualità ancora più infima, per i più poveri e gli schiavi. Queste pratiche della vita frugale contadina rimarranno comunque in uso per secoli.
Ad esempio il vino protropo si faceva col mosto che Columella chiama lissivo, cioè quello che scorreva per primo per il peso delle uve che erano accumulate via via nel palmento. Oggi, sarebbe come fare vino con quella “brodaglia” che rimane sul fondo delle cassette dell'uva, soprattutto se sono state un po’ troppo maltrattate.
I vini secondi, detti anche lora, erano quelli che si ottenevano dalle vinacce (che erano già state abbondantemente strizzate) o le fecce (Catone lo chiama vin fecato). Fecce o vinacce erano lasciate a bagno per diversi giorni in acqua. Le vinacce erano poi nuovamente pressate ed il liquido veniva vinificato. Ne uscivano vini molto leggeri, di bassissimo costo, usati spesso per i servi e gli schiavi.
La pratica dei "vinelli" prodotti da vinacce e fecce ripassate è rimasta comune nei secoli. La loro produzione e vendita, per il consumo, fu vietata definitivamente in Italia nel 1925 (regio decreto n.2033 del 15/10/1925), perché generevano molte frodi (era difficile distinguerli dai vini fatti con uva, di scarsa qualità). In questo periodo erano ancora chiamati vini secondi o di ripasso.
Direte, ma chi beveva certi vini?
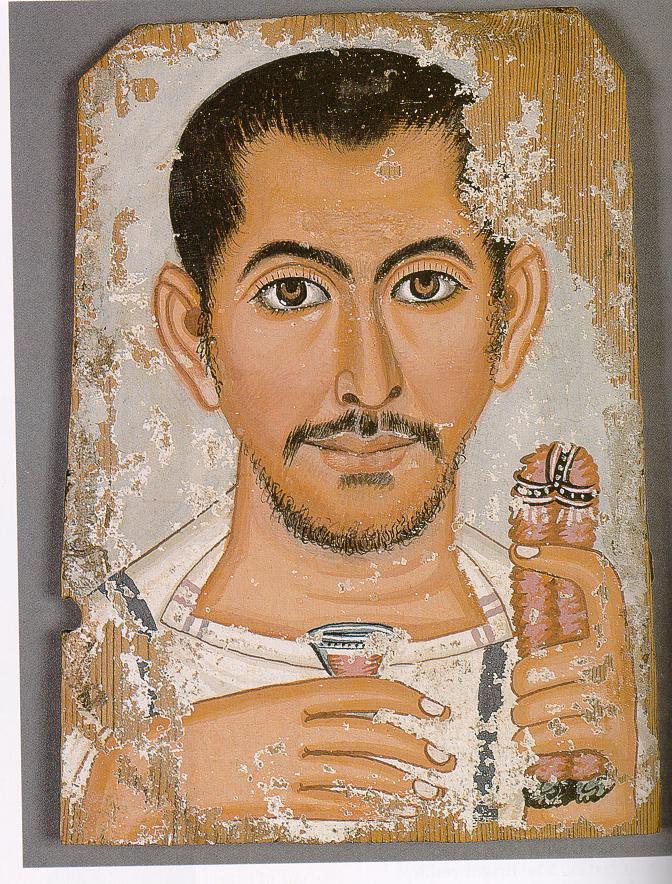
Considerate che, fino a non tantissimi decenni fa, bere vino di qualità per piacere, come facciamo oggi, era solo un privilegio da ricchi. Tutti gli altri bevevano vini che andavano da una qualità media a pessima, fino ai vinelli di ripasso.
Nel passato, anche il vino peggiore aveva una sua valenza. Aggiungeva qualche caloria in più a pasti spesso troppo leggeri, oltre che dare un po' più di sapore e un leggero "brio" alcolico. Inoltre, questi vinelli da tutti i giorni erano considerati più salutari del bere solo acqua. Oggi sappiamo perché: anche una bassa gradazione alcolica proteggeva un po' più dalle contaminazioni microbiologiche, che invece nell'acqua erano molto frequenti e rischiose.
Abbiamo parlato di tanti vini prodotti in antichità, con tecniche che sono arrivate fin quasi ai nostri giorni. Alcuni erano molto buoni, altri così e così, alcuni pesantemente adulterati, altri ancora abbastanza inconsistenti. Che si bevesse per piacere, per salute o per ogni altro motivo, chiudiamo qui il discorso col brindisi romano:
"Bene vos!", "Bene nos!", "Bene te!", "Bene me!"
(Plauto, Stichus, 709)
BIBLIOGRAFIA
“L’agricoltura di Lucio Giunio Moderato Columella” volgarizzata da Benedetto del Bene, con annotazioni adattate alla moderna agricoltura e con cenni sugli studi agrari d’Italia del cav. Ignazio Cantù, Milano, dalla Tipografia di Giovanni Silvestri, 1850.
“De re rustica”, Lucio Giunio Moderato Columella (60-65 d.C.), tradotto da Giangirolamo Pagani, 1846
“Interventi di bonifica agraria nell’Italia romana”, a cura di Lorenzo Quilici e Stefania Quilici Gigli, ed. L’Erma di Bretchneider, 1995.
“Il vino nel «Corpus iuris» e nei glossatori”, Cornelia Cogrossi, (2003) In: La civiltà del vino. Fonti, temi e produzioni vitivinicole dal Medioevo al Novecento. Atti del convegno (Monticelli Brusati, Antica Fratta, 5-6 ottobre 2001). Centro culturale artistico di Franciacorta e del Sebino, Brescia, pp. 499-531.
“Storia dell’agricoltura italiana: l’età antica. Italia Romana” a cura di Gaetano Forni e Arnaldo Marcone, Edizioni Polistampa, 2002
“Terra e produzione agraria in Italia nell’Evo Antico”, M. R. Caroselli.
“Origini della viticoltura”, Attilio Scienza et al., Atti del Convegno, 2010.
“La viticoltura e l’enologia presso i Romani”, Luigi Manzi, 1883.
“Storia della vite e del vino in Italia”, Dalmasso e Marescalchi, 1931-1933-1937.
“Storia del paesaggio agrario italiano”, Emilio Sereni, 1961.
“Il vino nella storia”, Enrico Guagnini, 1981.
Hugh Johnson, “Il vino, storia, tradizioni, cultura”, 1991
Tim Unwin, “Storia del Vino “, 1993
Antonio Saltini, “Storia delle pratiche di cantina, Enologia antica, enologia moderna, un solo vino o bevande incomparabili?”, Rivista di Storia dell’Agricoltura a. XXXVIII, n. 1, giugno 1998
E. Chioffi, “Anfore, archeologia marina”, Egittologia.net
“Storia dell’agricoltura italiana: l’età antica. Italia Romana” a cura di Gaetano Forni e Arnaldo Marcone, Edizioni Polistampa, 2002
“Terra e produzione agraria in Italia nell’Evo Antico”, M. R. Caroselli.
"Il vino da pasto e da commercio", di Ottavio Ottavi, 1875, Tipologia Sociale del Monferrato, Casale.
"Trattato completo di enologia", di Antonio Sannino, 1914, Stabilimento di Arti Grafiche, Conegliano.
"La nuova enologia" di Pier Giovanni Garoglio, 1963, Istituto d'Industrie Agrarie, Firenze.
La vendemmia della vigna Campo Bianco
Campo Bianco è la vigna dove nasce Criseo, una complantazione di 5 varietà bianche: Vermentino, Fiano, Verdicchio, Manzoni Bianco, Petit Manseng. La vigna è raccolta tutta insieme e l'uvaggio è co-fermentato, per originare un vino unico ed "antico".








È iniziata la vendemmia
Ieri, 15 settembre, abbiamo dato il via ufficiale alla vendemmia 2020.
Fra ieri e oggi abbiamo raccolto la vigna Campo Pietrini, dove c’è il Vermentino, la nostra principale varietà bianca, oltre che la più antica del nostro territorio.
L’uva è bella e sana, per una vendemmia che si sta prospettando molto interessante.









Orario di apertura autunnale
Le giornate si accorciano e la vendemmia è alle porte, per cui cambiamo i nostri orari di apertura: dal lunedì al sabato, orario 10.00-13.00 15.00-18.00.
Visite e degustazioni sono solo su appuntamento. La domenica sono possibili tour guidati per gruppi di almeno 6 persone.
Vi aspettiamo!
La vinificazione dell'epoca Romana, dove tutto ha avuto inizio I: entriamo in cantina
Eravamo rimasti al gusto del vino romano (vedi qui), poi abbiamo passeggiato a lungo fra le vigne dell'epoca (vedi qui, qui, qui, qui qui, qui). Entriamo finalmente in cantina.
[one_second][info_box title="" image="" animate=""]Il consumo del vino a Roma: sobrietà o vizio?

Nel nostro immaginario spesso associamo il vino dell'epoca romana ai banchetti, con ubriachi in toga che vomitano anche l’anima, complici tanti film o rappresentazioni che esaltano i vizi del mondo antico.
In realtà, è vero che il vino era consumato tanto in epoca romana, ma in genere in modo sobrio. La cultura prevalente era quella che, più o meno, è rimasta in Italia: il vino si beveva quasi esclusivamente ai pasti e senza esagerare, sempre diluito con acqua (per stemperate le alte gradazioni dell'epoca). Le uniche eccezioni, come oggi, erano le feste, i banchetti. Comunque, gli eccessi di certi ricchi non erano certo la norma.
Il vizio dell’ubriachezza, detto temulentia (da temetum la parola più antica per vino in etrusco e latino) era piuttosto mal visto socialmente. Ad esempio, Ottaviano accusò spesso Marco Antonio di amare troppo il vino, utilizzando quest'arma per screditarlo politicamente. Che fosse vero o no, la nomea di ubriacone gli è rimasta appiccicata nella storia.
C'è stata comunque una grande evoluzione del consumo nei secoli. Nelle epoche più antiche il vino non era abbondante, sia perché la produzione era ancora limitata, sia per via del clima più rigido (vedete qui i cambi climatici di epoca romana). Per i Romani più antichi il vino era quindi un bene di lusso, riservato quasi solo ai banchetti, per eventi sociali e religiosi. Col tempo e l'espansione produttiva, verrà introdotto sempre più nei pasti comuni. Seneca racconta che gli avi di solito si concedevano un po’ di vino solo alla fine del pasto e consideravano dei ghiottoni quelli che lo bevevano anche durante.
I cos tumi rigidi della Roma più antica vietavano il vino alle donne. Il vino era associato alla perdita del controllo, quindi al rischio di adulterio da parte della moglie. Ai tempi di Romolo, tale Egnazio Mecenio uccise la moglie a bastonate perché beveva vino e fu addirittura lodato per la "punizione esemplare". Più avanti nella storia di Roma, le donne non rischiavano più la vita solo per un po’ di vino, ma per le signore "per bene" era comunque accettato socialmente solo un consumo moderato. Le cronache giudiziarie riportano, ad esempio, il caso di una donna che venne multata dal giudice, con la perdita della dote, perché aveva bevuto di nascosto più vino "di quanto fosse ritenuto necessario per la salute".
tumi rigidi della Roma più antica vietavano il vino alle donne. Il vino era associato alla perdita del controllo, quindi al rischio di adulterio da parte della moglie. Ai tempi di Romolo, tale Egnazio Mecenio uccise la moglie a bastonate perché beveva vino e fu addirittura lodato per la "punizione esemplare". Più avanti nella storia di Roma, le donne non rischiavano più la vita solo per un po’ di vino, ma per le signore "per bene" era comunque accettato socialmente solo un consumo moderato. Le cronache giudiziarie riportano, ad esempio, il caso di una donna che venne multata dal giudice, con la perdita della dote, perché aveva bevuto di nascosto più vino "di quanto fosse ritenuto necessario per la salute".
Nel tempo comunque la produzione di vino aumentò sempre più, arrivando a grandi produzioni di vino di bassa qualità per le masse e una piccola élite di vini raffinati per i ricchi, ed i costumi si fecero sempre meno severi. Il consumo di vino divenne la consuetudine a tutti i pasti. Nelle Satire di Varrone (I sec. a.C.) si scherza sul pasto senza vino, chiamandolo “prandium caninum”, il pasto dei cani (che non bevono di certo vino).
Arriviamo quindi all'epoca Imperiale, con gli eccessi celebrati nei tanti film in toga, dei quali Plinio dice di vergognarsi anche dal riferire. Nei casi più estremi, si poteva arrivare ad infilarsi una penna in bocca per indurre il vomito e poter ricominciare a bere e a mangiare.
Durante i banchetti, che non erano necessariamente sempre sfrenati, era uso brindare agli Dei, agli amici, agli innamorati o al potente di turno. C’era anche l'uso del nomem bibere: bere tanti bicchieri quante erano le lettere del nome dell’amata o del potente a cui si dedicava il brindisi.
Plinio riporta anche l’uso di “bere le corone”, cioè gli amanti si scambiavano coppe di vino con dentro i petali delle loro corone di fiori ed erbe. Queste corone vegetali, diventate di uso comune ai banchetti, erano nate dalla credenza che, portandole, avrebbero impedito l'ubriachezza. Nel tempo diventarono anche oggetti di lusso, fatte con i fiori più rari e profumati.
Fra le tante leggende nere che circolavano su Cleopatra, si racconta di quella volta che, offesa da Antonio, provò ad avvelenarlo, offrendogli la coppa con i petali della sua corona, che erano stati intrisi di veleno. All'ultimo però si pentì e lo bloccò, prima del sorso fatale. Per dargli comunque una lezione, fece bere la coppa avvelenata, davanti a lui, ad un condannato a morte.

[/info_box][/one_second]
Manca pochissimo alla nostra vendemmia e mi sembra quanto mai appropriato tornare a parlare della vinificazione. Lo faccio però andando alle sue origini, dove tutto ha avuto inizio, cioè all'epoca Romana.
Non vi voglio però raccontare per l'ennesima volta delle anfore in terracotta e altre generalità che conosciamo tutti bene, se non per rapidi accenni. Voglio invece entrare veramente in una cantina dell'epoca, con l'occhio del produttore di vino, e capire le loro tecniche, al di là di miti e pregiudizi.
Avrete di certo letto di chi riporta, con perplessità, che aggiungevano durante la vinificazione tante cose strane: acqua di mare, latte, noccioli d'olive, polvere di marmo, farina di piselli selvatici e altro. In realtà queste pratiche, non sono così assurde come possono sembrare, come vi spiegherò poi. Anzi, rappresentano dei primi approcci rudimentali all'enologia che verrà. In questo periodo nascono infatti diverse delle pratiche enologiche che verranno sviluppate in seguito, sia nel bene che nel male, con sofisticazioni dei vini anche eccessive.
In generale, possiamo dire che al loro apice i Romani avevano una produzione di vino tecnicamente curata, come vedrete, tolti quei diversi aspetti che ci sono incomprensibili (soprattutto per la scarsità d'informazioni) e non trascurando i limiti oggettivi dell'epoca. Questo livello produttivo verrà perso nell'Alto Medioevo, con un netto peggioramento della qualità, e verrà riconquistato solo dopo qualche secolo, prima del salto definitivo verso l'enologia moderna.
Luci ed ombre
Al momento dell'apice, producevano diverse tipologie di vino: fermi, effervescenti, secchi, dolci, passiti, ... Tutti questi vini erano abbastanza buoni da essere bevuti tal quali, a parte la solita diluizione con acqua (necessaria per stemperate le alte gradazioni dell'epoca, visto che spesso raccoglievano le uve surmature; si tratta comunque di un sistema naturale di conservazione). Non siamo più nelle epoche più antiche, quando le tecniche produttive erano primitive ed i vini erano così "cattivi" da dover essere sempre corretti al momento del servizio con erbe, spezie e miele ed altro (vedete qui), per renderli bevibili. L’addolcimento col miele rimarrà, ma solo per un "cocktail" particolare, detto mulsum, servito come aperitivo. Rimarranno anche i vini alle erbe, per uso medicinale o per piacere, ma erano prodotti specifici.
La produzione di vino romana si è quindi evoluta notevolmente nei secoli, partendo da sistemi primitivi. Lo ha fatto integrando la conoscenza del tempo (gli autori latini citano molte referenze di testi greci, che a noi non sono pervenuti), attraverso la sperimentazione empirica, oltre che una notevole evoluzione tecnologica degli strumenti (di cui ho già raccontato qui, parlando degli Etruschi). I più avanzati torchi romani non cambieranno praticamente più fino al XIX sec.
Il periodo di apice è rappresentato dai testi dei soliti Columella e Plinio (come abbiamo già visto per la parte di viticultura), della seconda metà del I sec. d.C. Questi testi descrivono una produzione del vino accurata, senza però concederci molti dettagli e spiegazioni. Puntano l'attenzione soprattutto sulle pratiche finalizzate al miglioramento dei vini di bassa qualità, la grande massa della produzione. Accennano anche ad una piccola nicchia di vini di grande pregio che, scrivono, non avevano bisogno di nessuna correzione in fase di vinificazione.
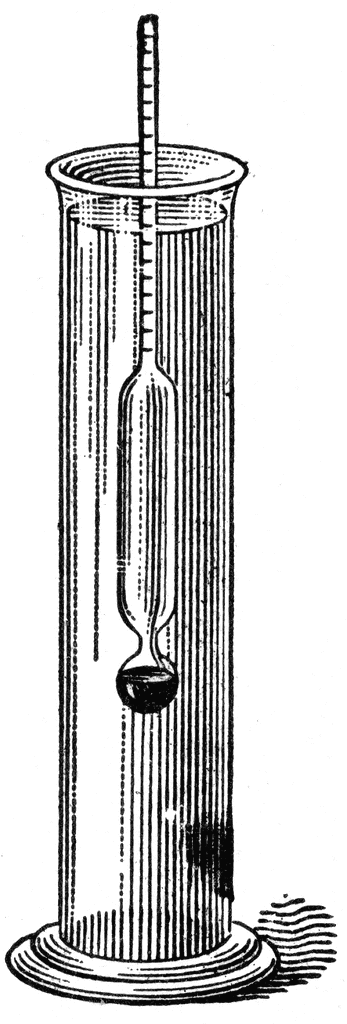
Nel periodo successivo ci saranno solo alcune evoluzioni tecnologiche, come l’invenzione del densimetro, detto allora hydroscopium, uno strumento per valutare la densità dei liquidi. Per quanto ci riguarda, è usato per misurare lo zucchero e l'alcol di mosti e vino (a lato, un disegno di un densimetro più moderno). È citato per la prima volta da Sinesio, in una lettera scritta alla sua maestra Ipazia, a cavallo del IV-V secolo d.C. Sembra però che l’uso comune risalga al VI sec., come racconta il grammatico Prisciano. Questa ed altre conoscenze verranno perse nei secoli successivi. Uno strumento simile verrà di nuovo inventato solo all'inizio del XVII sec.
Rimangono comunque diversi aspetti inspiegabili per noi nella produzione del vino dell'epoca romana. Il più eclatante è rappresentato da quei poeti che decantano vini dall’incredibile invecchiamento, anche di centinaia di anni. Considerando che neppure oggi è possibile avere vini così longevi (che restino bevibili e piacevoli), probabilmente erano solo iperboli o licenze poetiche.
Alcuni passaggi importanti della vinificazione sono totalmente omessi nei testi antichi. Ad esempio non sono mai descritte le macerazioni delle bucce. Questo fatto ha tratto in inganno diversi autori moderni di storia del vino, facendogli scrivere che, all'epoca, si producessero solo vini bianchi. In realtà gli autori latini parlano di un'ampia gamma di colori. Plinio scrive di vino bianco, fulvo (orange wine?), sanguigno (rosso) e nero. Galeno aggiunge anche il rosso pallido (rosato?) ed il pallido, che descrive come una via di mezzo fra il bianco e il fulvo.
Ad ogni modo, i Romani hanno di certo gettato le basi di certe pratiche enologiche, come vedremo, ma non sapevano perché le facevano o perché aggiungevano certe sostanze, non avendo conoscenze chimiche sulle composizioni dei mosti e dei prodotti che utilizzavano. Potevano giusto apprezzarne i risultati finali. L'altro limite insormontabile dell'epoca era l'assoluta ignoranza sulla fermentazione, oltre che sulle alterazioni microbiologiche.
Quindi, potevano essere anche bravi a fare alcuni vini, ma erano sempre in balia della fortuna e del caso. Se qualcosa andava storto, non sapevano porvi rimedio e semplicemente declassavano il vino. Questa fragilità produttiva non appartiene però solo dell'epoca romana, rimarrà molto a lungo. Si inizieranno a capire (e a gestire) questi processi solo con le scoperte di Pasteur sul ruolo dei microorganismi nella produzione enologica, ma dovremo aspettare fino alla seconda metà del XIX secolo. (Se vi interessa scoprire il lungo ma affascinante percorso che ha portato alla comprensione del processo della fermentazione, vi invito a leggere questa mia serie di post, qui, qui, qui, qui).
Infine, non dimentichiamo che, come in ogni epoca passata, coesistevano diverse realtà: le cantine più ricche e dotate degli strumenti più all'avanguardia, quelle (di ogni dimensione) gestite da persone istruite o comunque esperte, fino ai tanti contadini che continuavano a fare il vino in modo molto primitivo.
Alcuni concetti-chiave
I Romani avevano già raggiunto una certa consapevolezza riguardo alcuni concetti chiave della produzione del vino, che verranno recuperati solo secoli dopo la fine dell'era antica.
Primo fra tutti, c'è l’importanza della pulizia. Di certo non sapevano dell'esistenza dei microorganismi, non avevano i nostri prodotti sanificanti, l’acqua corrente nelle cantine e tante altre cose. Avevano però intuito quanto fosse importante pulire tutto per bene. La cura e la perfetta pulizia di ogni contenitore ed attrezzo, prima e dopo ogni uso, è una “mania” per gli autori romani, fin dai tempi più antichi di Catone. Tale modo di operare verrà recuperato, in epoca moderna, solo abbastanza recentemente. La pulizia dei contenitori del vino era facilitata dal rivestimento interno fatto con resina vegetale, rinnovata ad ogni uso, dopo aver raschiato a fondo quella vecchia. Raccomandavano anche di ripulirli attentamente da ogni odore residuo. In una cantina di Stabia, trovata totalmente integra dall’archeologo Fiorelli a fine Settecento, il locale di lavorazione delle uve era rivestito sul pavimento e sulle pareti da un materiale fatto da mattoni triturati e calcina, fino a circa un metro e ottanta d’altezza, col limite segnato da una riga rossa. La calce è il sistema più antico per igienizzare le pareti soggette ad umidità. La sua alcalinità evita lo sviluppo di muffe ed altri microrganismi.

Avevano intuito anche l’importanza della temperatura nel corso della vinificazione. Columella consiglia di portare i contenitori vinari in luoghi caldi o freddi a seconda della necessità o di avere dolii in posizioni diverse. Scrive che, se toccando il dolio si sente salire troppo la temperatura, sicuramente non si avrà una buona vinificazione. Oggi sappiamo che i lieviti fermentativi agiscono bene a determinate temperature. Soprattutto quelle troppo alte possono compromettere il processo. In una cantina di Pompei è stato trovato un sistema ingegnoso per raffreddare le anfore vinarie. Queste era appoggiate ad un’intercapedine in argilla nella quale veniva fatta scorrere acqua fresca. Nella descrizione della produzione di vini spumanti dolci, si legge che le anfore, ben sigillate, erano trasferite ad un certo punto in vasche d’acqua fredda (per bloccare la fermentazione e lasciare un residuo zuccherino). Come ancora oggi, il freddo era un'alleato dei cantinieri per favorire i processi di sedimentazione e poi travaso dei vini. Nei testi tardo-antichi, si sottolinea l'importanza di realizzare le cantine in modo che siano sempre fresche. Se così non era, in passato bisognava sfruttare i cambi stagionali per fare certe operazioni. Per questo motivo spesso gli autori antichi legano certe pratiche a determinate costellazioni (o altro): non è una questione di astrologia, ma il loro modo per indicare il momento stagionale più opportuno.
Avevano anche capito i rischi dell'ossidazione (per loro una generica alterazione). Infatti gli autori scrivono di evitare di esporre il vino all’aria, soprattutto a temperature calde. Nella descrizione di ogni passaggio di cantina, gli autori insistono molto sul fatto di avere sempre i contenitori accuratamente rivestiti internamente (con resine vegetali) e sigillati.
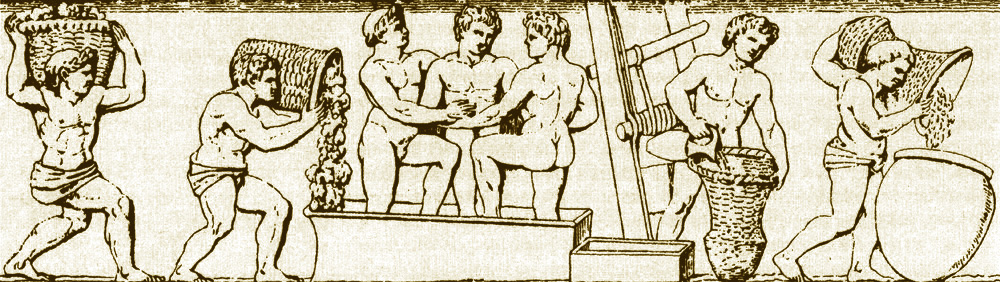
La cantina e la vinificazione
La produzione del vino non era così diversa da quella di una qualunque cantina del passato, almeno fino al XIX sec., salvo che per i contenitori.
L’uva era pigiata coi piedi nei palmenti. Le vinacce o i grappoli interi (chiusi dentro a cestelli in vimini o altro materiale) erano pressati nei torchi. Come sappiamo, i principali vasi vinari, dove il vino completava la fermentazione, erano dei grossi contenitori in terracotta, rivestiti internamente con pece vegetale, parzialmente o completamente interrati, detti dolii (dolium al singolare). Il loro nome più antico era calpar, già non più in uso ai tempi di Varrone (I sec. a.C.). Esistevano anche vasche chiuse in muratura, anche se meno diffuse.
A cosa serviva l'impeciatura dei contenitori vinari? Si trattava di un rivestimento interno fatto con resine di origine vegetale, che sono sostante di diversa natura prodotte da numerose piante, a volte in seguito a ferite o attacchi parassitari, per cui è spesso anche un antisettico naturale. Da migliaia di anni sono state usate per gli usi più disparati, prima dell'introduzione delle resine o altri materiali sintetici. Spesso sono anche aromatiche e non sappiamo quanto questo rivestimento influisse o meno sul gusto del vino. Sicuramente serviva a rendere questi contenitori il più possibile inerti, come cerchiamo di fare anche oggi. Il rivestimento in resina sigilla la porosità delle anfore, contro i rischi dell’ossidazione e le rende perfettamente impermeabili ai liquidi. Inoltre garantisce una certa pulizia, contro il rischio di contaminazioni microbiologiche, visto che dopo ogni uso i vasi erano accuratamente raschiati dallo strato di resina vecchio e di nuovo rivestiti.

Durante la vinificazione, ritenevano importante la valutazione della schiuma che si forma sul liquido, per capire se la fermentazione stesse procedendo bene o no. In particolare, descrivono una delle alterazioni più comuni del vino (fino a non tanto tempo fa), la fioretta. La descrivono come una velatura chiara, come una tela di ragno sulla superficie del vino. Il vino così alterato diventava insipido e piatto, con spunto acetico o proprio acetificazione. Può succedere soprattutto per vini a bassa gradazione alcolica che restano troppo in contatto con l'ossigeno. Dipende dallo sviluppo di diverse specie di batteri aerobi.
I vini venivano lasciati riposare dopo la vinificazione e, nel mese di maggio, li travasavano in nuovi vasi impeciati. Durante questo passaggio avveniva la sfecciatura. Era il momento finale per classificare la qualità del prodotto, tramite l'assaggio. Veniva ritenuta molto importante l’acidità. Se era troppo scarsa, non lo si considerava un buon segno per la conservabilità e la qualità in generale del vino (come sappiamo bene anche oggi).
 Il vino di bassa qualità o da bere giovane era in genere messo dentro a nuovi dolii (vinum doliare), ben chiusi, da dove era prelevato di volta in volta per la vendita o il consumo. Da qui era travasato in brocche e vasi di diverso materiale. Per il trasporto via terra, poteva essere messo anche in un grande otre in pelle, detto culleus o uter vini, posizionato su un carro.
Il vino di bassa qualità o da bere giovane era in genere messo dentro a nuovi dolii (vinum doliare), ben chiusi, da dove era prelevato di volta in volta per la vendita o il consumo. Da qui era travasato in brocche e vasi di diverso materiale. Per il trasporto via terra, poteva essere messo anche in un grande otre in pelle, detto culleus o uter vini, posizionato su un carro.
Quello migliore, era invece travasato in anfore e per questo era detto vino anphorariarum. Qui era conservato, invecchiato e trasportato. Le anfore erano sempre impeciate, accuratamente chiuse con tappi in sughero, sigillati con resina, argilla o gesso. Erano identificate da una nota, cioè una scritta a pennello fatta sull'anfora o su una pergamena o una striscia di cuoio. Questa specie di etichetta era detta pittacium. Riportava la tipologia (ad esempio, l'abbreviazione rubr. stava per vino rosso), il luogo di provenienza e l’anno in cui era stato riposto. Soprattutto dal II secolo d.C. in poi, il vino poteva anche essere messo, per la conservazione ed il trasporto, in barili di legno (cupa), ed era detto vinum de cupa. Già Plinio li descrive, nella seconda metà del I sec. a.C., come tipici della zona delle Alpi.
Per spostare i liquidi (mosto e vino) da un contenitore all'altro, si usavano lunghi sifoni, oppure contenitori di trasporto più piccoli (anfore o altro). In cantine più all'avanguardia, come in una trovata a Stabia, il palmento aveva il pavimento inclinato verso un canale di scolo, dove si potevano inserire dei tubi (fistole) in piombo, che portavano il vino nei dolii sfruttando la pendenza. Per assaggiare il vino, si usava uno strumento detto aulon sysetera, fatto in vetro, simile agli alzavino (o pipetta) usati ancora oggi per prelevare piccoli campioni d’assaggio dalle botti.
Per eliminare torbidi e fecce, usavano i sistemi in uso da sempre nelle cantine, cioè i travasi, dopo aver lasciato sedimentare il torbido sul fondo. Per la pulizia e filtrazione dei vini, gli autori ci parlano di un colum o saccus vinarius, un cesto o colatoio fatto in vimini, stuoia o giunchi, a forma di cono (sotto, uno simile ottocentesco).
CONTINUA... (qui) con l'approfondimento delle pratiche enologiche.
BIBLIOGRAFIA
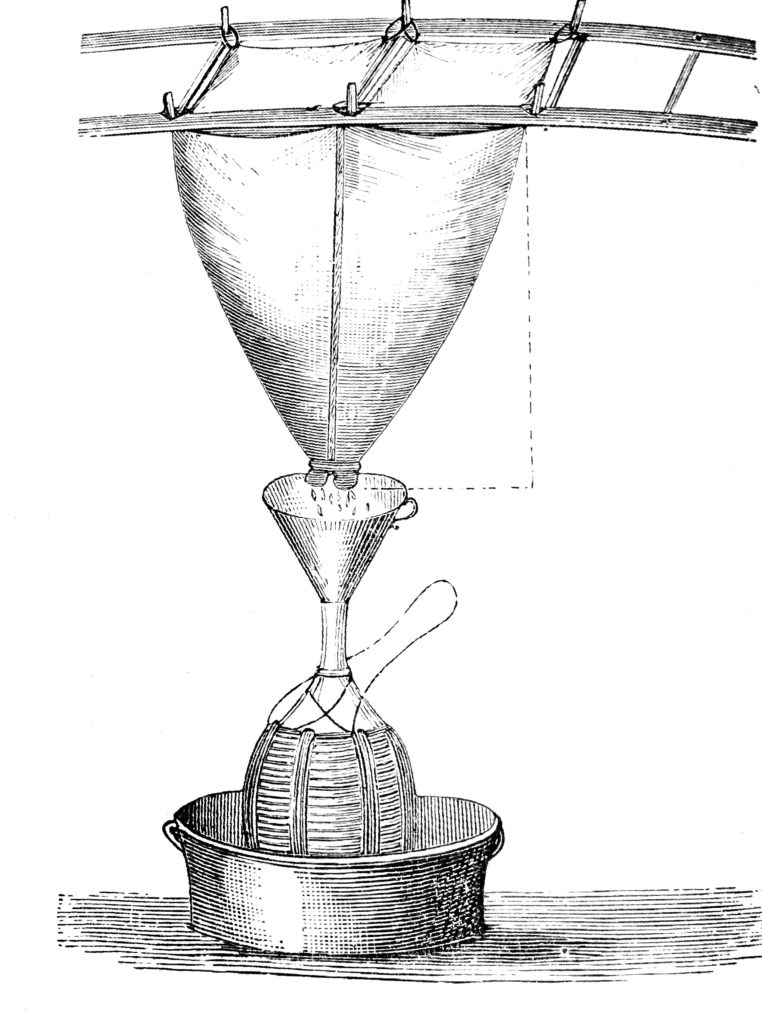
“De re rustica”, Lucio Giunio Moderato Columella (60-65 d.C.), tradotto da Giangirolamo Pagani, 1846
Luigi Manzi “La viticoltura e l’enologia presso i Romani”, 1883
Dalmasso e Marescalchi, “Storia della vite e del vino in Italia”, 1931-1933-1937
Emilio Sereni, “Storia del paesaggio agrario italiano”, 1961
Enrico Guagnini, “il vino nella storia”, 1981
Hugh Johnson, “Il vino, storia, tradizioni, cultura”, 1991
Tim Unwin, “Storia del Vino “, 1993
Antonio Saltini, “Storia delle pratiche di cantina, Enologia antica, enologia moderna, un solo vino o bevande incomparabili?”, Rivista di Storia dell’Agricoltura a. XXXVIII, n. 1, giugno 1998
E. Chioffi, “Anfore, archeologia marina”, Egittologia.net
“Interventi di bonifica agraria nell’Italia romana”, a cura d Lorenzo Quilici e Stefania Quilici Gigli, ed. L’Erma di Bretchneider, 1995.
“Storia dell’agricoltura italiana: l’età antica. Italia Romana” a cura di Gaetano Forni e Arnaldo Marcone, Edizioni Polistampa, 2002
“Terra e produzione agraria in Italia nell’Evo Antico”, M. R. Caroselli.
L’uva non ama la tintarella
In agosto amiamo il mare, cerchiamo il sole, l’abbronzatura. Noi possiamo proteggerci con una buona protezione solare ma l’uva no. Non ama la tintarella o, meglio, l’esposizione diretta ai cocenti raggi solari, che qui da noi (sulla costa toscana) sono particolarmente intensi.
In questo periodo così importante di maturazione delle uve, noi vignaioli valutiamo anche l’esposizione del grappolo. Decidiamo se vale la pena fare la defogliazione, cioè togliere alcune foglie intorno al frutto, quanto farla, oppure se proprio evitarla.

In generale l’uva sta bene un poco coperta da foglie, tuttavia dipende molto dal clima e dalla situazione particolare. Soprattutto nei climi caldi e con intensa radiazione solare, come a Bolgheri (e per buona parte del centro e del sud), se troppo esposta potrebbe andare incontro ad alterazioni anche serie.
La defogliazione (o sfogliatura).

Nei territori più freschi e soprattutto umidi, la defogliazione nelle ultime fasi (dall’invaitura a poche settimane dalla vendemmia) è spesso necessaria. Togliere un po’ di vegetazione serve ad evitare ristagni di umidità, micro-condizioni che possono favorire i terribili marciumi e le muffe del grappolo, con la conseguente perdita dell’uva. Questa necessità può esserci anche da noi, eccezionalmente, nelle annate particolarmente umide.
Di norma comunque una vite in equilibrio non richiede la sfogliatura. Gli studiosi ci danno dei parametri: una copertura fino a circa il 40%-50% dei grappoli va bene, non deve essere eliminata.
Se però la vite è troppo rigogliosa e l’eccesso di foglie scherma completamente i grappoli, la defogliazione può essere favorevole, soprattutto negli ambienti non troppo caldi. In questo caso si è visto (con prove sperimentali) che l’alleggerimento della vegetazione e la migliore esposizione migliorano la maturazione (favoriscono l’aumento degli zuccheri, aumenta il colore, ci sono più aromi primari, meno acidità, un miglior accumulo dei composti fenolici).
Se si decide che è il caso di sfogliare, si deve però anche capire quanto e come togliere, per cui è un lavoro che dovrebbe essere fatto a mano solo da persone esperte, in grado di decidere vite per vite. Spesso il rischio è di togliere troppo.
Le foglie non vanno scelte a caso. Si tolgono principalmente quelle basali, cioè che stanno sotto il grappolo. Sono le più vecchie ma anche quelle non direttamente implicate nella fotosintesi a favore del grappolo in maturazione. Questo ruolo è invece svolto dalle foglie che stanno sopra al frutto, che sarebbe meglio eleminare il meno possibile, salvo quelle veramente troppo ombreggianti.
In generale, è sempre meglio comunque non togliere troppe foglie, altrimenti si limita la capacità di fotosintesi della pianta e, quindi, la qualità dell’uva. Quanto deve essere estesa la chioma? Dipende da tanti fattori: dal clima, dall’intensità della radiazione solare, dalla varietà (ad esempio, influisce anche la dimensione del grappolo), il sistema di allevamento, …
L’eccesso di luce e calore
Nel nostro territorio, se le viti sono in equilibrio, come detto, per lo più evitiamo la sfogliatura: non si hanno quasi mai rischi fitosanitari legati all’umidità, se non in annate particolari. In particolare, vogliamo evitare i danni da eccesso di luce e calore.
Sono stati fatti numerosi studi che hanno dimostrato che, in territori caldi e con intensa radiazione solare, la situazione ottimale per l’uva in maturazione è un microambiente in cui il grappolo riceve luce diffusa, con alcuni lampi di luce che si infiltrano da diverse direzioni fra la vegetazione.
In questi climi non si ha paura dello scarso accumulo delle varie componenti dell’uva. Al contrario, si rischiano più facilmente concentrazioni zuccherine troppo alte, che portano a tenori alcolici troppo elevati, aromi poco eleganti e scarso colore.
Il caldo eccessivo e la siccità, per acini esposti direttamente alla luce solare, possono portare anche a danni gravi. Si possono avere fenomeni di disidratazione degli acini, con la sintesi di aromi poco piacevoli (come di “cotto”), la degradazione di alcuni precursori aromatici, fino a delle vere e proprie scottature, che causano l’imbrunimento e la necrosi dei tessuti del frutto.

Questi danni gravi accadono più spesso a quei grappoli che si sono sviluppati in situazione di luce diffusa e che vengono esposti di colpo alla luce solare. Può succedere per colpa del vignaiolo, che sbaglia qualcosa nella gestione della chioma, ma anche per eventi non voluti (ad esempio la caduta delle foglie per attacchi parassitari, grandine, ecc.).
Il problema non è solo la luce diretta ma anche la temperatura, che ha un ruolo rilevante nella maturazione, soprattutto sul colore e gli aromi, e può diventare eccessiva per i grappoli non sufficientemente protetti dalle foglie. Gli studi hanno dimostrato che temperature estive di 35°-40°C (e oltre) possono inibire la sintesi degli antociani (il colore delle uve rosse) ma anche degradare i pigmenti che sono già stati prodotti. Le alte temperature sembrano causare anche una degradazione dei precursori aromatici (ad es. i carotenoidi), cioè quelle sostanze che non sono aromatiche nelle uve ma lo diventeranno nel corso della vinificazione. Elevate escursioni termiche fra il giorno e la notte, come succede a Bolgheri (soprattutto fra le colline), possono però riequilibrare in modo ottimale anche certi eccessi di calore diurno.
La natura ci dona tanto, ma solo un continuo buon lavoro in vigna permette una maturazione ottimale delle uve. Nonostante ciò, può succedere che qualche singolo grappolo possa sfuggire alla protezione delle foglie di una chioma gestita in modo ottimale. Sarà allora nostra cura non raccoglierlo, con la selezione in fase di vendemmia, come facciamo per ogni acino che non sia più che perfetto.
Cambiamenti climatici, leggi e vendemmie: gli ultimi passi nelle vigne italiane al tempo dei Romani.
(continua da qui)
Concludiamo questo nostro viaggio nella viticoltura italiana dell'epoca Romana con gli ultimi lavori della vigna e la vendemmia.
Prima però vorrei completare il quadro dell'epoca con la descrizione del clima di allora. Spesso non ci si pensa, ma i mutamenti climatici hanno avuto grande importanza negli eventi storici dell'umanità, a maggior ragione per quanto riguarda l'evoluzione dell'agricoltura.
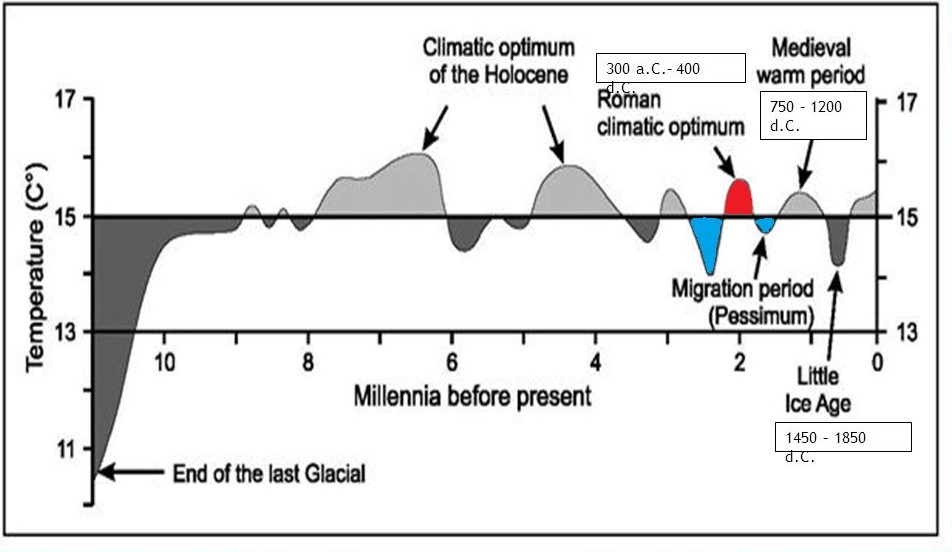
La fondazione di Roma (753 a.C.) cadde in un periodo di piccola era glaciale (nel grafico, il primo picco discendente colorato in blu), durato circa dal 900 al 300 a.C. Questo significa che, nei primi secoli dell'epoca Romana, l'Italia aveva un clima decisamente più freddo di quello a cui siamo abituati oggi. Nel grafico a lato si vedono le temperature medie annuali dall'Era Glaciale ad oggi. La linea verticale in fondo rappresenta il nostro periodo.
Numerosi autori romani testimoniano i terribili inverni di quei periodi. Columella e Giovenale raccontano che all'inizio del IV secolo a.C. gli inverni erano così rigidi che il Tevere era incrostato di ghiaccio. I boschi del Lazio e dell'Etruria erano costantemente ricoperti di neve. L'inverno del 399-400 a.C. rimase nella storia di Roma per via di un'incredibile nevicata. Caddero più di 2 metri di neve (7 piedi) ed i crolli di alberi e tetti in tutta la città causarono numerosi morti e feriti. Varrone racconta di inverni lunghissimi nelle montagne italiane. Sant'Agostino riporta che, ancora nell'inverno del 275 a.C., il Tevere gelò e Roma rimase sotto la neve per 40 giorni.

Come possiamo immaginarci la viticoltura di quel periodo? Non abbiamo molte indicazioni a prosito. Possiamo pensare che era presente soprattutto nelle aree più miti, come le coste o altre zone favorevoli, fino ad altitudini non molto elevate.
Dopo di che il clima si avviò ad un notevole cambiamento, con la risalita delle temperature, fino ad arrivare al momento detto dell'Optimum Climatico Romano, un periodo piuttosto caldo. Durò circa dal 250 a.C. al 400 d.C. e interessò in modo locale l'Europa e l'Atlantico settentrionale. Il passaggio climatico verso temperature più alte corrisponde con l'espansione di Roma nel Mediterraneo. In antichità, infatti, si navigava solo nelle stagioni favorevoli ed il clima migliore permise periodi di navigazione più lunghi. Corrisponde anche all'aumento esponenziale della viticoltura italiana. Il clima più caldo ne permise l'espansione anche in aree prima non favorevoli. Iniziò così anche l'esportazione massiccia del vino.

L'aumento delle temperature determinò, in generale, lo spostamento verso nord della linea delle coltivazioni mediterranee, come l'ulivo. Plinio scrive che il faggio, che prima arrivava solo all'altezza di Roma, spinse il suo habitat fino al nord d'Italia. Il periodo caldo favorì poi la diffusione della viticoltura da parte dei Romani in buona parte d'Europa, anche nei territori che non avevano mai visto prima la vite. La portarono fino in Inghilterra, oltre che a notevoli altitudini. Da molte di queste zone estreme sparirà con la successiva Piccola Era Glaciale.
Dal 400 circa iniziò invece un periodo di raffreddamento. Secondo diversi studiosi, l'instabilità ed i peggioramenti climatici, con le conseguenze sull'agricoltura e la salute della popolazione, contribuirono alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente.
Non si sa esattamente quanto l'attività umana di allora potesse aver influito sulle evoluzioni climatiche. Sappiamo però che l'epoca Romana ha registrato i primi interventi massicci dell'uomo sulla trasformazione del paesaggio naturale italiano.
In epoca pre-romana l'Italia era fatta di immense distese di boschi, interrotti da aree paludose nelle zone costiere o nelle pianure. Solo una piccolissima parte era occupata dall'agricoltura, ristretta intorno alle colonie della Magna Grecia al sud o le città-stato dell'Italia centrale.
Ad esempio la vasta area fra Aquileia, Ravenna, Mantova, Brescia, Reggio e Como era tutta paludosa. Le coste adriatiche, tirreniche e liguri erano ricoperte da fitte foreste, dalle quali si prelevava legname considerato pregiato per la grossezza dei tronchi. Gli stessi colli di Roma, come il Palatino o il Quirinale, erano ricoperti da boschi. Fra Modena e Bologna le foreste era ancora così fitte in epoca Repubblicana da rallentare notevolmente i lavori di costruzione della via Emilia. Tito Livio racconta che la foresta del Cimino, in Etruria, era così terrificante da superare quelle germaniche descritte da Tacito. La Gallia Cisalpina (nord d'Italia) era ricchissima di querce, infatti fu il principale centro di allevamento dei maiali dell'impero. Il Gargano, in Puglia, era ricoperto da querce ed altri alberi che arrivavano fino al mare.
[one_second][info_box title="La vigna prima ancora della legge" image="" animate=""]

«Sed etiam a vinea, et balneo, et theatro nemo dubitat
in ius vocari licere».(Gaius, Liber I ad Legem XII Tabularum)
"Non è consentito chiamare in giudizio (e portare in tribunale) chi si trovi nella vigna, al bagno (le terme) o a teatro".
Questa sententia citata dal giurista Gaius, compresa nelle leggi scritte più antiche di Roma, le Leggi delle XII Tavole (Lex XII Tabularum, 450 a.C.), dimostra quanto fossero considerati importanti i lavori in vigna nelle epoche più antiche di Roma, al punto da far sospendere anche un procedimento giudiziario. Bisognava aspettare che il vignaiolo avesse finito il suo lavoro.
In generale l'importanza della viticoltura a Roma si può capire dal grande numero di leggi che la riguardavano, rispetto alle successioni, le compravendite, i legati, ecc. Nei contratti agrari veniva sempre riconosciuto l'aumento del valore di un terreno nel quale era statto fatto un vigneto. In caso di risoluzione anticipata del contratto di affitto, anche per morosità, il proprietario doveva comunque indennizzare il fittavolo che vi aveva impiantato viti.
Numerose sono anche le cause giudiziarie che riguardano la vigna, che ci offrono siparietti non sempre edificanti della vita dell'epoca. Ad esempio, il giurista Sesto Pomponio racconta di un tale che, approfittando del grande rigoglio delle viti (alberate) del vicino, raccoglieva i frutti dai tralci che si allungavano fin sugli alberi della sua proprietà e ne traeva profitto. Ad un certo punto il proprietario delle viti se ne accorse e volle tagliare quei tralci. Il tale si oppose al taglio, arrivando a far causa al vicino per impedirglielo. Il tribunale gli diede però torto, ribadendo che i rami appartengono sempre al proprietario del terreno dove le viti sono piantate, ovunque essi arrivino.
Nella Roma antica comparve anche il primo esempio nella storia di intervento del governo per regolamentare l'impianto delle vigne e, quindi, il mercato del vino. Si tratta del famoso editto di Domiziano che, nel 92 d.C., vietò l'impianto di nuove vigne e introdusse l'obbligo di espianto di metà di quelle delle province. Secondo alcuni studiosi, l'editto nacque in un momento di stagnazione generale del commercio del vino. In particolare, i patrizi romani, che erano produttori di vino, non volevano subire la concorrenza esterna. Già Cicerone aveva intenti protezionistici quando scriveva nel De Re Pubblica (55-51 a.C.): «Noi non permettiamo che i popoli Transalpini coltivino l'olivo e la vite, perché si mantengano superiori la nostra olivicoltura e viticoltura». Secondo altri, l'editto nacque anche dalla volontà di frenare l'eccessiva espanzione delle vigne che stava avvenendo in quel periodo, per evitare carestie per mancanza di grano.

La successiva decadenza della viticoltura in Italia fece sparire il divieto e, viceversa, diversi imperatori si impegnarono per arginare questo fenomeno. Ad esempio, Aureliano, intorno al 275 d.C., distribuì gratuitamente schiavi ai proprietari terrieri, dall'Etruria fino alle Alpi Marittime, perchè ampliassero le vigne sempre più abbandonate.
Invece il divieto di creare nuovi vigneti fuori dall'Italia fu abrogato da Probo, verso la fine del III sec. d.C.. Probo permise finalmente «a tutti i Galli ed a tutti gli Spagnoli e persino ai Britanni di coltivare le viti e di fare il vino», e di «possedere le vigne ai Galli e ai Pannoni» (Historiae Aug. Probus, 18,8). Egli introdusse anche delle corvéé per i centurioni romani, dedicate spessoanche all'impianto di vigne, come accadde in Germania, che fino ad allora ne era priva.
 Sul finire dell'era antica, la viticoltura italiana era in forte decadenza anche perché era oppressa dalla burocrazia e da tasse sempre più asfissianti. Cassiodoro racconta che i produttori arrivavano al punto di tagliare le proprie viti per sottrarsi ad imposizioni fiscali insostenibili. Nell'codice teodosiano del 413 d.C. è scritto che si condannava alla pena di morte e alla confisca dei beni chi avesse tagliato le viti per sfuggire al fisco:
Sul finire dell'era antica, la viticoltura italiana era in forte decadenza anche perché era oppressa dalla burocrazia e da tasse sempre più asfissianti. Cassiodoro racconta che i produttori arrivavano al punto di tagliare le proprie viti per sottrarsi ad imposizioni fiscali insostenibili. Nell'codice teodosiano del 413 d.C. è scritto che si condannava alla pena di morte e alla confisca dei beni chi avesse tagliato le viti per sfuggire al fisco:
"Si quis sacrilega vitem falce succiderit, ..."
Se qualcuno avesse abbattuto la vite con falce profanatrice ..." Cod. Theod. l. XIII. Tit. XI. leg. 1.
Si ritornerà a parlare di leggi intorno alla vigna con i Longobardi. [/info_box][/one_second]

Questi boschi erano stati usati dall'uomo da sempre ma, in epoca Romana, la popolazione aumentò notevolmente rispetto al passato e così anche le applicazioni tecniche. L'uso del legname divenne massiccio, usato come combustibile ma soprattutto per l'edilizia in notevole espansione e la costruzione delle grandi flotte navali romane, ...
Così nei secoli i Romani disboscarono buona parte della penisola, anche per far sempre più spazio ai terreni agricoli e ai pascoli. Rispetto ad oggi, comunque, rimaneva ancora una buona parte di natura incontaminata.
In epoca arcaica, Anco Marzio aveva messo il patrimonio boschivo sotto la tutela degli Dei e dei magistrati decemvirali, dichiarandolo Demanio Pubblico Naturale. Più che una tutela, probabilmente, era solo una questione economica: una parte importante del reddito pubblico derivava proprio dalla gestione di questo patrimonio. Comunque sappiamo che gli stessi Romani si accorsero del degrado che derivò dallo sfruttamento intensivo delle risorse naturali. Ce lo raccontano Plinio ed altri autori, che parlano di frane, alluvioni, erosioni, carenze idriche e problemi agricoli, riconoscendo dietro ad essi la mano dell'uomo.
Torniamo però agli ultimi lavori della vigna.
Potatura verde
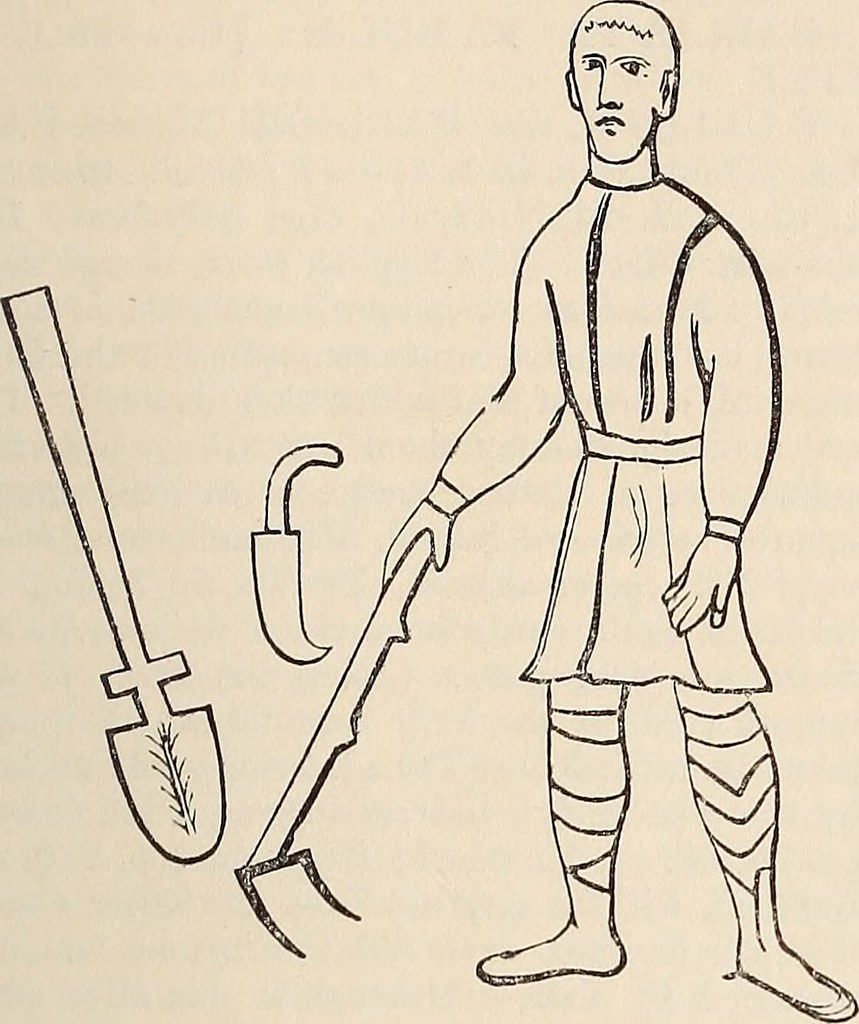
Gli autori agrari romani raccontano dei diversi lavori compresi sotto la dicitura di "potatura verde", all'epoca detta vites pampinari. Per Varrone è anche più importante della potatura invernale e deve essere fatta solo da persone esperte. Già Catone cita i lavori di spollonatura , legatura e sfogliatura. Columella aggiunge anche la cimatura ed il diradamento dei grappoli, completando l'insieme dei lavori, come ai nostri giorni.
Per spollonare usavano i cultelli minores, piccoli coltelli ricurvi. I tralci delle viti erano legati perché non venissero rotti dagli attrezzi e dagli animali durante il passaggio, facendo attenzione ad indirizzarli verso l'alto. Queste scelte erano fatte senza conoscere la fisiologia delle viti, come oggi. Era un sapere empirico, nato dall'osservazione attenta e razionale della risposta delle piante ai lavori fatti in diverso modo.
Ad agosto, spiega Columella, si tolgono le foglie intorno ai frutti nei territori dove il clima è più fresco e piovoso, per evitare di far marcire i grappoli. Consiglia invece di non farlo nei luoghi caldi, come facciamo ancora oggi. Racconta anche che nelle zone dal clima torrido si ombreggiassero le viti con delle stuoie, come faceva suo zio Marco in Betica (sud della Spagna).
Lavorazione del suolo
Anche la lavorazione del suolo e l'estirpazione dalle erbacce era importante allora come oggi. L’operazione era chiamata fossio e chi la faceva fossor. Virgilio usa il verbo jactare.
Dove era possibile, era sempre fatto con l’aratro tirato dai buoi. Dove non si poteva usare l’aratro, si lavorava con la vanga semplice (pala o ligo) o col bipalium (una vanga con sbarra trasversale, che scava a profondità doppia di quella comune). La marra era una zappa a testa larga e dentata. Il rastrum era uno strumento sempre dentato, così come il sarculum, tutti diversi tipi di rastrelli. L’irpex era un pesante rastrello tirato da buoi, come gli erpici moderni.
Gli autori latini consigliano di zappare la vigna almeno tre volte all'anno: uno quando germoglia, l'altro alla fioritura e il terzo per la maturazione. Le giovani vigne devono essere sempre accuratamente vangate per togliere tutte le erbacce. Questi lavori sono essenziali anche oggi, anche se fatti in modo diverso, essenzialmente per togliere la vegetazione a ridosso della vite ed per evitare competizioni sfavorevoli in momenti delicati della vita della pianta.
Un altro lavoro era quello di scalzare le viti (ablaqueare o circumfodere) con la dolabra e la dolabella, che erano delle piccole asce. All'epoca di Palladio si diceva excodicari: si apriva la terra intorno alla vite e si tagliavano le radici più superficiali. Poi si rincalzava la terra intorno alle viti nel periodo freddo, nei territori dal clima più fresco. Questo lavoro tradizionale oggi non viene praticamente più fatto.
Vendemmia
La raccolta dell'uva era un evento legato a pratiche religiose, dedicate principalmente a Giove, come già descritto qui, ed altre superstiziose. Le festività Vinalia Rustica si svolgevano il 19 agosto e servivano a propiziare il bel tempo durante la maturazione dell’uva. Durante le feste i vendemmiatori poteva fare scherzi di ogni tipo, anche offendendo i passanti, senza che questi potessero reagire. Cicerone parla delle Auguratio Vineta, pratiche augurali prima della vendemmia. Il via ufficiale alla raccolta era dato invece dalla festa della Auspicatio Vindemiae, con un rito officiato dal Flamen Dialis, il sommo sacerdote di Giove. Egli raccoglieva un grappolo primiziale in una vigna pubblica e lo offriva al dio, compiendo un sacrificio animale. Il gesto doveva garantire un buon raccolto. La data della festa variava ogni anno, in relazione al periodo della vendemmia. Plinio il Vecchio cita invece un rituale magico usato per scongiurare il mal tempo: si metteva un grappolo d’uva finto nella vigna e questo avrebbe dovuto attirare a sé i danni, risparmiando il resto.

Columella scrive invece della ricerca di metodi razionali per decidere il momento ideale della raccolta. Egli passa in esame i sistemi proposti da diversi autori, come la valutazione della mollezza dell'acino, del colore e della lucidità del frutto, addirittura dal cadere delle foglie. Questo non deve stupire però, anche perchè all'epoca spesso si facevano quelle che oggi noi chiamiamo "vendemmie tardive". Tuttavia per lui non sono sistemi sicuri, perchè possono dipendere anche da altre cause oltre che la maturità, come le intemperie dell'annata o altro. C'è chi assaggia l'uva ma anche questo metodo può essere frutto di inganno per Columella, perchè dice che non sempre si riesce a cogliere bene il rapporto fra dolcezza ed acidità, soprattutto per le varietà più aspre.
Secondo Columella, il sistema migliore e senza possibilità di sbagli è valutare il colore dei vinaccioli:
“La cosa migliore, come io stesso uso fare, è osservare la maturazione naturale di per sé. Ora, la maturità naturale si ha se, spremuti i vinaccioli, i quali si nascondono nell’acino, essi sono scuri di colore o alcuni nerissimi. Nessuna cosa, infatti, può dare colore ai vinaccioli se non il raggiungimento della maturità naturale …” (De Re Rustica”).
 In effetti i vinaccioli sono un buon segnale della maturazione dell'uva. Al momento dell'invaiatura (il momento di cambio di colore degli acini), i semi da verdi diventano giallognoli o marroncini, a seconda della varietà, poi diventano sempre più scuri. Si tratta di un parametro oggettivo, sufficientemente buono per il passato e rimasto in uso per secoli. Non è però precisissimo. Infatti, diventa sempre più difficile valutare le diverse gradazioni di marrone nelle fasi finali. Oggi, per decidere il momento perfetto per la vendemmia, valutiamo un insieme di diversi parametri (vedete qui). I vinaccioli completano le informazioni necessarie, soprattutto assaggiandoli e valutando la maturazione dei tannini.
In effetti i vinaccioli sono un buon segnale della maturazione dell'uva. Al momento dell'invaiatura (il momento di cambio di colore degli acini), i semi da verdi diventano giallognoli o marroncini, a seconda della varietà, poi diventano sempre più scuri. Si tratta di un parametro oggettivo, sufficientemente buono per il passato e rimasto in uso per secoli. Non è però precisissimo. Infatti, diventa sempre più difficile valutare le diverse gradazioni di marrone nelle fasi finali. Oggi, per decidere il momento perfetto per la vendemmia, valutiamo un insieme di diversi parametri (vedete qui). I vinaccioli completano le informazioni necessarie, soprattutto assaggiandoli e valutando la maturazione dei tannini.
Un altro sistema consigliato in epoca antica consisteva nel valutare la crescita della dimensione degli acini che, a maturità, si ferma. Il metodo suggerito è quello di togliere un acino da un grappolo e di controllarlo dopo un po' di tempo. Se non si è ancora a maturità, le altre bacche continuano a crescere e riempiono il vuoto lasciato dall'acino tolto. Quando gli acini non crescono più ed il buco non viene riempito, allora si è pronti. Anche questo sistema si basa sull'attenta osservazione di quanto succede in vigna. Come il precedente, è un sistema abbastanza buono, ma non permette la finezza che cerchiamo adesso.

In ogni caso, queste conoscenze erano avanzate per l'epoca. Molto probabilmente erano conosciute e messe in pratica solo da chi aveva la cultura per leggere i trattati agrari di allora. Sicuramente la maggior parte dei vignaioli raccoglieva l'uva senza conoscere queste tecniche e senza grande precisione per la maturità, come è successo nella stragrande maggioranza delle vigne fino a non molto tempo fa.
Quando si raccoglieva nel passato? I vignaioli spesso raccoglievano nello stesso periodo tutti gli anni, quando iniziava il vicino, quando avevano tempo dalle altre incombenze, ecc. In epoca antica si andava anche a chiedere agli indovini. Infatti Catone e Columella, nei loro testi, "sgridano" i vignaioli che si affidano ad astrologi, aruspici o altre fonti simili per decidere il tempo della vendemmia, invece che imparare il loro mestiere!
Quando vendemmiavano?
Columella ci offre la testimanianza più precisa sulle date della vendemmia, nel suo calendario dei lavori agricoli (libro XI del De re rustica). Scrive nella seconda metà del I sec. d.C., per cui nel periodo climatico dell'Optimum Romano. Il periodo della vendemmia sembra molto simile al nostro.
Nel calendario mensile dei lavori, Columella inizia a parlare di vendemmia ad agosto, quando dice che si inizia a raccogliere l'uva nelle terre con climi notevolmente caldi, come la Betica, nel sud della Spagna (quella dello zio Marco) e il nord Africa. All'inizio di settembre, scrive, si inizia a vendemmiare nei luoghi vicini al mare e quelli caldi in generale. Nella seconda metà del mese, afferma che ormai si raccoglie un po' ovunque. Infine, ad ottobre si vendemmia anche nelle zone più fresche. Ricordo che ai tempi di Columella si seguiva il Calendario Giuliano, noi quello Gregoriano, ma più o meno i mesi coincidono.
La raccolta era fatta con piccoli falcetti ricurvi, detti falcula vindimiatoria. Per raggiungere i grappoli delle alberate, si usavano scale. Plinio raccomanda di non raccogliere l’uva calda e neppure quella ricoperta di rugiada, ottimi consigli anche per oggi. I grappoli erano riposti in ceste, come si vede in tanti mosaici o affreschi romani, oppure in contenitori di legno, come scrive Catone.
Quanto produceva una vigna dell'antica Roma?
"Vinea est prima, si vinum multum siet"
Così scriveva Catone nel II secolo a.C.: "La vigna è la più conveniente fra le coltivazioni, se produce molto vino".
Infatti, in generale, rispetto ai nostri parametri, la produzione raccontata dai Rustici Latini è veramente alta, come già abbiamo visto in anteprima con la meravigliosa vigna di Palemone (qui).
Per i Romani, come in tutte le epoche passate anche più vicine a noi, il valore della vigna era legato all'alta produttività, anche se riconoscevano un'opportuna riduzione delle rese per i vini di grande pregio. Tolta questa piccola parte, la grande massa di uva serviva a produrre grandi quantità di vino a basso costo. I vari autori antichi ci forniscono alcune stime.
In Cispadania (attuale Emilia Romagna e anche parte delle Marche) sembra che si producesse in media intorno ai 10 cullei* di vino per jugero* (circa 200 hl/ per ettaro), con punte estreme di 15 cullei (circa 320 hl/ha). Rese un po' più basse sono testimoniate per il centro Italia. Vi ricordate la meravigliosa vigna di Palemone che, secondo Svetonio, produceva 360 grappoli per ogni vite? Anche Columella la cita, dopo che era passata sotto la proprietà di Seneca, con una produzione di 8 culei per jugero (circa 170 hl/ha). Columella afferma che era meglio cessare l'uso di una vigna se questa fosse scesa al di sotto dei 3 cullei per jugero (circa 65 hl/ha). Naturalmente, da questa considerazione erano escluse le poche vigne pregiate, per le quali si citano anche minimi di 1 culleo/jugero (circa 21 hl/ha).
Considerate che oggi abbiamo una resa media in Italia che si aggira intorno ai 100-120 q.li di uva per ettaro (esattamento 108 q.li/ha nel 2019), che corrispondono a circa 75-90 hl di vino per ettaro. In Toscana, dove di media la qualità è molto alta, nel 2019 la resa media è stata di 66 q.li/ha, cioè poco più di 50 hl/ha. (Questi dati li ho presi dall'utilissimo blog "I numeri del Vino", qui)
Le rese romane sono quindi enormi rispetto alle nostre, considerando anche che all'epoca le vigne non avevano la densità d'impianto di oggi, anzi, spesso erano in coltura promiscua. Quindi, ogni singola vite produceva quantità di uva esagerate. Ricordiamoci anche che la forma di coltivazione più diffusa era la vite maritata, che è molto espansa e porta ad alte produzioni.
Certi studiosi hanno giustificato questi numeri pensando che fossero le rese massime possibili. C'è chi sostiene che non debbano essere presi esattamente alla lettera, col sospetto che alcuni autori romani possano peccare di una certa enfasi quando vogliono lodare qualcosa. Ciò non toglie che la quantità, per la produzione di massa, non mancava di certo.
Per ora ci fermiamo qui, sulla soglia della cantina, col cesto in spalla. Ci entreremo un'altra volta.
[alert style="warning"]*Unità di misura citate in questo articolo:
L'unità di misura della capacità riferita alla produzione del vino era il culleus, che corrispondeva ad un grande otre in pelle di circa 520 litri, la più grande unità di volume romana. Sotto ad esso c'era l’anfora, amphora, che corrispendeva a circa 26 litri. Ci volevano 20 anfore per fare 1 culleus. L'unità di misura di base era il sextarius, il sestero, che corrisponde a poco più di mezzo litro (circa 540 ml). 1 amphora= 48 sextarii.
L'unità di misura più usata per le superfici agricole era lo jugerum, circa 2553 m2, più o meno ¼ di ettaro (che, ricordo, è 10.000 m2). L'unità di base era l’actus quadratus, la metà dello jugero.[/alert]
Bibliografia:
"L'agricoltura di Lucio Giunio Moderato Columella" volgarizzata da Benedetto del Bene, con annotazioni adattate alla moderna agricoltura e con cenni sugli studi agrari d'Italia del cav. Ignazio Cantù, Milano, dalla Tipografia di Giovanni Silvestri, 1850.
"Interventi di bonifica agraria nell'Italia romana", a cura di Lorenzo Quilici e Stefania Quilici Gigli, ed. L'Erma di Bretchneider, 1995.
"Il vino nel «Corpus iuris» e nei glossatori", Cornelia Cogrossi, (2003) In: La civiltà del vino. Fonti, temi e produzioni vitivinicole dal Medioevo al Novecento. Atti del convegno (Monticelli Brusati, Antica Fratta, 5-6 ottobre 2001). Centro culturale artistico di Franciacorta e del Sebino, Brescia, pp. 499-531.
“Interventi di bonifica agraria nell’Italia romana”, a cura d Lorenzo Quilici e Stefania Quilici Gigli, ed. L’Erma di Bretchneider, 1995.
“Storia dell’agricoltura italiana: l’età antica. Italia Romana” a cura di Gaetano Forni e Arnaldo Marcone, Edizioni Polistampa, 2002
“Terra e produzione agraria in Italia nell’Evo Antico”, M. R. Caroselli.
"Meteo, clima e storia. Le variazioni climatiche del periodo Romano". Marco Rossi, 2007.
“Studi sui Libri ad edictum di Pomponio”, Emanuele Solfi, 2002, ed. LEM
“Origini della viticoltura”, Attilio Scienza et al., Atti del Convegno, 2010.
“La viticoltura e l’enologia presso i Romani”, Luigi Manzi, 1883.
“Storia della vite e del vino in Italia”, Dalmasso e Marescalchi, 1931-1933-1937.
“Storia del paesaggio agrario italiano”, Emilio Sereni, 1961.
“Il vino nella storia”, Enrico Guagnini, 1981.
“Il vino, storia, tradizioni, cultura”, Hugh Johnson, 1991.
“Contadini perfetti e cittadini agricoltori nel pensiero antico”, Valerio Merlo, Alce Nero.
Le magliette 2020
Sono arrivate le magliette ufficiali della vendemmia! Il 2020 è turchese: il colore del mare, della tranquillità ma anche di un nuovo inizio, tutte cose di cui abbiamo bisogno quest’anno.

In edicola, la guida di Repubblica sulla Costa Toscana
In questi giorni potete trovate in edicola la guida di Repubblica dedicata al nostro bellissimo territorio.
È la costa toscana, fatta di mare, campagna, storia, natura, grande cucina e prodotti di territorio eccezionali, come l’olio extravergine d’oliva ed il vino.
Grazie a chi ha curato quest’ultima parte, l’AIS, per la menzione della nostra azienda:
” ... La gamma dei vini è diversificata e di grande livello. In una denominazione a vocazione rossista, sono riusciti anche a mettere a punto un grande bianco, il Criseo... “
Se decidete di trascorrere qualche giorno o una vacanza in questa meravigliosa parte della Toscana, ricordatevi che vi aspettiamo a Guado al Melo.
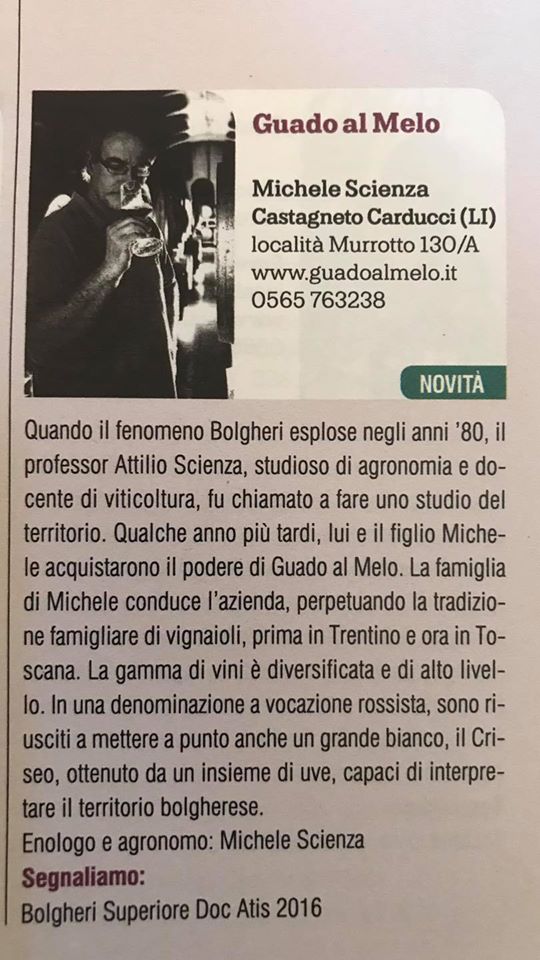
"La stirpe del vino" vince il Premio Biblioteca Lunelli
Con piacere abbiamo saputo che il libro di Attilio Scienza e Serena Imazio, "La stirpe del Vino" (ed. Sperling & Kupfer 2018) ha vinto la prima edizione del Premio Biblioteca Lunelli, un riconoscimento per testi di argomento enologico.
Orario di apertura estivo
Dalla prossima settimana (da lunedì 6 luglio) cambiamo gli orari di apertura al pubblico della cantina:
- dal lunedì al sabato mattina 10.00-12.30 16.00-20.00,
- il sabato pomeriggio 15.00-18.00,
- domenica solo su prenotazione (per gruppi).
Vi aspettiamo!
Annalisa e Michele
Fertilità e malattie: ragione vs superstizione nelle vigne dell'antica Roma ... ed oggi
.... continua da qui
Come abbiamo già in parte visto nei post precedenti, gli autori agrari romani (qui), in particolare Columella, raccontano in genere di una viticoltura molto pratica e razionale, che nasce dall'esperienza e dall'attenta osservazione dei fenomeni della vigna, come facciamo oggi, pur con i limiti conoscitivi dell'epoca. Nelle opere d'ambito letterario o storico, le descrizioni agricole si mescolano molto spesso ai riti religiosi o alle credenze superstiziose, che erano sicuramente molto diffuse nelle campagne, soprattutto in relazione agli aspetti più difficili da gestire, come la fertilità del suolo e le malattie di cui racconto in questo post.
 La contrapposizione fra ragione e superstizione in agricoltura è antica. Mescolate più o meno tra di loro, hanno attraversato tutti secoli e sono arrivate fino a noi, l'era delle bufale e dei falsi miti, che stanno proliferando più che mai per quanto riguarda il cibo e la sua produzione.
La contrapposizione fra ragione e superstizione in agricoltura è antica. Mescolate più o meno tra di loro, hanno attraversato tutti secoli e sono arrivate fino a noi, l'era delle bufale e dei falsi miti, che stanno proliferando più che mai per quanto riguarda il cibo e la sua produzione.
Già Catone se la prendeva con i vignaioli che, invece di imparare le tecniche viticole, andavano da astrologi, aruspici o auguri (nell'immagine sotto) per decidere quando iniziare la vendemmia o fare altri lavori, con risultati disastrosi! Anche Columella cercava di persuadere dell'inutilità delle divinazioni o altre superstizioni, come certe pratiche magiche che si facevano nelle campagne.
I riti religiosi di allora sono continuati nelle processioni e benedizioni dei campi del cristianesimo, rimaste in uso nelle nostre campagne fino a non molto tempo fa. Oggi la dimensione religiosa è quasi del tutto scomparsa. Stanno invece emergendo sempre più, in questi ultimi anni, approcci irrazionali che sembravano essere passati definitivamente in secondo piano con l'epoca moderna, ma così non è stato. Fra l'altro, come vedrete, sono molto simili a quelli che erano già deprecati dagli agronomi dell'epoca antica. 
Possibile che non sia cambiato niente?
In passato c'era reale ingenuità verso l'irrazionale, il che era spiegabile con l'ignoranza diffusa. Tuttavia l'istruzione generalizzata di oggi sembra non aver cambiato molto la situazione. Sembriamo più che mai in balia di falsi miti, bufale, paure, pratiche pseudo-antiche, ecc.
D'altra parte, posso capire che per molti non è facile difendersi, c'è troppa confusione di informazioni. L'agricoltura è ormai molto lontana dalla vita della maggior parte delle persone (e non parlo di coltivare un orto o un giardino amatoriale). Troppi esperti o pseudo-tali ne parlano con superficialità. Inoltre, un ruolo importante è giocato dal marketing del cibo che, forse a corto di altre idee, sembra cavalcare più che mai paure e storie evocative, contribuendo a consolidare miti o bufale varie.
Direte: che male può fare? Purtroppo molto. Stiamo già assistendo a ripercussioni che, se si continua in questa direzione, diventeranno sempre più importanti, con effetti sulle politiche agricole, le regolamentazioni del comparto, gli indirizzi della ricerca scientifica, ecc. Pensiamo a quelle pratiche o prodotti usati in agricoltura che sono vietati o viceversa osannati per motivi di "pancia" o di mito, più che di reale sperimentazione. In generale, tutto questo rischia di portarci ad uno scadimento generale dell'agricoltura, con influenze sulla qualità e/o la quantità dei prodotti e sul futuro stesso del settore.
Tuttavia, l'ignoranza e la superficialità in agricoltura sono piaghe che esistono da sempre, come ci racconta anche Columella. Nella prefazione al suo De re rustica, già lamentava quanto l'agricoltura fosse sottovalutata. Molti, scrive, attribuiscono l'impoverimento dei suoli ed il declino dell'agricoltura al fato, alle avversità metereologiche o ad altro, mentre quello che manca, spesso, è solo la conoscenza.
Columella ci invita a riflettere sul fatto che, mentre tutti condividono l'idea che serva una buona istruzione per svolgere la maggior parte delle professioni, lo stesso non succede per l'agricoltura, che è pure fra le attività più importanti, perché senza di essa l'uomo non può nutrirsi. Eppure, troppe persone la praticano (o ne parlano, aggiungo io) con leggerezza, solo con conoscenze superficiali. Così l'agricoltura peggiora sempre più e le importazioni dei prodotti diventano sempre più indispensabili.
Sembra scritto oggi!
Veniamo però ai temi della vigna che ci interessano, la fertilità e le malattie, e vediamo come le affrontavano al tempo dell'antica Roma, sia in modo razionale che con la superstizione e la magia.
Fertilità e concimazione
I problemi legati alla fertilità del suolo non sono solo moderni, ma hanno da sempre un ruolo centrale nelle preoccupazioni agricole.
Fin dalle epoche più remote la fertilità era legata ad eventi inspiegabili e quindi collocata nell'ambito del sovrannaturale. Era vista come segno di favore da parte degli dei o, con la sua mancanza, di punizione. Tutti popoli, in tutte le epoche, hanno creato riti religiosi, offerte, sacrifici o pratiche magiche, nella speranza di avere buoni raccolti. Per fortuna però l'umanità non è rimasta ferma solo a questi aspetti: i nostri avi agricoltori, con la capacità di ragionamento e di osservazione legate alla pratica, hanno capito che la terra aveva bisogno di essere "nutrita" con concimazioni perché potesse continuare a donarci i suoi frutti.
 Oggi sappiamo che la fertilità dipende da un insieme di caratteristiche del suolo di natura chimica, fisica e biologica. Grazie ad esse il suolo è in grado di fornire (o meno) gli elementi minerali che servono alle piante come nutrimento. La perdita di fertilità dipende da molti fattori. Ogni pianta sottrae nutrienti al terreno in cui cresce, in modo maggiore più la coltivazione è intensa. Inoltre si perdono per fenomeni di lisciviazione (cioè l'azione di trascinamento dovuto all'acqua che passa nel suolo), problemi di compattamento, di erosione, ecc. In agricoltura gli elementi nutritivi devono quindi essere reintegrati in qualche modo.
Oggi sappiamo che la fertilità dipende da un insieme di caratteristiche del suolo di natura chimica, fisica e biologica. Grazie ad esse il suolo è in grado di fornire (o meno) gli elementi minerali che servono alle piante come nutrimento. La perdita di fertilità dipende da molti fattori. Ogni pianta sottrae nutrienti al terreno in cui cresce, in modo maggiore più la coltivazione è intensa. Inoltre si perdono per fenomeni di lisciviazione (cioè l'azione di trascinamento dovuto all'acqua che passa nel suolo), problemi di compattamento, di erosione, ecc. In agricoltura gli elementi nutritivi devono quindi essere reintegrati in qualche modo.
Tornando alla viticoltura dell'epoca Romana, i nostri autori agrari riconoscevano la grande importanza della concimazione della vigna. Oggi sappiamo che l'ottimale nutrizione delle viti è un fattore essenziale per la qualità del vino. Secondo Columella, la concimazione deve essere “frequente, tempestiva e modica”. Oggi diremmo, qualcosa di simile, anche se più preciso, secondo i principi della viticoltura integrata sostenibile: va fatta in modo appropriato, solo quando e dove serve, in riposta alle esigenze nutrizionali specifiche di ogni particella di vigna.
Catone raccomanda che si usi buon letame, fatto ben maturare, prodotto da pecore o cavalli. Quello bovino all'epoca non era considerato ottimale. Oggi il letame è usato ancora, ma spesso è difficile da reperire, soprattutto nei territori dove mancano gli allevamenti. Allora, come oggi, veniva data grande importanza anche alla concimazione fatta con i resti verdi (tralci della potatura, dei raspi, delle vinacce, erba, …), che formano compost. Oggi sappiamo anche che letame e compost non sono sempre sufficienti. Ne parleremo meglio un'altra volta: è un tema molto complesso.

Se passiamo agli aspetti meno razionali, fra la gente comune delle campagne erano diffuse molte superstizioni e riti religiosi per incrementare la fertilità agricola.
Fra le pratiche magiche della vigna, mi è piaciuta molto l'usanza di appendere ai rami degli alberi delle piccole maschere di Bacco, dette oscilla (oscillum al singolare), che il vento faceva girare. Si credeva che la parte di vigna dove si voltasse la maschera diventasse molto feconda. (Virgilio, Georgiche, II). Mi sembrano installazioni artistiche.
Un'altra pratica magica, molto più esoterica, consisteva nell'impiantare tre corni di capra nella terra intorno alla pianta a cui erano avvolte le viti (qui descrivo il sistema di coltivazione romano tradizionale, la vite maritata all'albero), con la parte cava verso l'alto, di poco sporgenti dal terreno. Si credeva che la pioggia, entrata nelle corna e poi passata nel suolo, avrebbe donato fertilità.

Diversi animali rientravano spesso nei riti propiziatori e di fertilità, tramite sacrifici o attraverso l'uso magico di parti del loro corpo (corna, ossa, ecc.). Gli antropologi parlano di magia per compensazione, perché questi animali erano considerati molto pericolosi per la vigna. Oltre a cinghiali, daini, cervi e caprioli, che danneggiano le vigne anche oggi, allora c'era ancora un grande bovino selvatico, l'uro (Bos taurus primigenius L.). I buoi che lavoravano la vigna erano dotati di museruole, perché non danneggiassero le viti e le altre piante. Un altro grande pericolo, allora, derivava dalle greggi sfuggite al controllo dei pastori. La capra era considerata la nemica principale del vignaiolo. Infatti, non a caso, era l'animale sacrificale per eccellenza al dio Bacco.
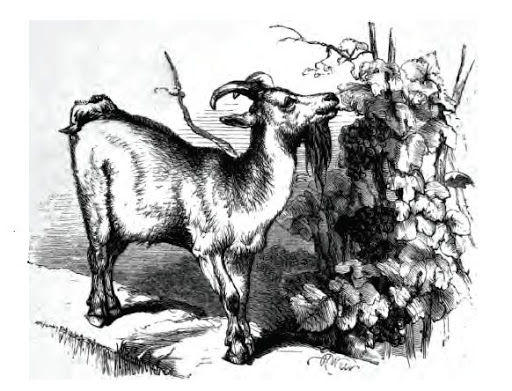
Le corna, in particolare, hanno assunto tanti significati simbolici presso diversi popoli ed in varie epoche, fra cui quelli di forza e di fertilità, oltre che di protezione dagli influssi maligni. Il Cristianesimo, per contrasto, le ha messe sulle teste dei diavoli. Oggi, tornano, curiosamente, nelle vigne.
Malattie ed avversità della vite.
Le malattie sono probabilmente l'aspetto più debole dei testi dei Rustici Latini, compreso il grande Columella. D'altra parte in questo ambito non sono sufficienti una buona pratica e capacità d'osservazione. Servono conoscenze più approfondite sulla natura delle malattie e dei parassiti, sulla fisiologia della vite, di chimica, ecc., che arriveranno solo dall'Ottocento in poi. Nonostante ciò, si intravede comunque nei loro scritti un tentativo di ricerca razionale che, seppur debole, mostra qualche spunto interessante.
Come vedremo, anche questo ambito così problematico cadeva facilmente preda delle superstizioni e delle pratiche magiche, che sono spesso figlie dell'impotenza. La vita degli agricoltori dal passato non era di certo facile.
 Fortunatamente, i nostri avi romani (e per molti secoli a venire) si sono risparmiati le peggiori malattie della vigna, capaci di mettere veramente in ginocchio i viticoltori. Sono arrivate in Europa solo nell’Ottocento, dall'America: la fillossera, l'oidio e la peronospora.
Fortunatamente, i nostri avi romani (e per molti secoli a venire) si sono risparmiati le peggiori malattie della vigna, capaci di mettere veramente in ginocchio i viticoltori. Sono arrivate in Europa solo nell’Ottocento, dall'America: la fillossera, l'oidio e la peronospora.
Non mancavano però le malattie autoctone, che creavano comunque problemi. Tuttavia sono meno distruttive di quelle americane: colpiscono per lo più il grappolo e, salvo casi particolarmente nefasti, possono essere "sopportate" meglio dal vignaiolo (pur perdendo in qualità e produzione). In certi casi possono essere contenute eliminando per tempo i primi segni di infezione, oppure facendo una selezione dei grappoli. A questi links trovate come le affrontiamo noi, con la moderna viticoltura integrata e sostenibile: tignoletta, muffe varie e mal dell'esca, insetti ed altri animali, virus e fitoplasmi.

Per diverse malattie, i Rustici Latini consigliavano l’uso di sostanze che si pensava avessero funzioni "disinfettanti". Torna infatti spesso l'uso dell'aceto o di impiastri a base di elaterio (Ecballium elaterium L., detto anche cocomero asinino o cocomero selvatico o sputaveleno), con cui strofinare le parti infette. L'elaterio è una pianta selvatica mediterranea, usata in passato per gli effetti purganti, ma abbandonata per l'elevata tossicità. Non mi risulta che questi composti possano essere utili.
Un rimedio ricorrente era l’aspersione delle viti con urina umana vecchia. Noi sappiamo che non serve per combattere le malattie. Tuttavia l’urina apporta azoto, un po' di fosforo e potassio. Forse veniva consigliata perché si osservava un certo effetto benefico, semplicemente come forma di concimazione. In realtà l'eccesso di azoto è uno svantaggio per certe malattie della vite ma, forse, all'epoca c'erano più carenze che abbondanze di nutrienti.
Per prevenire malattie e problematiche dovute alle gelate o all'umidità, Columella consiglia di accendere nelle vigne dei mucchi di paglia o di spargere cenere calda sulle viti. Ancora oggi, nelle località più fredde, si cerca di evitare i danni dal gelo accendendo fiaccole nella vigna.

Dalle descrizioni degli autori latini non è comunque facile riconoscere le malattie ed i parassiti che sappiamo infestare la vigna, allora come oggi. Sono troppo scarne e vaghe, si possono solo fare ipotesi. Ad esempio, si parla di viti che non emettono frutto, le foglie diventano bianche e si seccano. Dai sintomi sembra una muffa, molto probabilmente la botrite in fase precoce. In questo caso il rimedio consigliato era di sfregare le piante con aceto fortissimo, mescolato a cenere e di versarlo, diluito, sulle radici.
Vengono descritte delle viti malate, con le foglie che diventano rosse (il mal dell’esca?). Consigliavano di trivellare la corteccia e nel buco introdurre un rametto di quercia o una pietra, o chiodi. Non stupitevi: interventi di tagli sul tronco vengono fatti anche oggi, con risultati spesso positivi, perché è una malattia che colpisce i vasi linfatici della pianta ed il legno. Altro consiglio antico era di tagliare le viti inferme vicino a terra, coprirle con un po’ di terra e sterco e da qui ripartire. Anche questo ha un senso, considerando anche che allora le viti erano "franche di piede", cioè non erano innesti come oggi (per via della fillossera: vedete qui).

 Diversi autori citano "bestiole" che creano danni alla vite, che ne erodono i teneri tralci ed i frutti o che alterano le foglie. Catone parla di piccoli bruchi. Plauto, un autore di commedie, ne La Cistellaria paragona un personaggio particolarmente fastidioso all'involvolus, che definisce "bestiam et damnificam, quae in pampini folio intorta se", "animale malvagio e malefico, che si arrotola nel pampino della vite" (Atto IV, Sc. II, v.63). Plinio parla di un convolvulus e di araneum (più o meno, ragnatela), Columella di volucre. Non si capisce se parlano della stessa o più avversità, sicuramente di insetti o altri parassiti. Alcuni autori moderni hanno pensato di riconoscere in certe descrizioni le forme larvali della tignoletta (o tignole in generale) e gli acari, parassiti molto comuni nelle vigne. Catone consiglia l'uso di un miscuglio di morchia cotta, bitume e zolfo. Quest'ultimo è uno dei prodotti fitosanitari più antichi. Viene usato ancora oggi nella difesa, anche se contro altre malattie (l'oidio). In certe situazioni, può dare effettivamente degli effetti secondari sugli acari.
Diversi autori citano "bestiole" che creano danni alla vite, che ne erodono i teneri tralci ed i frutti o che alterano le foglie. Catone parla di piccoli bruchi. Plauto, un autore di commedie, ne La Cistellaria paragona un personaggio particolarmente fastidioso all'involvolus, che definisce "bestiam et damnificam, quae in pampini folio intorta se", "animale malvagio e malefico, che si arrotola nel pampino della vite" (Atto IV, Sc. II, v.63). Plinio parla di un convolvulus e di araneum (più o meno, ragnatela), Columella di volucre. Non si capisce se parlano della stessa o più avversità, sicuramente di insetti o altri parassiti. Alcuni autori moderni hanno pensato di riconoscere in certe descrizioni le forme larvali della tignoletta (o tignole in generale) e gli acari, parassiti molto comuni nelle vigne. Catone consiglia l'uso di un miscuglio di morchia cotta, bitume e zolfo. Quest'ultimo è uno dei prodotti fitosanitari più antichi. Viene usato ancora oggi nella difesa, anche se contro altre malattie (l'oidio). In certe situazioni, può dare effettivamente degli effetti secondari sugli acari.
Altre pratiche, raccontate da diversi autori, sono invece veramente inspiegabili, tentativi ingenui o legati a superstizioni e a credenze magiche. Contro malattie e sfortuna bruciavano o seppellivano in vigna molte cose: corni, pesci, gamberi, piante varie, sterco di capra o di bue. Strofinavano le falci con sangue d'orso o con pelle di castrato, per una qualche azione purificante. Per disinfestare dai topi le vigne più vicine alle case, si consigliava di potare in una notte di luna piena. Qualche cedimento in questo senso sembra esserci anche nell'ultimo libro "Sugli Alberi" di Columella, la cui attribuzione è però incerta. Secondo diversi studiosi potrebbe essere un'opera spuria, forse di un certo Gargilio Marziale (o chi per esso), che copiò ampie parti del noto autore ed introdusse passaggi di suo pugno, di tutt'altro tono rispetto al trattato originario.
 Se tutto questo vi sembra strano, sentite come si prepara questo composto, che dovrebbe tenere lontane le malattie della vite. Bisogna raccogliere corteccia di quercia, togliendola dal tronco con una pialla, all'inizio dell'autunno. La corteccia va tritata finemente e con essa si deve riempire il cranio di un animale domestico, passando attraverso il foro alla base (da cui entra il midollo spinale). Si pressa bene e si chiude il foro con un frammento di osso e creta. Il cranio va interrato sul bordo di uno stagno, in presenza di materiale vegetale in decomposizione. In primavera si estrae il contenuto, che viene seccato. Quantità infinitesimali di esso sono poi sciolte in acqua piovana, mescolata con certi movimenti, tre volte a destra e tre a sinistra, ...
Se tutto questo vi sembra strano, sentite come si prepara questo composto, che dovrebbe tenere lontane le malattie della vite. Bisogna raccogliere corteccia di quercia, togliendola dal tronco con una pialla, all'inizio dell'autunno. La corteccia va tritata finemente e con essa si deve riempire il cranio di un animale domestico, passando attraverso il foro alla base (da cui entra il midollo spinale). Si pressa bene e si chiude il foro con un frammento di osso e creta. Il cranio va interrato sul bordo di uno stagno, in presenza di materiale vegetale in decomposizione. In primavera si estrae il contenuto, che viene seccato. Quantità infinitesimali di esso sono poi sciolte in acqua piovana, mescolata con certi movimenti, tre volte a destra e tre a sinistra, ...
Quella che ho appena descritto non è una pratica di epoca romana, ma di oggi (fa parte della biodinamica). Assomiglia molto a quelle che erano considerate superstizioni già duemila anni fa. Per altri preparati si devono usare corna di vacca o vesciche di cervo, interrate in notti di luna piena, ... Non sono neppure semplici da preparare: per fortuna che ormai si trovano comodamente in commercio, venduti da aziende pronte a soddisfare anche questi bisogni moderni di magia.
Le divinità della vigna
Per risolvere problemi di fertilità o avversità varie, si ricorreva anche all'aiuto degli dei, con riti e sacrifici.
Quando si parla di vino, tutti pensano essenzialmente a Bacco, un dio originariamente legato alla forza della natura ed ai suoi cicli. Comunque, è giunto a Roma solo alla fine del III sec. a.C., arrivando dalla Grecia e passando prima dall'Etruria, innestatosi su culti preesistenti. Lo conosciamo bene, per cui non mi dilungo. Riporto solo quella che mi è sembrata una sorta di preghiera del vignaiolo, scritta da Virgilio all'inizio del secondo libro delle Georgiche:
[one_second][info_box title="Dei della vigna e della fertilità agricola" image="" animate=""]
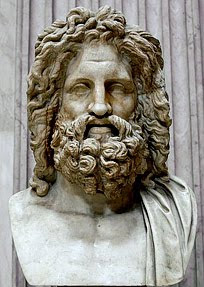
A Roma la viticultura era principalmente tutelata da Giove, che aveva stretti legami con la natura e, in particolare, con la vigna. A lui infatti erano dedicate le feste che precedevano la vendemmia.

Un culto legato alla terra è quello della triade Cerere, Libero e Libera. Libera è la Dea Madre, dea della fertilità dei campi. Libero è il figlio-vegetazione che ogni anno muore e ritorna. In altre versioni, Libero e Libera sono i due figli della dea madre Cerere, dea della fertilità e dei raccolti. Libero divenne poi la figura dominante, coll’appellativo di Pater, legato in modo particolare alla fecondità. A lui e a Libera erano consacrati gli strumenti della vendemmia e della cantina. Fu poi assimilato in parte a Bacco. Ricordo poi la Dea Dia o Bona Dea, ancestrale Dea Madre-Terra, rimasta come protettrice dei lavoratori dei campi e della fecondità femminile, moglie di Fauno, dio della campagna, dei pascoli e dell'agricoltura. La dea Tellus presiedeva a tutta la terra, dalle ricchezze agrarie a quelle minerarie ed ai defunti.
Giano è un Dio locale molto antico. Secondo Virgilio (Eneide), era re degli Aborigeni, un popolo primitivo abitante delle alte cime dei monti, a cui insegnò l’agricoltura e la religione. Un altro mito lo descrive come il fondatore di uno dei villaggi da cui nacque Roma, posto sul colle Gianicolo. Più tardi si aggiunse anche la storia della sua accoglienza del dio Saturno, che era stato spodestato da Giove. Il suo arrivo diede il via all’Età dell’Oro, un'epoca di grande abbondanza agricola. In cambio Giano ricevette il potere di vedere il passato e il futuro, diventando il Dio Bifronte, simbolo dell’inizio e della fine dell’anno. Un altro mito racconta che sia stato Saturno a donare il vino al Re Giano.
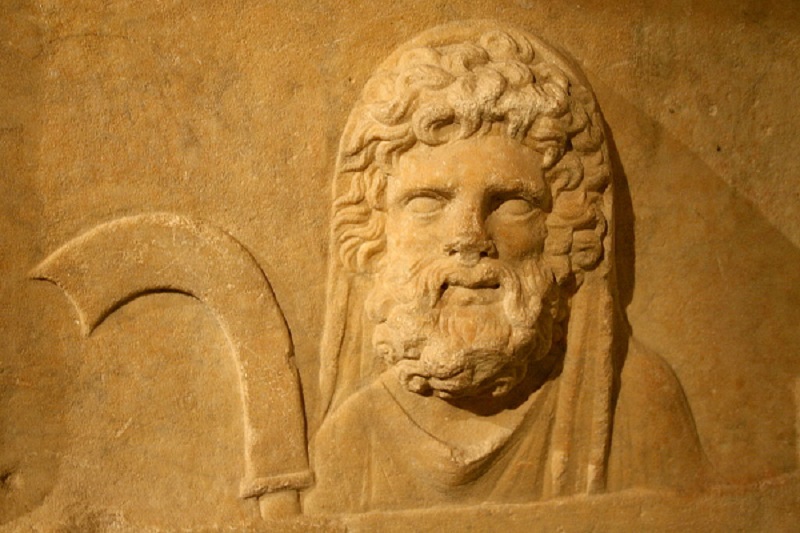
C'è però una tradizione ancora più antica e locale di Saturno, raccontata da Catone, nella quale è descritto come un dio-viticoltore sceso dai monti Sabini. Ha in moglie Opi, la dea madre-terra sabina, diventata a Roma dea dell'abbondanza agricola. A lui si deve la domesticazione delle piante utili, l'insegnamento dell’arte degli innesti, della coltivazione della vite e dell'apicoltura. Veniva sempre rappresentato con in mano una falce, il simbolo del vignaiolo. Gli si doveva presentare un'offerta di farro intriso di lardo e vino. Altri dei molto antichi e locali erano la coppia Robigo e Robiga, protettori del grano dalla ruggine (una malattia causata da un fungo), invocati anche perché proteggessero la vigna dalle malattie derivate dall'umidità e dalle piogge.
Nei territori soggiogati, le divinità locali rimasero come riferimento principale, come ad esempio la dea-madre Terra Feronia, protettrice dell’agricoltura presso i Volsci, Latini, Marsi, Umbri ed Etruschi. Elvio era il dio dei Sanniti che favoriva la raccolta della frutta e la vendemmia, ... Fra le divinità greche assimilate ricordo anche Priapo, raffigurato con un enorme fallo, espressione della sessualità maschile, della fecondità e della fertilità della vegetazione. In Italia il suo culto fu soprattutto legato alla protezione degli orti, delle vigne e dei giardini dai ladri (umani, ma anche uccelli o altri animali), tramite una sua effige posta all'ingresso di essi.[/info_box][/one_second]
"Vieni qui, o padre Bacco*, qui c’è il pieno di tutti i tuoi doni, la vigna fruttuosa grazie a te è rigogliosa di pampini in autunno e il vendemmiato schiumeggia nei tini ricolmi;
vieni qui, o padre Bacco, togli i sandali, tingi insieme a me gli stinchi nudi nel mosto nuovo."

HUC, PATER O LENAEE*, TUIS HIC OMNIA PLENA
MUNERIBUS, TIBI PAMPINEO GRAVIDUS AUTUMNO
FLORET AGER, SPUMAT PLENIS VINDEMIA LABRIS;
HUC, PATER O LENAEE, VENI, NUDATAQUE MUSTO
TINGUE NOVO MECUM DERPTIS CRURA COTHURNIS...
*Leneo è uno dei diversi appellativi di Bacco
In realtà, erano numerose le figure divine a cui si sarebbe potuto rivolgere un vignaiolo dell'epoca romana. Le divinità romane legate alla terra, alla fecondità e all'agricoltura erano tante, con sovrapposizioni e connessioni spesso difficili da comprendere. In origine, la religione romana adorava dei numi (numen, al plurale numina) che non erano persone, ma atti della potenza divina, espressioni dei molteplici aspetti dei fenomeni naturali. Fu l'influenza di altre culture (etrusca, greca, ecc.) che li portò, più o meno dalla Repubblica inoltrata, a dare loro forma sempre più umana, storie e gerarchie. Tuttavia l'impronta culturale originaria rimase. Con essa si spiega l'assoluta tolleranza ed assimilazione dei Romani verso le divinità di altri popoli. L'unico limite che ponevano era che il nuovo culto non creasse pericoli sociali o politici. Comunque, con la lucidità laica di molti grandi autori romani, Varrone scrisse che in origine fu adorato ciò che era utile.

Nelle campagne, fra i più semplici, le più amate e venerate erano spesso le figure divine locali, anche "minori", ma che i contadini sentivano più vicine. Alle divinità, come quelle elencate a lato, aggiungiamo il Genius loci, il genio del luogo, raffigurato come serpente o figura alata (di cui ho raccontato qui) o le Ninfe, legate a fonti o boschi o certi luoghi, ...
Inoltre, ogni singola attività agricola, in modo incredibilmente specifico, aveva il suo nume tutelare.  Servio ne elenca alcuni: Deus Vitisator (il dio che presiede all'impianto delle vigne), Vervactor (alla fienagione), Reparator (alle riparazioni, sistemazioni dei corsi d'acqua e recinzioni, ...), Obarator (all'aratura), Imporcitor (alla semina), Insitor (agli innesti), Occator (all'erpicatura), Sarritus (alla sarchiatura), Subruncinator (alla zappatura per diserbare), Messor (alla mietitura), Convector (al trasporto), Conditor (alla formazione di cumuli di fieno, grano o paglia), Promitor (al disfacimento dei covoni di fieno, paglia o cumuli di grano), ecc.
Servio ne elenca alcuni: Deus Vitisator (il dio che presiede all'impianto delle vigne), Vervactor (alla fienagione), Reparator (alle riparazioni, sistemazioni dei corsi d'acqua e recinzioni, ...), Obarator (all'aratura), Imporcitor (alla semina), Insitor (agli innesti), Occator (all'erpicatura), Sarritus (alla sarchiatura), Subruncinator (alla zappatura per diserbare), Messor (alla mietitura), Convector (al trasporto), Conditor (alla formazione di cumuli di fieno, grano o paglia), Promitor (al disfacimento dei covoni di fieno, paglia o cumuli di grano), ecc.
Il Cristianesimo faticò molto di più a sradicare questi culti contadini locali, diffusi capillarmente nelle campagne, che quelli delle divinità principali nelle città. Ce la fece attuando semplicemente un'operazione di sostituzione: queste figure divennero le figure dei Santi Patroni o i culti di Madonne locali. Allo stesso modo sono sopravvissute molte festività antiche legate al mondo agricolo, assorbite da festività cristiane o diventate fiere agricole tradizionali.
Carlo Levi, confinato in Basilicata dal regime fascista, rimase affascinato dalla scoperta della permanenza di culti arcaici agresti e lo raccontò nella sua opera "Cristo si è fermato ad Eboli" (1945). A proposito del culto di una Madonna Nera, ha scritto:
[blockquote author="" link="" target="_blank"]"La Madonna dal viso nero, tra il grano e gli animali, gli spari e le trombe, non era la pietosa Madre di Dio, ma una divinità sotterranea, nera, delle ombre del grembo della terra, una Persefone contadina, una Dea infernale delle messi.
...

La terra era troppo dura per lavorarla, le olive cominciavano a risecchire sugli alberi assetati; ma la Madonna dal viso nero rimase impassibile, lontana dalla pietà, sorda alle preghiere, indifferente natura. Eppure gli omaggi non le mancano: ma sono assai più simili all'omaggio dovuto alla Potenza, che a quello offerto alla Carità.
Questa Madonna nera è come la terra; può far tutto, distruggere e fiorire; ma non conosce nessuno, e svolge le sue stagioni secondo una sua volontà incomprensibile.
La Madonna nera non è, per i contadini, né buona né cattiva; è molto di più. Essa secca i raccolti e lascia morire, ma anche nutre e protegge; e bisogna adorarla. In tutte le case, a capo del letto, attaccata al muro con quattro chiodi, la Madonna di Viggiano assiste, con i grandi occhi senza sguardo nel viso nero, a tutti gli atti della vita."[/blockquote]
continua...
Bibliografia:
"De re rustica", Lucio Giunio Moderato Columella (60-65 d.C.), tradotto da Giangirolamo Pagani, 1846 (preferisco le traduzioni dell'Ottocento perchè, avendo una viticoltura e tecniche di produzione del vino più simili a quelle antiche delle nostre, sanno spiegare meglio i concetti e trovare le parole giuste. Quelle moderne spesso incappano in errori dovuti alla non conoscenza delle tecniche di viticoltura romane).
"Interventi di bonifica agraria nell'Italia romana", a cura d Lorenzo Quilici e Stefania Quilici Gigli, ed. L'Erma di Bretchneider, 1995.
"Storia dell'agricoltura italiana: l'età antica. Italia Romana" a cura di Gaetano Forni e Arnaldo Marcone, Edizioni Polistampa, 2002
“La viticoltura e l’enologia presso i Romani”, Luigi Manzi, 1883, .
“Storia della vite e del vino in Italia”, Dalmasso e Marescalchi, 1931-1933-1937, .
“Storia del paesaggio agrario italiano”, Emilio Sereni, 1961, .
“Quando le cattedrali erano bianche”, Quaderni monotematici della rivista mantovagricoltura, il Grappello Ruberti nella storia della viticoltura mantovana, Attilio Scienza.
“Terra e produzione agraria in Italia nell’Evo Antico”, M. R. Caroselli.
"Le tignole della vite", G. Anfora et al., Istituto Agrario di San Michele all'Adige, 2007.
http://narrabilando.blogspot.com/2014/05/culti-pagani-e-culti-cristiani.html
Cosa stiamo facendo ora in vigna: giugno e le cimature
In vigna è finita la fioritura e si sono formate piccole bacche verdi (allegagione). I tralci, che abbiamo palizzato (messi tra i fili, in posizione verticale, ricordate?) hanno continuato la loro crescita, arrivando anche un poco a sovrastare i fili più alti della spalliera. A metà giugno le giornate di sole e vento sono state interrotte da alcuni temporali, che hanno anche abbassato un po’ le temperature.
 Il cambio di tempo ha richiesto degli interventi per la protezione dalla peronospora, che in queste fasi è particolarmente pericolosa perchè potrebbe entrare nel grappolo. Grazie ai sistemi di viticoltura integrata, possiamo contenere questa malattia con un numero molto limitato di interventi, con prodotti a bassissimo impatto ambientale che non lasciano residui, ma molto efficaci per proteggere i nostri teneri grappolini in crescita. Evitiamo così di usare il rame, sostanza ecotossica e che richiede un numero di trattamenti molto più alto per avere una difesa sufficiente. Il rame è anche fitotossico in fioritura. Comunque, per fortuna, per noi la difesa dalla peronospora non è frequente. Ora è già tornato il clima caldo e ventoso che è la norma nella nostra costa toscana, per questo periodo.
Il cambio di tempo ha richiesto degli interventi per la protezione dalla peronospora, che in queste fasi è particolarmente pericolosa perchè potrebbe entrare nel grappolo. Grazie ai sistemi di viticoltura integrata, possiamo contenere questa malattia con un numero molto limitato di interventi, con prodotti a bassissimo impatto ambientale che non lasciano residui, ma molto efficaci per proteggere i nostri teneri grappolini in crescita. Evitiamo così di usare il rame, sostanza ecotossica e che richiede un numero di trattamenti molto più alto per avere una difesa sufficiente. Il rame è anche fitotossico in fioritura. Comunque, per fortuna, per noi la difesa dalla peronospora non è frequente. Ora è già tornato il clima caldo e ventoso che è la norma nella nostra costa toscana, per questo periodo.
Subito dopo l’allegagione è il momento delle cimature, cioè il taglio delle parti finali dei tralci in crescita, l'apice e le ultime foglie. È una pratica tradizionale antichissima, consigliata fin da Columella. Oggi sappiamo il perché. Non è comunque una pratica generalizzata, però apporta diversi vantaggi che ora provo a spiegarvi.
La cimatura fa parte della grande famiglia dei lavori detti di “potatura verde”, che modificano la chioma della pianta. Se fatti in modo opportuno, migliorano la produzione e la sostenibilità della vigna. Gli interventi al verde, in generale, servono per mantenere la chioma dentro certi limiti di crescita, altrimenti la vigna diventerebbe poco percorribile, con rischi di rotture accidentali dei tralci. Servono poi anche a regolare gli equilibri fra vegetazione e produzione. È infatti importante che la vite abbia una chioma sufficiente, in relazione alle proprie condizioni ambientali e produttive, per accumulare sufficiente energia sotto forma di zuccheri. Non è però solo questione di quantità: è anche fondamentale la loro corretta distribuzione fra le varie parti della pianta, se si vuole avere una maturazione ottimale. Alcuni interventi influiscono anche su questi equilibri energetici. Inoltre, la chioma non deve neppure essere troppa, per l'esposizione ottimale delle foglie e dei grappoli (questi, a seconda delle condizioni climatiche, a volte devono essere più esposti, a volte più protetti). Infine, la vegetazione troppo sovrapposta crea micro-ambienti sfavorevoli, umidi, che favoriscono diverse malattie. Quindi certi lavori di potatura verde servono anche a prevenire le infezioni di patogeni.
Andiamo nel particolare: perché si fa la cimatura?

Il motivo più “terra-terra” è togliere l’ingombro dei tralci che, cresciuti in altezza, possono ripiegare nell’interfilare. I risvolti fisiologici sono invece qui elencati, in modo sintetico:
- La cimatura rende le viti più resistenti agli stress idrici: le foglie apicali sono le più grandi consumatrici d’acqua. Togliendole, la pianta raggiunge un miglior equilibrio per le risorse idriche disponibili.
- Contribuisce alla nascita di vini più equilibrati: il taglio degli apici blocca lo sviluppo in altezza e stimola le gemme laterali, che formano i rami laterali o femminelle. Questo sposta gli equilibri interni, abbassa il vigore generale e comporta quindi una leggera diminuzione della produzione degli zuccheri, che nello stesso tempo sono però meglio veicolati verso i grappoli.
- Migliora il micro-clima della chioma: il taglio alleggerisce un poco la chioma, con maggiore illuminazione ed arieggiamento delle foglie sottostanti e dei grappoli, migliorando la qualità generale. Inoltre, si evitano micro-condizioni ambientali umide che favoriscono diverse malattie.
- Ringiovanisce la chioma: in un primo tempo in realtà la invecchia, perchè taglia le punte con le foglie giovani. In seguito però, lo stimolo dei rami laterali (femminelle) porta a far nascere nel corso della maturaziane tante nuove foglie giovani, molto efficienti nella fotosintesi. Quelle dei germogli principali, in questa fase, iniziano ad invecchiare. Il ringiovanimento complessivo contribuisce a supportare una maturazione ottimale, permettendo l’accumulo nel grappolo di tutti quei componenti che daranno ricchezza e complessità al vino.
Attenzione, però: come tutte le pratiche agricole, fatta bene è ottimale, fatta male crea problemi.
È ottimale in questa fase, subito dopo l’allegagione. Fatta troppo presto blocca l’accrescimento dei tralci e limita la parete fogliare (anche se in certi casi, per certe varietà, si è visto che, se fatta in pre-fioritura, può migliorare la percentuale dell'allegagione). Se viene fatta troppo tardi, la sua azione sui delicati equilibri fisiologici della vite può diventare più negativa che positiva, perché causa una diminuzione troppo forte della gradazione zuccherina e del peso dell’acino. Ad esempio, nei climi più freschi la crescita tardiva delle femminelle va a competere troppo con le bacche in maturazione per l’assorbimento delle risorse energetiche della pianta, a discapito delle seconde. Negli ambienti più caldi, viceversa, le cimature tardive non stimolano particolarmente la crescita dei rami laterali. Si rischia di portare via foglie senza benefici, ottenendo solo di diminuire la superficie fogliare.
Quanto tagliare? Dipende dalla propria situazione, ma di solito è poco. In genere bisogna evitare i tagli troppo drastici: non stiamo potando una siepe ornamentale! Come detto, se la chioma è troppo limitata, rischiamo conseguenze negative. Si è calcolato che è necessario che i grappoli abbiano un numero sufficiente di foglie sopra di sé per una maturazione ottimale (almeno una decina). Sono queste foglie sopra al grappolo a fornire gli zuccheri per la maturazione. Quelle sotto inviano i loro zuccheri essenzialmente ai tralci e agli organi perenni (tronco, radici). Se il rigoglio vegetativo è talmente intenso da richiedere tagli molto importanti, bisogna valutare di cambiare qualcosa d'altro nella gestione della vigna, a monte.
Seppure servono le attenzioni che ho spiegato, la cimatura non è un lavoro che richiede eccessiva precisione. Per questo, in un sistema a spalliera come il nostro, la sia può fare in modo meccanico, con un attrezzo portato dal trattore, anche perchè è molto importante concluderla velocemente, nella breve finestra di tempo che segue l'allegagione, senza andare troppo avanti.
Nuova annata: il Criseo Bolgheri Bianco 2018
L'attesa è stata un po' lunga ma finalmente è arrivata la nuova annata del nostro Criseo Bolgheri DOC Bianco, la 2018.
C'è sempre un po' d'attesa ma quest'anno è stata un po' più lunga del solito. Tutti gli anni lo finiamo prima che sia uscita l'annata successiva, perchè è un vino prodotto in piccola quantità. Nasce infatti da una singola vigna di soli 0,7 ettari, Campo Bianco, posta vicina al nostro guado, prima che inizi il bosco.
L'annata 2017 era stata ulteriormente scarsa: la siccità aveva ridotto notevolmente le rese produttive. Fra questo e quel poco più di attenzione derivata dall’aver ricevuto i TreBicchieri del Gambero Rosso, il 2017 è finito molto rapidamente. Se siete curiosi di assaggiarlo, c’è rimasta solo qualche ultima Magnum.
Il 2018 è stato un anno molto regolare, con caratteristiche di maggiore freschezza climatica rispetto al 2017. La primavera è stata molto piovosa e ha permesso di recuperare l’aridità dell’anno precedente. L’estate è stata invece nella norma, calda e siccitosa, senza particolari eccessi. Anzi, qualche breve pioggia ha un po’ rinfrescato le temperature a fine estate, senza creare problemi. Questo andamento stagionale ha permesso una maturazione più lunga del solito: abbiamo raccolto la vigna Campo Bianco il 10 settembre.
Questa data varia con le annate: in quelle più calde e aride può anticipare alla fine di agosto o nei primi giorni di settembre, in quelle più fresche si può spostare un po’ più avanti. L’importante è cogliere quel momento perfetto di maturazione sinergica, nel quale si trova l'equilibrio perfetto fra le varietà che vi sono in complantazione (Vermentino in prevalenza, Fiano, Verdicchio, Manzoni Bianco, Petit Manseng). In questa scelta conta molto l'esperienza che abbiamo maturato su questa vigna in oltre vent’anni.
Una volta un vino come questo era chiamato uvaggio. Le uve, che sono cresciute insieme nella vigna Campo Bianco e sono state raccolte insieme, dopo la selezione sono anche co-fermentate. Si tratta di una pratica antica tradizionale, capace di far loro esprimere una personalità unica.
Il suo gusto? Ha un bel corpo, è morbido ma bilanciato da una grande freschezza. Inoltre ha una complessità aromatica incredibile, con aromi che cambiano in continuazione via via che il vino si ossigena nel bicchiere. Si sprigionano profumi di pompelmo, frutta tropicale, pasticceria, salvia, fiori bianchi, zafferano, note minerali, idrocarburi, ... Nel tempo prevarranno sempre più questi ultimi, perché è un bianco che può avere un lungo invecchiamento, grazie al fatto che dopo la fermentazione è rimasto in acciaio sui lieviti per quasi un anno. Ora lo proponiamo dopo che è stato quasi un altro anno ad affinare in bottiglia.
È ottimo adesso, ma se amate i bianchi dalle note più evolute, come Michele e me, potete tranquillamente conservarlo in cantina (al fresco e con bottiglia coricata) per ancora qualche mese … o qualche anno. Se resistete!
Siamo aperti: vi stiamo aspettando
Guado al Melo è di nuovo aperta ai visitatori, con orari ridotti.
La vendita del vino è possibile:
dal lunedì al giovedì 10.00-12.30 15.00-17.30
venerdì 10.00-12.30 15.00-18.00
sabato 10.00-13.00 15.00-18.00
Le visite guidate e le degustazioni si fanno solo su prenotazione, chiamando il numero 0565 763238 o scrivendo a info@guadoalmelo.it
Grazie!
I lavori primaverili: cosa stiamo facendo adesso
In questo momento la crescita della vite è vertiginosa. Ci sono tanti lavori da fare che si susseguono a ritmo incalzante. Ognuno di essi ha un nome particolare: così imparate anche un po’ il linguaggio del vignaiolo!
Stiamo ormai concludendo i lavori di potatura verde, cioè di un insieme di diversi interventi che agiscono sulle parti verdi della pianta (foglie, germogli, tralci, grappoli), chiamata così in contrapposizione a quella "secca" o invernale (che abbiamo fatto sui rami spogli). Facciamo questi lavori tutti a mano, perchè richiedono scelte accurate per ogni singola vite. Vediamo quelli di questo periodo.
La spollonatura è l’eliminazione dei germogli che nascono dal portinnesto della vite, oltre che quelli che nascono sul fusto o altri rami legnosi dalle gemme latenti, rimaste nel legno vecchio. È importante farlo molto presto, prima che si sviluppino troppo. La scacchiatura invece è la rimozione dei germogli in eccesso dai tralci dell’anno.
https://youtu.be/nNVu7MpobYk
Tutti questi lavori di potatura verde sono importantissimi per far trovare alla vite il giusto equilibrio. Permettono di diminuire il carico della pianta, così che i futuri grappoli maturino il meglio possibile. Preparano la futura potatura invernale, che sarà più semplice. Inoltre, la massa fogliare viene resa meno densa, evitando così che si crei un ambiente di sovrapposizione ed umidità favorevole allo sviluppo di muffe o altre malattie. Infine, prevengono anche problemi di colatura. Col termine colatura si indica la caduta eccessiva dei fiori. In generale, rispetto ai fiori prodotti da ogni pianta, solo il 20-50% (dipende dalla varietà) verrà fecondato e allegherà, cioè formerà il frutto. Si parla di colatura se la caduta è superiore alla norma per quella varietà. Può dipendere da disequilibri fisiologici della vite, condizioni climatiche difficili, carenze nutrizionali, diverse malattie (virosi, peronospora, oidio, tignola, …).
Il lavoro che stiamo facendo ora è la palizzatura. Si tratta della sistemazione dei tralci in posizione verticale. Nei sistemi a spalliera come i nostri, si fa alzando una coppia di fili paralleli. Gli effetti sono numerosi: i tralci non invadono l’interfilare e noi non rischiamo di romperli nei passaggi con i mezzi, sono meglio distribuiti e meno affastellati. La posizione verticale, come ho già spiegato nel post sulla potatura, aumenta l’attività fisiologica dei germogli.
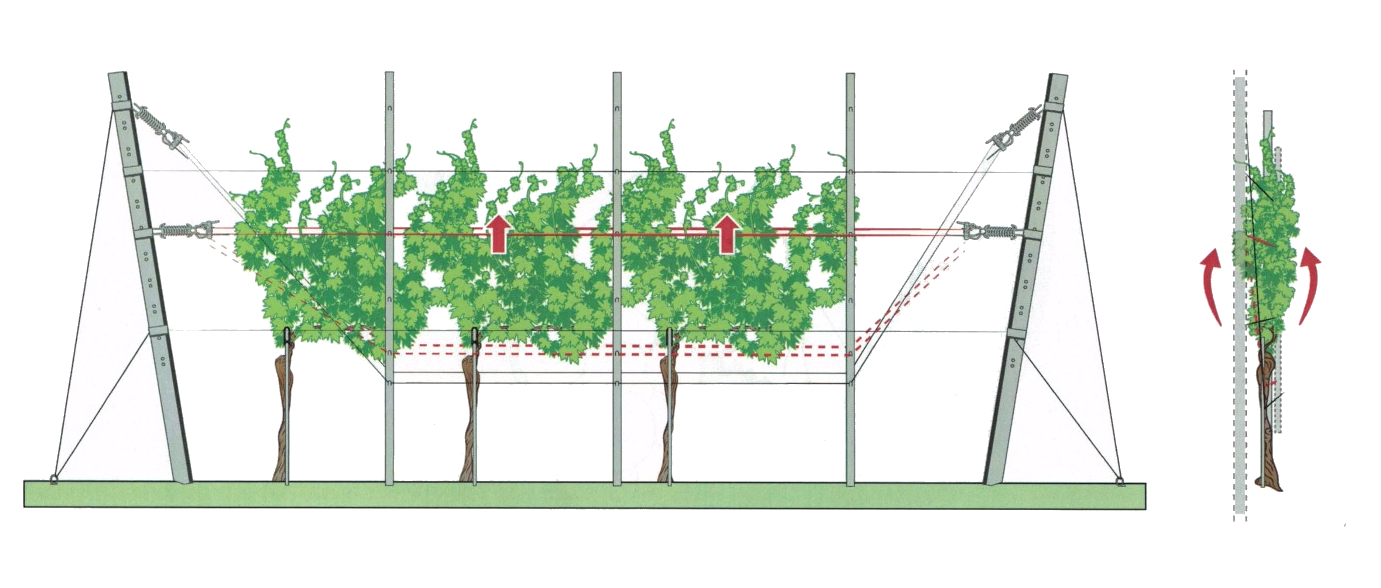
In questo periodo è anche molto importante capire, il prima possibile, se ci sono carenze nutritive della vite. Su questa parte così complessa sarà però necessario un post dedicato.
A seconda poi delle condizioni ambientali, dobbiamo anche intervenire per evitare i problemi dati dall’oidio e dalla peronospora, secondo i principi della viticoltura integrata e sostenibile. In questa primavera 2020, almeno per ora, siamo un po’ più a rischio oidio che peronospora, come è usuale per le condizioni climatiche del nostro territorio. Sono le zone più umide e piovose che hanno in genere più problemi con la peronospora. Per quanto riguarda la tignoletta, abbiamo già distribuito nella vigna le trappole e i sistemi di confusione sessuale (lotta biologica). Se cliccate sui nomi, potete andate ai post in cui spiego cosa facciamo per ciascuna di queste avversità.
Il verde tra le vigne, ovvero la gestione sostenibile del suolo
Terreno “nudo”, prati dai mille fiori, monoculture seminate, pratini stile campo da golf, strisce verdi alternate ad altre marroni …
Avrete sicuramente visto nelle vigne tante situazioni diverse nella gestione del suolo. Non si tratta solo di una questione estetica o casuale. Alla base di queste scelte ci sono ragionamenti e necessità diverse, che proverò a spiegarvi in questo post.
[one_third][info_box title="Cosa significa sostenibile?" image="" animate=""]Oggi la parola sostenibilità è usata in tanti contesti e non sempre in modo corretto.
Una pratica agricola, per essere effettivamente sostenibile, non basta che suoni come vagamente "green" o "bio", ma deve dimostrare di funzionare per lo scopo che si prefigge. Deve soddisfare contemporaneamente queste diverse condizioni:
- Deve essere la scelta migliore in termini agrari. In questo caso, deve consentire alle viti di raggiungere un equilibrio ottimale rispetto alla situazione ambientale particolare. Per trovare la risposta dobbiamo quindi chiederci com’è il clima, il suolo, la pendenza, la disponibilità dell’acqua, quali portinnesti e varietà abbiamo, quanto produce quella vigna, il tipo di vino voglio produrre (giovane, da invecchiamento, spumante, ecc.), ...
- deve avere il più basso impatto sull’ambiente possibile (sostenibilità ambientale), dimostrato da studi e ricerche;
- non deve avere costi troppo alti (sostenibilità economica);
- deve rispettare i lavoratori (sostenibilità sociale).
Non è semplice trovare il sistema che le soddisfi pienamente tutte insieme. L'importante è trovare l’equilibrio migliore fra di esse. L'essenziale è avere dei sistemi di controllo che possano farci capire se stiamo lavorando bene, sia in termini di qualità che di sostenibilità o che, viceversa, è meglio cambiare qualcosa (ne parlo nel paragrafo "Capacità di scegliere").[/info_box][/one_third]
Storicamente nelle vigne ha prevalso a lungo il suolo costantemente lavorato. Ad esempio, quando abbiamo iniziato a lavorare a Bolgheri alla fine degli anni ’90, tutte le vigne erano nude. Noi abbiamo invece impostato fin dall'inizio una scelta diversa, l'inerbimento, in linea con le più avanzate ricerche di viticoltura integrata e sostenibile.
Negli anni la situazione è abbastanza cambiata un po’ ovunque e negli ultimi decenni l'inerbimento si è diffuso sempre più, con diverse impostazioni a seconda dei territori. Alla luce delle attuali conoscenze, è la forma che presenta più vantaggi ecologici ed economici, oltre che qualitativi, in grado di preservare la qualità del suolo e gli equilibri della vite. Se leggere fino in fondo capirete il perché.

Non è giardinaggio
La gestione del suolo non è solo questione di ordine, di avere un bel paesaggio da ammirare. Ha delle ripercussioni importanti sull’ecosistema generale della vigna e sulle sue risorse naturali, oltre che sugli equilibri delle viti stesse, quindi sull’uva che andremo a raccogliere. Naturalmente non agisce da sola sulla produzione: va integrata con tutte le altre scelte e lavorazioni dell'anno.
A volte si sceglie l'una o l'altra gestione per abitudine, perché si è sempre fatto così, perché altri fanno così, ecc. In realtà dovrebbe dipendere essenzialmente dalle condizioni climatiche ed ambientali nelle quali si trova la vigna, dalle varietà e dai portinnesti utilizzati, oltre che da quale tipologia di vino si produce. Come ho spesso ripetuto, la viticoltura è qualcosa che va pensata sempre su misura, non esistono scelte migliori uguali per tutti, pur essendoci delle linee guida di base consolidate dagli studi e dall’esperienza.
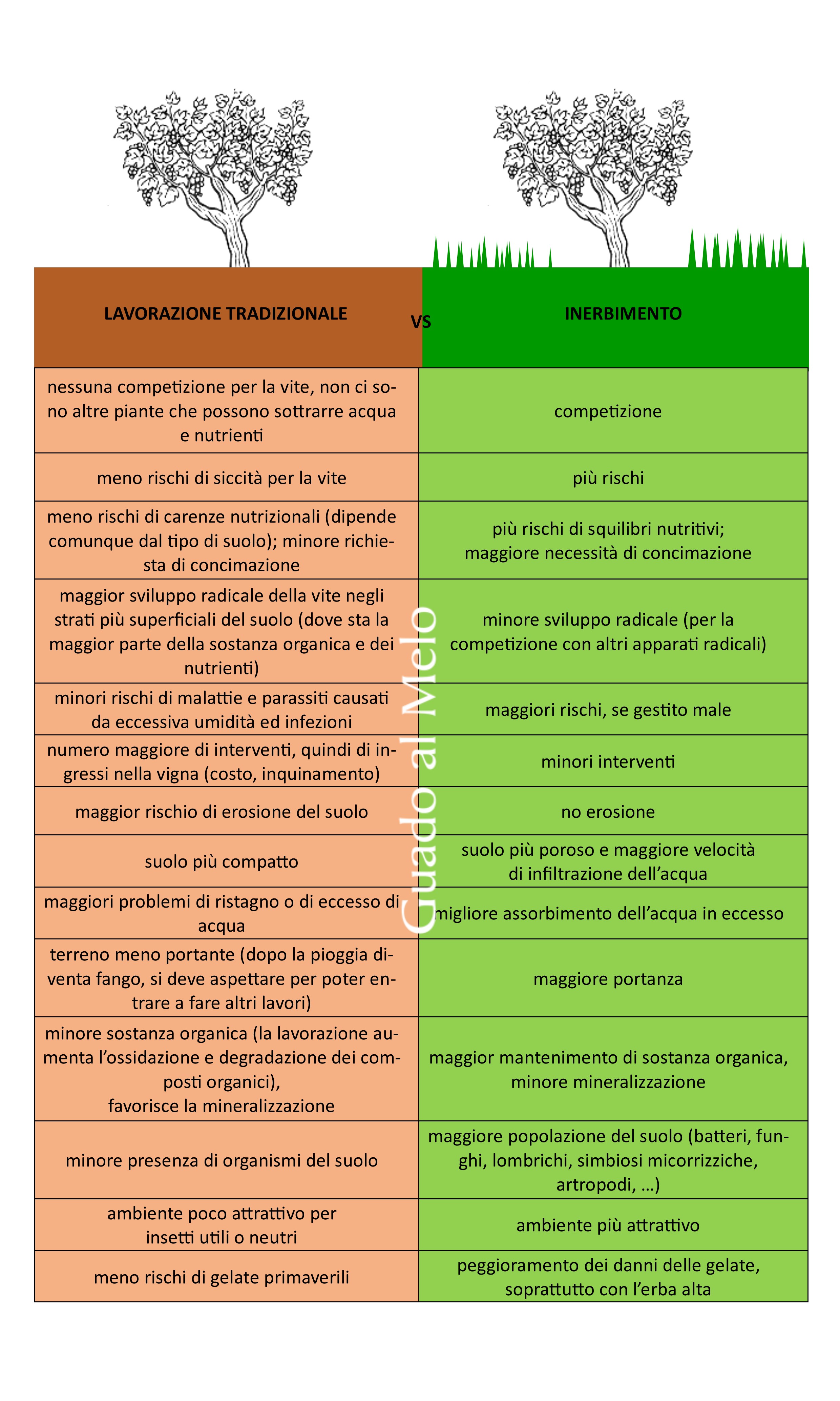 Meglio il prato o il deserto?
Meglio il prato o il deserto?
Fra le tante situazioni intermedie che si possono avere, sono due le categorie principali: le lavorazioni tradizionali, che portano a far sparire fino all’ultimo filo d’erba, e la presenza di vegetazione (inerbimento).
Queste due categorie principali portano dei pro e dei contro, che ho provato a schematizzare nel grafico a lato. Come vedete ci sono vantaggi e svantaggi sia a destra che a sinistra della tabella. Quale situazione allora è migliore?
Il punto nodale è legato alla competizione fra la vegetazione e la vite, per l'acqua e gli elementi nutritivi (sali minerali). Sicuramente la vite non è una pianta che ha grandi richieste idriche, ma non deve neppure diventare un fattore limitante. La presenza di altra vegetazione può pesare in modo molto sfavorevole, soprattutto se la vigna è già in condizioni al limite.
La competizione ha fatto a lungo pendere la bilancia a favore della lavorazione continua, soprattutto in epoche in cui era rilevante la quantità di uva prodotta e nei territori con limiti d'acqua più o meno importanti.
L'inerbimento comporta una minore espansione della vite, meno germogli, una chioma meno ampia e meno densa, rese produttive più basse. Si è visto anche che si hanno mosti con contenuti zuccherini mediamente più alti e con un aumento dei polifenoli ed antociani (nelle uve nere). C’è però una minore presenza di azoto nel mosto disponibile per i lieviti. Queste conseguenze non sono così negative per una produzione votata più alla qualità che alla quantità.
Passare però dal vantaggio allo svantaggio a volte è un attimo in viticoltura. Se mal gestita, la competizione può realmente portare ad un deperimento troppo elevato delle viti. In questo caso il problema non sarà solo la scarsa quantità (che oggi può anche non farci paura), ma la produzione di un’uva povera di elementi fondamentali, non in grado di originare vini complessi ed interessanti.
Nella vigna inerbita la chioma è meno espansa e meno densa. Questo comporta anche una minore suscettibilità a diversi parassiti. Il contagio però può aumentare anche con una cattiva gestione della vegetazione, soprattutto se la si lascia crescere a dismisura. La massa vegetale può aumentare troppo l’umidità locale, soprattutto a ridosso delle viti, innalzando la possibilità d’infezione di diverse muffe o funghi.
La differenza, come sempre, sta nella gestione, nella sensibilità e capacità del viticultore di mantenere un rapporto equilibrato nella competizione fra copertura e viti. Solo così di hanno tutti i vantaggi dell'inerbimento e si minimizzano gli svantaggi.
L'inerbimento porta a degli indiscussi vantaggi ambientali che mancano nella lavorazione tradizionale. Preserva al meglio la qualità del suolo e tutti gli aspetti che ne derivano. Consente infine un numero minore di ingressi nella vigna, con risvolti ecologici e anche costi minori.

Aree di confine nella vigna
Prima di scendere nello specifico della gestione, considerate che il suolo della vigna non è tutto uguale. Ci sono due aree ben distinte, che hanno problemi e necessità di lavoro molto diverse.
Uno è il sottofila o sottofilare (nel caso del filare), comunque lo spazio a stretto ridosso delle viti. In questa zona la competizione è massima, con in più i problemi pratici di lavorare senza danneggiare le viti.
L’interfilare è la zona intermedia, dove la competizione sfuma, ci sono meno problemi pratici legati all’ingombro delle viti ma con molte altre variabili per le scelte operative.
La lavorazione continua del suolo
Fin dalle epoche più antiche si trova l'indicazione di lavorare il suolo almeno tre volte l'anno: al germogliamento, all'allegagione del frutto e all'invaiatura. L'introduzione della meccanizzazione ha portato ad interventi sempre più frequenti, al punto di eliminare tutta la vegetazione spontanea con lavorazioni continue e, in qualche caso, il diserbo.
In passato si vedevano più rischi che vantaggi nella competizione tra viti e flora spontanea, anche perchè erano momenti in cui la produzione cercava in genere di ottenere quantità. Quando si è iniziato a parlare in modo generalizzato di riduzione delle rese (soprattutto dagli anni '90), il suolo nudo ha costretto spesso a dover intervenire drasticamente in altri punti chiave per "risettare" gli equilibri della vigna.
Il metodo più tradizionale per ottenere il suolo nudo era (è) la lavorazione frequente. Gli strumenti più vecchi erano anche invasivi: si facevano vere e proprie arature o interventi che sminuzzavano le zolle in modo fine (come alcune zappatrici rotative molto usate fino agli anni '90). Nel tempo sono però emersi gli effetti negativi di questo modo di operare, legati soprattutto all’impoverimento della componente organica del suolo, ai fenomeni di erosione, al dilavamento, la formazione della cosiddetta "suola di lavorazione", l'asfissia radicale e le carenze nutrizionali (come la comparsa di clorosi ferrica). I frequenti ingressi con le macchine portavano ad un ulteriore compattamento del terreno e un alto consumo di gasolio, peggiorati nel caso di uso di mezzi grandi e pesanti.
Una lavorazione invasiva rischia anche di rovinare le radici della vite. La maggior parte di esse si trova nella fascia di suolo dove sono concentrate le sostanze nutritive, che è relativamente superficiale (non si spinge oltre i primi 50 cm). La massa principale delle radici si trova mediamente fra i 25 e i 45 cm di profondità, una zona che rischia di essere "massacrata" da lavorazioni troppo profonde.

Il diserbo alla francese
Già in passato si vedevano i limiti delle lavorazioni continue e si sono cercate strade alternative, con il fine di diminuire sempre più gli interventi. Dagli anni ’50 cominciò a diffondersi l’uso dei diserbanti, che sembravano superare tanti problemi della lavorazione continua, con maggiore velocità d’azione ed un numero inferiore di ingressi nella vigna.
In Italia sono stati usati (o sono usati anche oggi) quasi esclusivamente per il sottofila. L’uso sull’intera superficie è molto più diffuso in altre nazioni, come ad esempio la Francia. L’INRA aveva investito molto negli studi in questo ambito e diffuse la pratica detta della “non coltura” (“no tillage”), che prevedeva l’abbandono quasi totale delle lavorazioni a favore dei diserbi. Alla fine degli anni ’80 si era arrivati ad un’amplissima diffusione in tutta la Francia vinicola, con punte fino al 98% (nella Champagne). Ancora oggi è molto diffuso.
Nel tempo sono però emersi anche diversi problemi. Ad esempio, si è presentata la problematica del dilavamento di queste sostanze nelle falde acquifere. Si è visto che l’uso prolungato dei diserbanti causa comunque un’alterazione della struttura del suolo. Diventa più compatto in superficie, con minore ricircolo d’aria e infiltrazione d’acqua, oltre che una diminuzione della sostanza organica. Sembra che questi effetti siano legati alla riduzione della sua componente microbica. Infine, ci può essere sempre il rischio di uno sviluppo o selezione di piante resistenti.
Nel tempo alcuni prodotti che lasciavano residui, i disseccanti, sono stati prima limitati e poi abbandonati. Nonostante la ricerca si sia orientata a studiare prodotti più sostenibili, i diserbanti hanno però sempre raccolto molta diffidenza.
Nell’ultimo decennio, soprattutto, c’è stata una forte campagna contro il glifosate, il principio attivo ormai più usato al mondo. Gli studi scientifici sembrano dimostrare la sua biodegradabilità e la non nocività (con un uso corretto). I detrattori sostengono che però non si è certi dei suoi effetti e del fatto che non persista nell’ambiente. Fatto sta che ormai l’opinione pubblica si è schierata contro, il che sta portando la politica europea verso la prevalenza di un principio di precauzione. La regione Toscana, ad esempio, lo ha messo già al bando dal prossimo anno.

L’inerbimento, ovvero la flora come risorsa
Michele si ricorda ancora di quando suo padre Attilio, negli anni '70, aveva iniziato a lasciare le vigne inerbite nell'azienda storica di famiglia Vallarom, in Trentino, mentre intorno il terreno era quasi tutto nudo. Erano gli anni pionieri della viticoltura integrata e sostenibile, nata negli anni '60.
Queste pratiche hanno iniziato ad uscire dalla nicchia soprattutto negli anni '90, grazie alla diffusione di una sempre maggiore sensibilità ambientale, al crescere dell'esperienza e al supporto di ricerche sempre più avanzate. La viticoltura di quegli anni si era poi orientata sempre più verso basse rese produttive e la competizione non faceva più così paura.
La viticoltura sostenibile non ha stravolto la vigna e le scelte del passato ma ha cambiato l'approccio. Non vede più la flora come un intralcio ma come una risorsa che, se ben gestita è in grado di mantenere equilibri ottimali in vigna, preservando nello stesso tempo le risorse naturali (suolo, biodiversità, acqua), e permettendo una riduzione importante degli interventi (la "non coltura" o "no tillage" cercato da tempo; ricordate?).
"Ben gestito" non significa seguire tutti una sola direttiva, ma valutare le scelte a seconda del proprio territorio, della singola vigna o anche particella. L’inerbimento sempre presente (permanente) è ottimale dove c’è una disponibilità di acqua molto buona in tutte le stagioni. Nei territori dove l’acqua è un po’ meno disponibile, può bastare a volte la lavorazione del solo sottofila per bilanciare la situazione. Se l'acqua è ancora più carente o ci sono momenti dell’anno di forte siccità, l’inerbimento può essere interrotto momentaneamente con delle lavorazioni. Queste possono riguardare l'intera superficie o solo parti, come ad esempio a filari alterni. Ricordiamo comunque che nei periodi siccitosi l'erba in genere secca spontamente, elimandosi da sola.
Le lavorazioni sono comunque notevolmente ridotte, sia come numero che come impatto, rispetto alle profonde e continue lavorazioni del passato. Oggi, nella gestione sostenibile, si usano attrezzi che stanno in superficie. Inoltre non sminuzzano troppo il suolo, ma mantengono il più possibile integre le zolle. La lavorazione ha comunque il beneficio di permettere il sovescio, cioè di interrare leggermente i resti vegetali ed i concimi, per rendere più veloce l'arricchimento del suolo in materia organica e componente minerale.

Prato spontaneo o seminato?
L’inerbimento naturale, che abbiamo scelto anche noi, integra la vigna nel suo ambiente naturale, nel paesaggio. La flora è molto varia (alta biodiversità). Ci sono molte specie che fioriscono a scalare per diversi mesi e creano un ambiente attrattivo per la micro-fauna locale, che altrimenti se ne andrebbe altrove. C'è poi l’aspetto assolutamente positivo del costo, che è pari a zero: la natura si rigenera da sé, senza spese per il seme ed i passaggi di lavoro per la semina.
Un prato abbandonato tende però nel tempo verso il predominio di alcune specie, soprattutto quelle a foglia larga (es. il tarassaco, la malva, ecc.) che sono anche fra le più competitive con la vite. Alcune, come il convolvolo e l'ortica, attirano una cicalina, un insetto che trasmette un fitoplasma (un organismo simile ai virus) che causa una malattia della vite detta "legno nero". Masse vegetali troppo dense aumentano l'umidità e il rischio di certe malattie. I tagli periodici evitano però questi pericoli. Inoltre favoriscono lo sviluppo di più essenze, soprattutto graminacee, che danno maggiore complessità.
Il prato spontaneo può non essere la scelta migliore in certe situazioni come, ad esempio, dove ci sono grossi problemi di erosione, se la flora spontanea è lenta a crescere o fatica a distribuirsi su tutta la superficie.
L’inerbimento artificiale richiede invece la semina di una o più specie scelte con precise finalità. Questo comporta un aumento degli interventi in vigna e costi più alti. Crea un ambiente, con una o poche specie, molto meno attrattivo per la micro-fauna del luogo.
Nelle zone mediterranee si preferiscono spesso alcune leguminose, che non hanno grandi necessità di acqua, si insediano velocemente e hanno una crescita veloce. Non sopportano però il calpestamento. Sono state a lungo utilizzate perché si pensava che, col sovescio, arricchissero il suolo in modo importante di azoto, ma ormai si è visto che non è proprio così. Consentono comunque un arricchimento generico in materia organica.
Il massimo risultato in questo senso si ottiene con le graminacee, che formano una biomassa più consistente. Sono più usate nel centro-nord perché hanno in genere una maggiore richiesta idrica. Sono miscele ben studiate per le diverse situazioni, composte da diverse festuche e loglietto, con crescita lenta e la capacità di formare un prato denso e compatto, che evita molto bene i fenomeni di erosione.
Il controllo dell’erba e la pacciamatura
Nel nord, o nei luoghi più freschi, la crescita dell'erba è continua dalla primavera fino all’autunno, per cui saranno richiesti diversi interventi di taglio. La semina artificiale può consentire di scegliere graminacee a crescita lenta. Nelle zone più siccitose e mediterranee, come la nostra, il problema è esclusivamente primaverile. Da giugno-luglio in poi la vegetazione secca spontaneamente e non è più un problema.
La pacciamatura è un sistema sostenibile, che usiamo anche noi in primavera, e che permette di controllare la vegetazione limitando gli interventi. Non è niente di nuovo: consiste nel lasciare in vigna l'erba tagliata e trinciata, così come i tralci delle potature triturati ed altri scarti vegetali. Questi formano uno strato organico-minerale che limita naturalmente la crescita vegetale. Nel tempo si degrada, diventa compost ed arricchisce il suolo.
Nel video sotto si vede un esempio di pacciamatura che facciamo a Guado al Melo, in questo caso nella capezzagna. Lo stesso si fa tra i filari.
https://youtu.be/0R9OH_vDiqo

Il sottofila, la difficoltà degli spazi stretti
La vegetazione a stretto ridosso della vite porta sempre più problemi che vantaggi: sottrae nutrienti e vigore alla vite, ne limita lo sviluppo radicale, può portare umidità e maggiori rischi di malattie e parassiti, … Per questi motivi in genere nel sottofila si preferisce mantenere il suolo nudo. Solo in quei territori dove c’è abbondanza d’acqua vi si può tenere la vegetazione, sempre che sia ben curata e non si notino squilibri nutrizionali della vite.
Il metodo più tradizionale per mantenere pulito il sottofila è la lavorazione del suolo, a mano o meccanica. In passato zappavano solo a mano. Si fa ancora oggi nelle vigne giovani, per non danneggiare le barbatelle, mentre in tutti gli altri casi si usano ormai mezzi meccanici.
A lungo i mezzi meccanici sono stati un rischio per questa fascia ristretta, perchè potevano rovinare le radici ed il piede della vite, rompendolo o scortecciardolo (col rischio di malattie). Questo problema ha spinto diversi produttori alla scelta del diserbo nel sottofila, a cui ho accennato sopra, che evita questo inconveniente.
Il progresso tecnologico degli ultimi decenni ha però portato ad attrezzi che fanno questo lavoro in modo sempre più rispettoso, sia nei confronti delle viti che del suolo. Hanno sensori che rilevano in modo sempre più preciso la presenza della vite e la evitano. Le viti giovani che possono esserci nella vigna sono protette con dei cilindri detti “shelters” (foto). Inoltre tendono a stare in superficie, per evitare di danneggiare le radici. Anche noi ne abbiamo provati e cambiati diversi negli anni. Per il viticultore non sono secondari certi aspetti di dettaglio che possono renderli più o meno performanti, anche a seconda del proprio tipo di suolo. È importante che lavorino bene e che consentano di procedere non troppo lentamente in vigna.
Esistono altri sistemi che non mi pare abbiano grande diffusione, per problemi vari (costi alti, bassa qualità, ecc.). Ad esempio ricordo il pirodiserbo, col calore. Un altro sistema è la pacciamatura del sottofila, ma in questo caso non funziona molto bene, se non in certe situazioni. Ad esempio in Trentino Alto Adige viene fatta con l’erba dell’interfilare, che forma grandi masse: ci sono attrezzi che la tagliano e l'ammucchiano nel sottofila. Oppure si fa spargendo trucioli, vinacce esauste, cortecce, ecc. Infine, ci sono casi in cui la pacciamatura di vigneti appena piantati viene fatta col film plastico (come per gli ortaggi), ma è solo temporaneo.
Nel video sotto si vede il nostro attrezzo che lavora nel sottofila, scansando le viti.
https://youtu.be/LdBI46l_C8Q

Capacità di scegliere
Viste tutte queste premesse, capirete che le scelte possono essere diverse e ricche di sfumature, soprattutto in dipendenza delle condizioni ambientali delle vigne. Il viticoltore, conoscendo a fondo le proprie situazioni, decide le impostazioni migliori: che tipo d'inerbimento, come e quanto lavorare il suolo, se farlo in modo uniforme o solo a filari alterni, ecc.
Sta poi alla sensibilità e capacità di osservazione del vignaiolo capire come le vigne rispondono alle scelte fatte, vivendole ogni giorno e negli anni, facendo anche prove in aree limitate, non smettendo quindi mai di cercare d’imparare e migliorare.
Sono diversi i punti nodali da tenere sotto controllo per capire se la gestione richiede (o meno) qualche variazione. Si deve valutare lo stato di crescita e salute delle viti, oltre che la qualità e quantità dell’uva ottenuta. Per quando riguarda la sostenibilità ambientale, si fanno test di biodiversità, analisi del suolo e dell’acqua, oltre che dell'assenza di residui nel vino.
Bisogna anche saper cogliere i cambiamenti delle annate e delle variazioni climatiche di periodi più lunghi, cambiando l’impostazione di conseguenza. Ad esempio noi, dopo anni di inerbimento permanente, abbiamo fatto alcune variazioni, a causa del trend di innalzamento medio delle temperature dell’ultimo decennio e di cambiamenti nella piovosità locale. Siamo passati, in alcune zone, ad un inerbimento con lavorazioni a filari alterni, con rotazione periodica.
Curare la vigna è un percorso di crescita, non di stasi.
Vigne da Instagram
 Chiudiamo questo capitolo con questa bella immagine che sembra essere uscita da un libro di agronomia ottocentesco. Non è rara ormai. Ultimamente se ne vedono sempre più sui social. Mostrano il ritorno ad usare animali in vigna, come in passato, al posto del trattore. Si vedono soprattutto i cavalli, raramente i buoi. Nelle vigne italiane, storicamente, questi lavori si facevano soprattutto con gli asini o anche piccole mucche.
Chiudiamo questo capitolo con questa bella immagine che sembra essere uscita da un libro di agronomia ottocentesco. Non è rara ormai. Ultimamente se ne vedono sempre più sui social. Mostrano il ritorno ad usare animali in vigna, come in passato, al posto del trattore. Si vedono soprattutto i cavalli, raramente i buoi. Nelle vigne italiane, storicamente, questi lavori si facevano soprattutto con gli asini o anche piccole mucche.
Sicuramente sono immagini pittoresche e di grande effetto, che rispecchiano una certa tendenza nostalgica di oggi a rimpiangere "i tempi che furono" dell’agricoltura. Era meglio allora? Era peggio? Sì e no: dobbiamo saper distinguere fra l’eredità utile del passato e quella no, se non vogliamo solo una viticoltura da Instagram.
La lavorazione del suolo col traino animale è una pratica molto evocativa, ma di fatto è poco sostenibile.
Come avete letto finora, oggi la sostenibilità si dirige in un'altra direzione, verso forme di non lavorazione. Nel sottofila, dove eventualmente si deve intervenire un po' di più, è impossibile (ai tempi zappavano a mano). Non è neppure il sistema migliore per la qualità del lavoro: come ho spiegato sopra, oggi ci sono attrezzi che permettono di gestire il suolo e l’integrità delle viti in modo molto migliore rispetto a quelli di vecchia generazione.
Comunque, è fattibile, ragionevolmente, solo per vigne minuscole, usate come “immagine” o da parte di hobbisti. È poco proponibile in tutti gli altri casi: è faticosa per l’animale e per l’uomo, oltre che troppo lenta. I tempi di crescita delle erbacce e delle viti sono rapidi in primavera: in poche settimane cambia tutto ... e sono tantissimi i lavori che incalzano. Infine, non scordiamoci che i lavori in vigna sono tanti e molti richiedono per forza un trattore. Parlo del taglio dell'erba, delle trinciature, delle cimature, ecc.
Non perdiamo di vista quello che ci serve veramente: una sostenibilità reale e razionale, di sostanza, capace di garantire un futuro al nostro lavoro e alla nostra terra.
Bibliografia:
"Viticoltura di qualità", Mario Fregoni, 1998, Edizioni l'Informatore Agrario.
"La vite e il vino", Renzo Angelini ed altri, 2007, ed. ART.
"Manuale di viticoltura", Alberto Palliotti ed altri, 2018, Edagricole.
"Difesa sostenibile delle colture", Paola Battilani, 2016, Edagricole.
"La nuova viticoltura", Alberto Palliotti e altri, 2015, Edagricole.
"View from the vineyard. A practical guide to sustainable winegrape growing", Clifford P. Ohmart, 2011, ed. The Wine Apprecciation Guild.
"Vine roots", E. Archer and D. Saymaan, 2018, The Institute for Grape and Wine Sciences (IGWS), Stellenbosch University.
Tutti i giorni Earth Day
Oggi è il Giorno della Terra ma lo dobbiamo ricordare tutti i giorni, più con le azioni che con le parole. Noi viticoltori sappiamo bene che se il nostro lavoro non è sostenibile, non può avere un futuro.
Per questo scegliamo ogni giorno le migliori pratiche attuali di viticoltura sostenibile integrata, che garantiscono 0 residui nel vino e nell’ambiente, oltre che una ricca biodiversità in vigna.
Per questo abbiamo costruito una cantina interrata, che “sparisce” nel paesaggio, che ci permette di risparmiare il 70% di energia, con un sistema di riciclo dell’acqua piovana che riduce i consumi del 40% (per tutti gli usi interni per cui non serve acqua potabile).
Per questo in cantina lavoriamo con sapienza artigianale, rispettosa delle uve e dell’esaltazione del nostro patrimonio più prezioso: il nostro territorio.
Trovate più informazioni sul nostro sito web.
I lavori in vigna di aprile: la sostituzione delle viti
Fa parte della normale vita di un vigna: ogni tanto, soprattutto andando in là con gli anni, anche le viti possono morire. Succede per tanti motivi: malattie o parassiti che prendono il sopravvento, colpi di freddo o per semplice fine del ciclo vitale. Quindi, togliamo le viti morte e al loro posto piantiamo nuove barbatelle, le piccole viti.
Prima scaviamo per togliere le radici della vecchia vite e riempiamo di nuovo la buca. Questo passaggio ammorbidisce la zolla di terra che cos' è pronta per l'impianto.
Per piantare le barbatelle poi Michele usa la gruccia, lo strumento che vedete nella foto e nel video. È una barra che finisce con due punte. Fra queste è possibile inserire la piantina e, facendo forza sulla barra, piantarla nel terreno senza danneggiarla. Sono infatti le punte a premere e a scavare nel terreno. Si tratta di uno strumento da lavoro antichissimo. Risale ai tempi degli antichi Romani. Allora si chiamava “pastinum”.
Le vigne dell'antica Roma, fra "l'otium" del proprietario ed il lavoro del vignaiolo
(continua da qui)
Secondo Columella, chi vuole iniziare un'attività agricola non deve mancare di tre cose: la conoscenza, la volontà di fare e la capacità di spendere. In realtà, dice, potrebbero bastare le prime due. Tuttavia ci ricorda, con ironia neanche troppo sottile, che la possibilità di spendere torna utile soprattutto a chi manca di conoscenza, perché così può supplire agli errori che fa.
Niente di più vero!
[one_second][info_box title="La quieta villa tra le vigne di Plinio il Giovane" image="" animate=""]

In una lettera all'amico Domizio Apollinare (detta ""della villa in Tuscis"), Plinio il Giovane racconta con orgoglio della splendida vista sulle sue ampie vigne, che può godere dalla sua villa nell'Alta Valle del Tevere.
Plinio era nato a Como il 61 o il 62 d.C. (morì nel 113-114) ed era nipote del celebre (e da me più volte citato) Plinio il Vecchio (zio per parte di madre). Era un avvocato ed un alto funzionario dello stato. Aveva grandi proprietà in diverse parti d'Italia ma la più amata sembra che fosse proprio la tenuta della valle del Tevere, in Etruria (chiamata Tuscia dai Romani). Si trova nell'attuale Umbria, tra San Giustino e Città di Castello.
Non siamo più ai tempi dei 100 jugeri di Catone o della piccola (ma meravigliosa) vigna di Palemone. Stiamo parlando di un grande latifondo, che Plinio ha soprattutto ricevuto in eredità ed, in piccola parte, ingrandito personalmente. Possedeva proprietà terriere per un totale stimato di circa 10.000 ettari, sparsi fra una villa sul mare, quella sulle colline della Tuscia e due sul Lago di Como, oltre che una casa signorile a Roma e una a Como. La proprietà della Tuscia comprendeva ottomila jugeri, circa 2.000 ettari (1 jugero è più o meno ¼ di ettaro), con diverse coltivazioni, che gli rendevano un affitto di 400.000 sesterzi annui.
Siamo ben lontani dalla figura del vignaiolo. Infatti lo stesso Plinio dice che ama questa tenuta più delle altre essenzialmente perché la ritiene la più comoda e di maggior agio, abbastanza lontana da Roma da permettergli una perfetta tranquillità. Qui poteva dedicarsi in pace al suo otium che, per l'intellettuale romano dell'epoca, era il tempo che poteva impiegare allo studio e alla riflessione, quando era libero dalle incombenze della vita politica e pubblica.
Plinio rappresenta ancora il grande proprietario che ben gestisce le sue proprietà, non il latifondista che le dedica soprattutto al pascolo, abbandonandole al degrado del saltus. Scrive chiaramente, con la sua mentalità patrizia tradizionale, che per lui l'unico guadagno legittimo è quello che deriva dalla terra. Infatti non impiegò il suo patrimonio in altre forme d'investimento. Nei suoi scritti ammette, non si sa quanto onestamente, di non sentirsi ricco. Afferma che le sue rendite, fra l'altro oscillanti (come normalmente succede in agricoltura), sono appena sufficienti per permettergli di sostenere il decoro richiesto dalla sua posizione di senatore. Gli consentono giusto una vita frugale, con la possibilità di concedersi solo ogni tanto qualche spesa extra. Fu oculato comunque anche in queste, oltre che filantropo: a parte l'acquisto di statue e la costruzione di templi nelle sue proprietà, donò un appezzamento di terra alla sua ex-nutrice e fece diverse donazioni alla sua città natale, Como. Vi costruì una biblioteca pubblica, creò una cassa alimentare per i poveri, dando in concessione delle sue proprietà. Nel testamento, lasciò in eredità alla città degli edifici termali.

Tornando alla lettera e alla sua tenuta in Tuscia, egli descrive con evidente amore il paesaggio appenninico. Si tratta di un ampio anfiteatro contornato dai monti ricoperti dai boschi. Le coltivazioni si estendono sia in pianura che sulle colline, "ricche di terra grassa".
"Ai loro piedi e per ogni lato si stendono vigneti che intrecciano in lungo e in largo un’unica trama; dal loro limite, quasi dal loro margine in basso, si dipartono viti alberate" (Sub his per latus omne vineae porriguntur, unamque faciem longe lateque contexunt; quarum a fine imoque quasi margine arbusta nascuntur).
Le prime pendici delle colline sono completamente rivestite da vigneti, vinea, le viti basse aggiogate. Circondano completamente la villa di Plinio e, come racconta, sembrano quasi entrare nelle stanze. Nella zona più pianeggiante si trovano invece le lunghe file degli arbusta, le viti maritate, alternate ai campi e ai prati. Purtroppo, come potreste leggere in altre traduzioni di questa celebre lettera, chi non conosce la viticoltura romana traduce arbusta con boschetti o anche siepi (sic!). La vite maritata è stata ed è ancora spesso persa nella traduzione, come avevo già raccontato qui.
La descrizione di Plinio è stata confermata dalle ricerche archeologiche nella valle del Tevere. Le zone pedecollinari erano state scelte dai ricchi per le loro ville ed erano dominate dai vigneti intensivi, coltivati con il lavoro degli schiavi. La pianura era invece soprattutto dei coloni (piccoli agricoltori). Originariamente erano proprietari di appezzamenti assegnati in passato con la centuriazione. Poi, all'epoca di Plinio, erano diventati dipendenti dei latifondisti.
Sembra che Plinio, come tanti altri proprietari, vendesse l'uva in pianta a degli imprenditori che si occupavano della vendemmia, della produzione e vendita del vino. Il mercato principale del prodotto era Roma città. La cosa curiosa, ma che sembra frequente all'epoca, è che Plinio (o più facilmente il suo amministratore) non si preoccupasse di vendere solo l'uva della proprietà padronale ma anche dei coloni. Può sembrarci normale nel caso in cui il colono pagasse in natura (una quota di uva o vino), sistema detto colonia partiaria. L'aiuto era però anche nel vendere la parte di prodotto del colono. Oltre tutto, succedeva lo stesso anche nel caso che il colono versasse l'affitto in denaro (detto locatio-conductio). In questo caso, il latifondista aiutava il colono a monetizzare il suo lavoro, assicurandosi così di ricevere la sua spettanza. Il rapporto sociale sembra molto equilibrato, ancora lontano dallo sfruttamento da "servi della gleba" che i coloni subiranno nelle epoche successive o in altri territori.

La differenza vinea-arbusta non era solo sociale, ripartita fra signori e coloni (vedete anche qui). In un'altra lettera Plinio sottolinea come fosse importante la diversificazione in agricoltura per essere sicuri di avere una rendita. Emerge quindi che la differenzazione in vinea, arbustum e campi era una strategia ben ponderata dei grandi proprietari, per non correre troppi rischi economici.

Il rapporto fra vinea e arbusta, in questo territorio e tanti altri dell'Italia, subirà nei secoli a venire oscillazioni altalenanti, senza che nessuno dei due sistemi scompaia mai del tutto (se non ai nostri giorni). La poca viticoltura dell'epoca Medievale, ristretta intorno ai borghi e portata anche dentro le mura di città e castelli, vedrà prevalere la vinea, più adatta ai piccoli spazi. In epoche successive, soprattutto dal XV-XVI sec., con la possibilità di tornare ai campi aperti, si ebbe il netto prevalere dell'arbusta, la vite maritata, e delle grandi estensioni di coltivazioni promiscue (come nell'immagine). Infine, la viticoltura contemporanea (dalla metà del Novecento circa), sempre più specializzata ed anche meccanizzata, ha portato all'assoluta affermazione della vinea e la definitiva scomparsa dell'antica cultura dell'arbustum, la vite maritata all'albero.[/info_box][/one_second]
La conoscenza, quindi, per Columella è essenziale ed è il motivo per cui ha sentito l'esigenza di scrivere il suo trattato, De Re rustica (60 o 65 d.C.). Sicuramente è la miglior fonte per capire com'era il lavoro del vignaiolo dell'epoca. Non è un'opera letteraria, ma un vero e proprio trattato tecnico. È talmente preciso, particolareggiato, con osservazioni razionali e da grande osservatore, da essere considerato il primo testo agronomico della storia, rimasto come riferimento fino alla fine del Diciottesimo secolo. Ciò non toglie che Columella rappresenta l'apice di conoscenze della sua epoca, un momento (come tanti nella storia) nel quale la conoscenza non era di certo diffusa in modo universale.
 Un aspetto generale e più pratico, che mi ha colpito leggendo dalla viticoltura romana, è che all'epoca avevano un numero incredibile di attrezzi agricoli, con tante funzioni specifiche, molti di più di quelli tradizionali nostri. Per i lavori di taglio in vigna c’era una falce usata solo per questo scopo, chiamata falx vineatica o vineatoria, il simbolo stesso del vignaiolo. Da questa è derivato il pennato, usato fino a tempi recenti in tutto il centro e sud d'Italia. Columella si raccomanda, per tutti i lavori di taglio, di fare sempre grande attenzione a non ferire troppo la vite, per evitare malattie e parassiti, come sappiamo bene anche oggi. Le ferite, consiglia, devono essere chiuse con mastice (resine di alberi) oppure terra umida mescolata con morchia.
Un aspetto generale e più pratico, che mi ha colpito leggendo dalla viticoltura romana, è che all'epoca avevano un numero incredibile di attrezzi agricoli, con tante funzioni specifiche, molti di più di quelli tradizionali nostri. Per i lavori di taglio in vigna c’era una falce usata solo per questo scopo, chiamata falx vineatica o vineatoria, il simbolo stesso del vignaiolo. Da questa è derivato il pennato, usato fino a tempi recenti in tutto il centro e sud d'Italia. Columella si raccomanda, per tutti i lavori di taglio, di fare sempre grande attenzione a non ferire troppo la vite, per evitare malattie e parassiti, come sappiamo bene anche oggi. Le ferite, consiglia, devono essere chiuse con mastice (resine di alberi) oppure terra umida mescolata con morchia.
Le vigne
Columella elenca i sistemi di coltivazione della sua epoca. Ho già parlato di alcuni di essi, ma vediamoli qui riassunti, come li raggruppa l'autore.
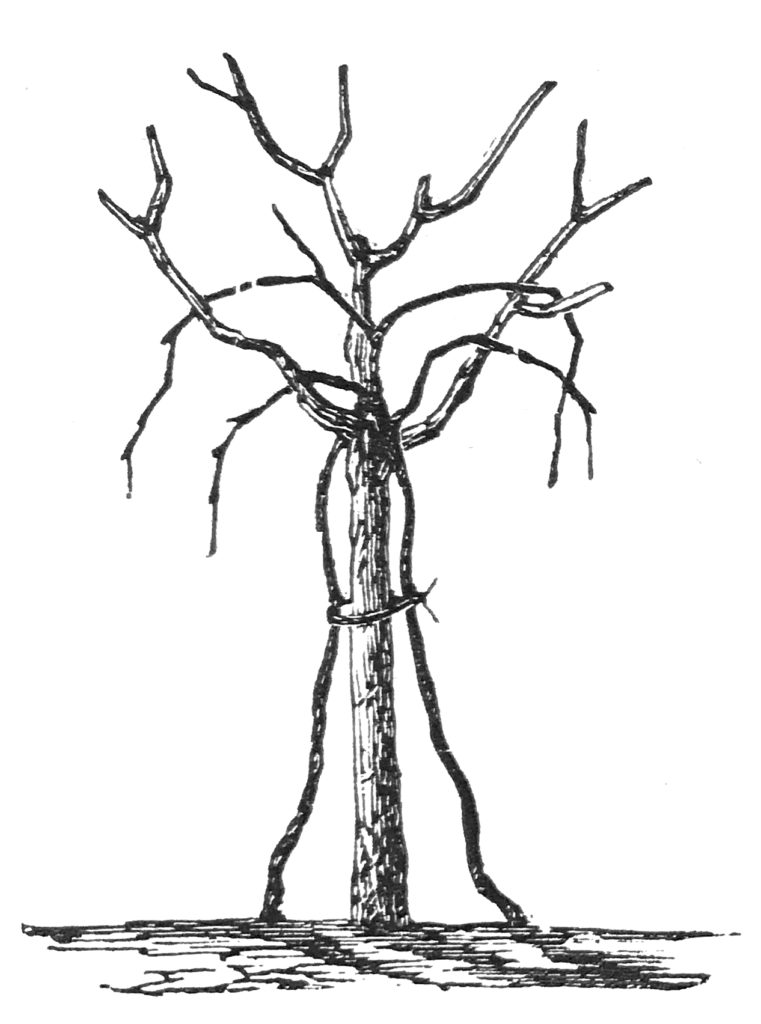
La vite maritata o alberata (arbustum) era il sistema tradizionale romano ed il più diffuso, di cui ho ampiamente già parlato in molti post precedenti, descrivendone l'origine e le peculiarità (qui, qui, e qui). Ricordo rapidamente le descrizioni che ne danno Plinio e Columella. L’arbustum poteva essere all’italiana (italicum), diffuso nell'Italia centrale, con le viti (in genere due) arrampicate su un singolo albero. Columella spiega che l'olmo è il preferito perché cresce bene in tanti tipi di suolo e le sue foglie sono molto adatte a foraggiare i buoi. Il pioppo non è molto gradito dagli animali ma è usato in alcuni territori (come la Campania, come noi sappiamo). Migliore è il frassino, che si usa nei terreni scoscesi e montani, non adatti all'olmo. Oltre tutto, le sue foglie sono ottime per capre e pecore. Catone citava anche il fico. In Etruria, patria originaria dell'arbustum, sappiamo che si usava principalmente l'acero.
Il secondo sistema è quello gallico (gallicum) o rumpotinum, presente soprattutto nell'Italia del Nord, nel quale i tralci di vite (detti traduces) passavano da albero ad albero. Si usano alberi non molto frondosi, fra cui l'olmo ben potato, l'acero, il corniolo, il carpino e l'orno. Il salice si utilizza solo nei terreni molto umidi. I tralci, se non riescono a raggiungersi fra albero ed albero, sono congiunti tramite una verga (pali orizzontali al suolo). Possono anche essere sorretti in mezzo da sostegni verticali.

Questi due sistemi sono rimasti in Italia fino a metà circa del Novecento.
Le viti aggiogate sono tutti i tipi di coltivazione in cui la vite era sorretta da supporti di varia natura, dal singolo palo alle strutture più complesse, fatte da pali, canne, corde e sarmenti. Il sistema a spalliera era detto jugatio directa. Da esso derivano tutti quelli moderni. Varrone dice che dà un ottimo vino perché le viti non si fanno ombra tra loro. C'erano poi sistemi particolari di alcuni territorio, come ad esempio la vite characata dell’Arpinate, dove la vite era circondata di canne, ogni ramo era appoggiato ad una di esse e i tralci erano piegati in circolo. Poi c’erano i pergolati, chiamati jugatio compluviata (dal nome dei compluvi delle case, nel disegno sotto), usati ancora oggi, con diverse modalità.

Columella dice che, fra le tante forme di viticoltura delle province, apprezza molto le viti ad alberello senza sostegno, che chiama “surrette”. Descrive anche la vite strisciante, “strata”: è un alberello con i tralci serpeggianti per terra. Columella dice che è usato in climi estremi. I tralci sono sovrapposti l’uno sull’altro per evitare che l’uva tocchi terra e possa marcire.
Siccome fra le viti era comune coltivare grano o altro, in genere si tendeva a lasciare spazi da due fino a dodici metri, per passarci agevolmente con l’aratro trainato dai buoi. Nelle vigne delle zone più impervie si stava più stretti, fino a un metro e mezzo, e i lavori si facevano con la zappa. Sia Columella che Plinio sostengono che l’impianto migliore delle vigne è quello a quinconce, come il numero 5 su un dado, utile per l’esposizione ma anche “perché offre un grato aspetto” (Plinio).
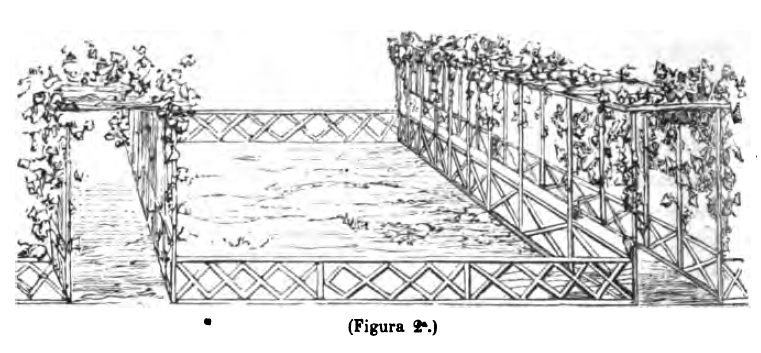
Gli animali erano considerati uno dei pericoli più grandi delle vigne, soprattutto quelli selvatici o le greggi sfuggite al controllo. Le vigne basse erano sempre recintate, soprattutto con siepi. Quelle alberate potevano essere lasciate aperte, con la possibilità anche di usarle per il pascolo, salvo vi fossero in mezzo altre colture da proteggere. I buoi, che trainavano l'aratro o il carro, erano dotati di museruole, altrimenti avrebbero mangiato i germogli e le tenere foglie della vite.
Propagazione della vite ed impianto
Una parte molto lunga e dettagliata del trattato di Columella è dedicata alla propagazione della vite, cioè l'accurata scelta, creazione e gestione della talea. La talea era chiamata malleolus (rimasto nel toscano di tempi più recenti come "magliuolo"), la barbatella da semenzaio viviradicem. Ricordiamoci che loro avevano la fortuna di poter coltivare la vite "franca di piede", cioè intera, non un innesto come dobbiamo fare oggi per colpa della fillossera.
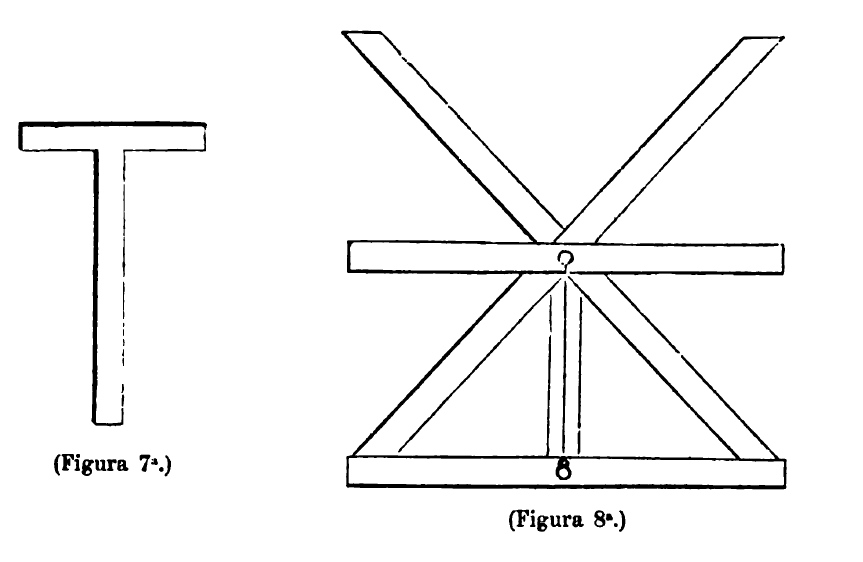
Lo scasso delle vigne era fatto in diversi modi. Il pastinatio, testimoniato dalle fonti scritte, consisteva nello zappare tutta la superficie, a circa 60-90 cm di profondità. Altri sistemi prevedevano invece solo lo scavo di lunghe strisce di terreno, dove si impiantavano le viti. A seconda del tipo di suolo si scavavano delle fossette, dette sulci, o delle trincee più profonde, dette scrobes. In alcuni siti archeologici sono state trovate tracce di questi scavi perché, in terreni vulcanici poco profondi, erano arrivati ad intaccare anche lo strato di tufo sottostante. Questi sistemi sono rimasti in Italia fino a tempi recenti, fino alla diffusione dei mezzi meccanici.
 In vigna si facevano anche diversi tipi di canalizzazioni, alcune per drenare l'acqua dai terreni più stagnanti, altre per l'irrigazione nei terreni più siccitosi.
In vigna si facevano anche diversi tipi di canalizzazioni, alcune per drenare l'acqua dai terreni più stagnanti, altre per l'irrigazione nei terreni più siccitosi.
Sul fondo della buca dell'impianto mettevano delle pietre, vinacce mescolate a letame, sia per nutrimento che per "riscaldare" le barbatelle. Poi riempivano le buche con la terra. Se il suolo era molto magro, si consigliava di aggiungere nella fossa anche terra grassa.
I magliuoli erano piantati ad entrambi i lati delle fosse, in modo che uscissero dalle parti opposte. Per piantare le giovani viti usavano il pastinum, un lungo bastone che finiva con due rebbi. In secoli più recenti si chiamerà trivella nel Lazio e gruccia in Toscana. Lo usiamo ancora oggi. Le vecchie viti sostituite erano dette ripastinate.
Le viti giovani erano fissate ad una canna perché crescessero diritte, per condurle poi alla forma di allevamento, come facciamo oggi. Soprattutto nel primo anno consigliano che siano ben seguite, irrigate se serve, accuratamente zappate e spampinate.

Potatura
Plinio racconta che fu all'epoca di re Numa che s'iniziò a potare le viti. Sembra che all'inizio i vignaioli fossero ritrosi a salire sugli alberi (la vite alberata, la forma originaria romana), che erano anche molto alti, per paura di cadere (“pericula arbusti”). Venne introdotta allora la pratica di garantire ai lavoratori delle vigne anche l’eventuale copertura delle spese funebri.
Parecchi secoli dopo Numa, Columella scrive, in modo molto moderno, che la potatura deve essere fatta con tre finalità: pensando alla produzione del frutto, scegliendo bene i migliori tralci, studiando di rendere la vite longeva. Per una potatura ottimale si deve ricordare la produzione dell’anno precedente di ogni pianta. Distingue e spiega la potatura lunga e quella corta, per le diverse forme di allevamento della vite. La vite strisciante invece ha solo una potatura molto corta. Lo sperone (il moncone che resta del tralcio dopo la potatura corta) lo chiama custodem, ma dice che è detto anche resecem o praesidiarium.
Lo sperone (il moncone che resta del tralcio dopo la potatura corta) lo chiama custodem, ma dice che è detto anche resecem o praesidiarium.
Columella dice che si può potare ad ottobre, dopo che le foglie sono cadute e sempre che i sarmenti siano ben maturi. Se l'inverno però è troppo freddo, meglio aspettare dopo la metà di febbraio (è corretto, perché alcune varietà sopportano male i geli invernali se sono già state potate). Comunque egli scrive che prima si pota e più si avrà legno, più tardi si pota e più si avrà frutto. In realtà oggi sappiamo che il tempo della potatura influisce soprattutto sul tempo di germogliamento primaverile della vite. Le potature troppo precoci fanno germogliare presto la vite, esponendola maggiormente ai rischi di gelate tardive. (... continua...)
Bibliografia:
"De re rustica", Lucio Giunio Moderato Columella (60-65 d.C.), tradotto da Giangirolamo Pagani, 1846 (preferisco le traduzioni dell'Ottocento perchè, avendo una viticoltura e tecniche di produzione del vino più simili a quelle antiche delle nostre, sanno spiegare meglio i concetti e trovare le parole giuste).
"Interventi di bonifica agraria nell'Italia romana", a cura d Lorenzo Quilici e Stefania Quilici Gigli, ed. L'Erma di Bretchneider, 1995.
"Storia dell'agricoltura italiana: l'età antica. Italia Romana" a cura di Gaetano Forni e Arnaldo Marcone, Edizioni Polistampa, 2002
"Le proprietà di Plinio il Giovane", V. A. Siragola, 1957
"Territorio e paesaggio dell'Alta Valle del Tevere in età Romana", Paolo Braconi, 2008, in F. Coarelli - H. Patterson (eds.) Mercator placidissimus. The Tiber Valley in Antiquity. New research in the upper and middle river valley, Atti del Convegno, Roma, British School at Rome, 27-28 febbraio 2004, Roma 2008, pp. 87-104
"La villa di Plinio il Giovane a San Giustino", Paolo Braconi, 2008, in F. Coarelli - H. Patterson (eds.) Mercator placidissimus. The Tiber Valley in Antiquity. New research in the upper and middle river valley, Atti del Convegno, Roma, British School at Rome, 27-28 febbraio 2004, Roma 2008, pp. 105-121
"La villa di Plinio il Giovane in Etruria, Giovanni Caselli,
“La viticoltura e l’enologia presso i Romani”, Luigi Manzi, 1883, .
“Storia della vite e del vino in Italia”, Dalmasso e Marescalchi, 1931-1933-1937, .
“Storia del paesaggio agrario italiano”, Emilio Sereni, 1961, .
“In vineis arbustisque. Il concetto di vigneto in età romana”, Paolo Braconi, Archeologia delle vite e del vino in Etruria" A. Ciacci - P. Rendini - F. Zifferero (eds.), Archeologia della vite e del vino in Etruria (Atti Scansano 9-10 settembre 2005), Siena 2012, pagg. 291-306.
“Catone e la viticoltura intensiva”, Paolo Braconi.
“Quando le cattedrali erano bianche”, Quaderni monotematici della rivista mantovagricoltura, il Grappello Ruberti nella storia della viticoltura mantovana, Attilio Scienza.
“Terra e produzione agraria in Italia nell’Evo Antico”, M. R. Caroselli.
Rinnovo nel nostro museo della vite e del vino
Questo tempo sospeso è l’ideale per sistemare la cantina, per essere ancora più belli ed accoglienti per quando potrete tornare da noi. Questi cartelli si erano rotti per il vento. Ne ho approfittato per rinnovarli.